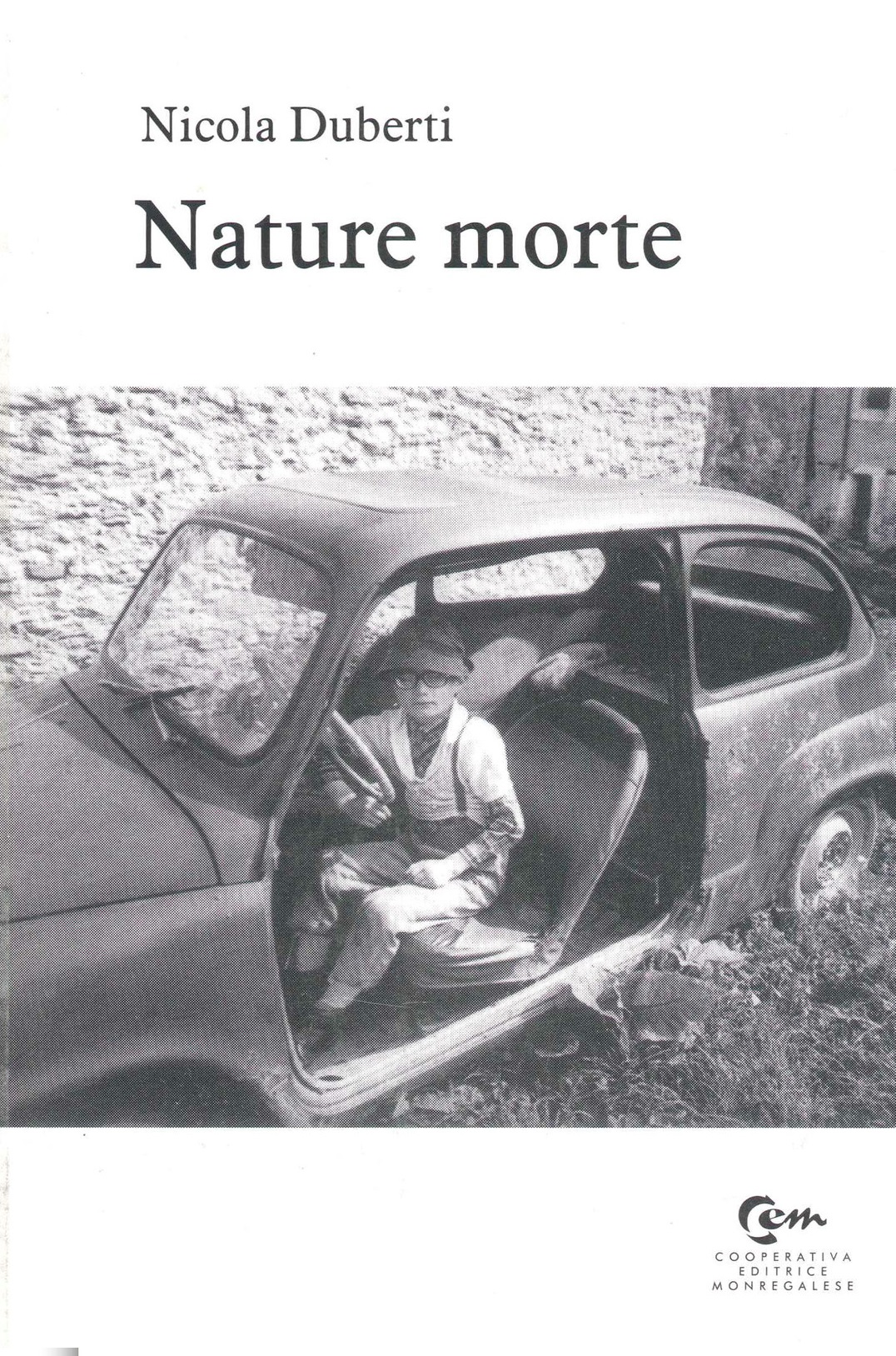LORENZO BARBERIS
Di recente, “La Stampa” torinese ha parlato del lavoro del linguista monregalese Nicola Duberti, che “Margutte” è orgogliosa di avere come collaboratore (vedi ad esempio qui). Abbiamo colto l’occasione per una intervista a Nicola per approfondire la sua ricerca linguistica tra teoria accademica e pratica poetica e letteraria. In calce all’intervista, una poesia dell’autore, che mostra perfettamente un aspetto del suo lavoro sulle contaminazioni di lingue differenti.
Di recente le tue ricerche hanno meritato (giustamente!) l’attenzione de La Stampa, nell’articolo “Il custode delle lingue dimenticate”. Puoi spiegare anche a Margutte di cosa si occupano le tue ricerche presso l’Università di Torino?
*All’Università di Torino io sono solo docente a contratto per un corso sperimentale di piemontese, che si configura come un laboratorio. Si tratta di un’esperienza molto interessante ma ovviamente provvisoria. Non sono strutturato nell’organigramma universitario. Tuttavia il rapporto con l’Università è fondamentale per riuscire a lavorare con serietà sugli argomenti che mi interessano, ossia le caratteristiche morfologiche e sintattiche delle varietà linguistiche piemontesi. In particolare, la mia tesi di dottorato si è incentrata su un argomento di sintassi, cioè le costruzioni causative, che poi sarebbero le frasi con fé e lassé. Sono costruzioni fraseologiche molto interessanti anche in italiano – ma capisco che detta così la cosa possa sembrare un po’ risibile. I linguisti trovano strane cose che per la gente comune sono del tutto normali. Ma il bello della scienza è proprio questa meraviglia. Anche l’italiano mi interessa: infatti durante il dottorato e subito dopo mi è capitato di lavorare su questioni riguardanti la lingua italiana, soprattutto in ambito didattico. In fondo il mio primo lavoro è sempre quello di insegnare italiano, storia e geografia ai ragazzini delle medie. Se vuoi sapere qualcosa di più specifico sul corso di piemontese che sto tenendo ora, sappi che per me è davvero molto bello: gli studenti non sono tanti, ma sono molto motivati e molto intelligenti. Non tutti provengono dal corso di laurea in Scienze Linguistiche: ci sono studenti di Filosofia, di Filologia e Letteratura, di Architettura, qualche volta di Giurisprudenza. Non tutti sanno già il piemontese. Anzi, alcuni non sono nemmeno italiani: ci sono due ragazze catalane della Comunitat Valenciana e ad alcune lezioni ha partecipato un ragazzo tedesco. Insegnare il piemontese non vuol dire chiudersi a riccio o riproporre vecchie storie piene di ragnatele. Al contrario è una fantastica occasione di apertura alla diversità, studiando insieme un codice linguistico molto affascinante. Anche studiare le piccole varietà locali, che rischiano di scomparire, vuol dire aprirsi a un confronto serrato con strutture morfologiche, sintattiche e fonologiche spesso piuttosto originali, che predispongono a capire meglio chi viene da lontano e porta con sé un plurilinguismo che la nostra società e la nostra scuola non sono ancora preparate ad affrontare con coraggio.
Il tuo rapporto con le lingue dimenticate non si limita allo studio teorico, ma si traspone anche nella tua attività poetica, con contaminazioni tra le varie tradizioni poetiche (penso, ma è solo un esempio, ai tuoi haiku in piemontese). Perché questa scelta, tutto sommato un po’ eclettica rispetto alla pura tradizione della lirica piemontese?
* Diciamo che l’uso poetico delle lingue marginali, nella mia storia individuale, viene prima dello studio teorico. In fondo mi sono avvicinato alla dialettologia da vecchio – a trent’anni suonati, cioè – dopo aver già pubblicato nel 1996 una raccolta di poesie in dialetto di Viola, Varsci. La mia formazione accademica era quella di un classicista, non di un dialettologo. Poi ho capito di essere un fallito come classicista – sostanzialmente perché trovavo quella formazione, che aveva prosciugato le migliori forze della mia giovinezza, assolutamente insignificante per dare un senso alla mia vita. Invece le varietà dialettali marginali delle nostre montagne, il violese e il kje in primo luogo, mi sembravano dense di misteriosi reconditi segnali capaci di garantirmi nientemeno che un contatto con il mondo dei morti. Forse c’era la voglia di continuare ad ascoltare la voce di mio padre, che era morto quando avevo quindici anni. Poi c’era il contatto diretto, fatto di letture e studio, con quella che tu chiami la pura tradizione della lirica piemontese: Nino Costa, Pinin Pacòt, Luigi Armando Olivero, ma soprattutto i nostri monregalesi, da Carlo Baretti a Remigio Bertolino, passando per Antonio Giordano, Carlo Regis, Ezio Briatore, Silvio Rinaudo – solo per citare quelli che hanno significato di più per me. Ma a questo proposito è necessaria una precisazione. Come hanno chiarito Giovanni Tesio e Riccardo Regis, la scuola poetica monregalese fin dagli anni Settanta del Novecento è stata fondamentale per spostare l’orientamento della produzione poetica piemontese dal centro (la koinè torinese) alla periferia linguistica: ebbene, quest’orientamento verso la periferia è già una scelta di contaminazione, poiché scegliere una varietà marginale di area monregalese significa implicitamente orientarsi verso il confine. Il confine fra piemontese e ligure, fra piemontese moderno e arcaico, fra pianura e montagna, forse addirittura – come si diceva nelle antiche vite dei trovatori riferendosi alle nostre zone – fra Lombardia e Provenza. E dire Provenza significa dire sole, musica, mare, Catalogna, Spagna, poesia del Novecento…
Non manca anche una tua produzione poetica in italiano, soprattutto “Il taccuino del barbiere chirurgo”. Cosa determina (se c’è un fattore) la scelta dell’italiano o del dialetto?
* Bella domanda. Non so rispondere, però. Io ho un rapporto difficile con l’italiano, è una lingua che mi ha sempre intimorito. Mi sento inadeguato, spesso respinto, da questa lingua con le parole troppo lunghe e troppo musicali. E poi alcune memorie, alcune immagini, certi segni di luce e di ombra sono indecifrabili se non in piemontese. E tuttavia, il piemontese per me necessita di traduzione. L’italiano è la cartina di tornasole: se la poesia resta bella anche tradotta in italiano (o in inglese, ma lo conosco troppo poco), allora la tengo e appena posso la pubblico. Altrimenti la lascio morire, non vale la pena illuderla. Va da sé che in questo modo l’italiano intride i miei pensieri. Così qualche volta le immagini e le idee si distillano in questa lingua, anche se io non vorrei. Del resto, all’Università per ragioni di studio mi è capitato di dovere leggere integralmente numerose opere di poeti italiani contemporanei. La loro lingua ha modellato, anche contro la mia volontà, il mio modo di intendere la sensibilità ritmica. Un poeta è ciò che legge, ma soprattutto la lingua in cui legge. E io, purtroppo, leggo quasi solo in italiano.
“Nature morte”, il tuo romanzo, è anch’esso in italiano (anche se già il titolo gioca sull’ambiguità linguistica, leggibile in italiano e in francese…) ma tratta, in chiave narrativa, del tema delle lingue e delle identità ad esse connesse. La struttura “a frammento” gli dà un taglio molto postmoderno che personalmente ho molto apprezzato (credo che sia l’unico romanzo postmoderno del monregalese, con l’eccezione forse di Silvano Gregoli e del suo Xeno). Quale la ragione di tale scelta?
* Prima di tutto un’osservazione: sei un genio. Io non avevo mai pensato che “Nature Morte” si potesse leggere anche in francese, davvero. O forse ci avevo pensato a suo tempo e ora me n’ero dimenticato. Ma adesso che ci penso seriamente, mi sembra una roba bellissima! Comunque sì, anche io credo sia un romanzo postmoderno. Nasce, come la passione per la linguistica, dalla consapevolezza di un fallimento. Mi piacerebbe essere in grado di scrivere articolati romanzi di successo, alla Wilbur Smith o alla Stephen King, ma non ci riesco. Do allora la colpa alla lingua, cioè all’italiano, e mi assolvo dalla mia inadeguatezza. Però la voglia di scrivere mi resta lo stesso – il dramma della vocazione senza talento! – e allora inizia il grande gioco del taglia e incolla. Un taglia e incolla tutto interiore, al termine del quale ho inciso fantastici omini di carta nelle mie memorie, nei miei dolori, nei miei sogni. Poi li metto insieme con un lungo lavoro di riscrittura che da fuori non si vede. E viene fuori questo romanzo-non romanzo a cui sono davvero legatissimo.
“Stermato”, il paese immaginario (che in un piemontese italianizzato richiama “nascosto”) al centro del tuo “Nature morte” è tornato anche in un feuilletton monregalese in cui narravi le cronache di Stermato e l’avanzata di un abile politico locale che riusciva infine a promuovere la secessione del paese. Una connotazione che potrebbe sembrare anche di satira o comunque di riflessione sulla politica e sull’identità. Cosa succede oggi a Stermato?
A Stermato succedono cose terribili, ma nessuno per ora se ne accorge. Poi magari basta un elemento insignificante e tutto si rivela ineluttabilmente nello splendore della sua tragicità. Quidquid latet apparebit, come recita il Dies Irae. Ma non oggi. Bisogna ancora aspettare un po’…
*
Ringraziamo di cuore Nicola per la sua disponibilità, e vi lasciamo con questa sua lirica (sotto vi è la traduzione in italiano, dell’autore stesso).
Pentecòste d’otonn
Me nóna ch’i parlòva ’dmâ dë Viora
veja veja.
La stiva ch’i tramblòva.
O nóno (nent ëmsé)
oj quentòva le quénte calabrèse.
«A fímmina ci dissi a lu dimoniu…».
La stiva ch’i tramblòva.
O nóno ch’o sognòva
le frome e ij pummadori.
Pummadori, tomâte. Le castâgne
rustívõ su la sciâma ch’i parlòva
calabrès e dë Viora.
I era l’ùrtima dmora.
*
Pentecoste d’autunno
Mia nonna che parlava solamente il dialetto di Viola
Vecchia vecchia.
La stufa troppo accesa.
Il nonno (non vero nonno)
le raccontava storie calabresi.
«A fímmina ci dissi a lu dimoniu…».
La stufa troppo accesa.
Il nonno che sognava
le donne e i pummadori.
Pummadori, pomi d’oro. Le castagne
arrostivano al fuoco che parlava
il calabrese e il dialetto di Viola.
Era l’ultima veglia. Ed era un gioco.