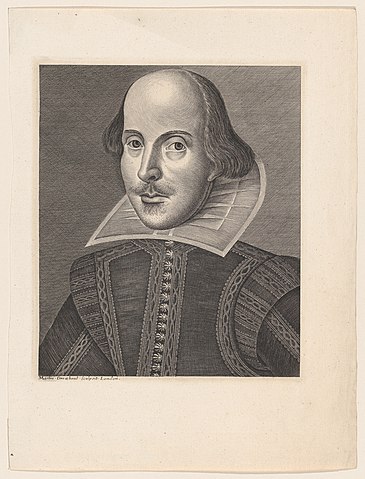GABRIEL JIMÉNEZ EMÁN
Mi chiamo William Shakespeare e scrivo e allestisco opere teatrali. Più che drammaturgo, chiaro, sono attore e direttore di scena nella compagnia di teatro Il Globo, le cui opere godono del plauso generale. Di seguito, narrerò un fatto che ha cambiato completamente la mia vita. Una sera sedevo al tavolo di una taverna correggendo un pezzo teatrale, quando arrivò il mio amico Christopher con un gruppo di beoni che, oltre a trincare copiosamente facendo chiasso e a interrompere il mio lavoro, presero a cantare a voce alta e a ballare con alcune donne. A un certo punto, esausti, si stancarono e sedettero a un altro tavolo. Mi avvicinai a salutarli e dopo poco Christopher mi chiamò in disparte per farmi i complimenti in merito a un pezzo teatrale che avevo ultimato e mi invitò a leggere quello che aveva con sé, dicendo che l’autore gli era sconosciuto. Mi consegnò il manoscritto con molta attenzione; me lo misi nella bisaccia, lo portai a casa e durante la notte lo lessi. Trattavasi di uno dei pezzi teatrali più affascinanti che avessi mai letto. Trascorsi l’alba chiedendomi chi potesse essere quel genio.
Il giorno dopo mi recai a casa di Christopher con l’intento di saperne di più sulla paternità del pezzo e lui mi rispose che lo aveva ricevuto in quel modo dalle mani del conte di Southampton, amico di corte e appassionato di teatro, ma che ignorava se ne fosse anche l’autore.
Giorni dopo cercai un pretesto per avvicinarmi al Conte, cosa difficile trattandosi di un nobile, però lo conoscevo di vista e ottenni, dopo molti sforzi, un colloquio con lui. Gli chiesi l’origine di quel manoscritto e mi rispose che non lo sapeva: l’aveva ricevuto dalle mani del messaggero dell’ anonimo autore, che ce lo aveva inviato con l’intento di farlo rappresentare in qualche teatro della città diretto da Christopher o da me nel teatro Il Globo, compagnia in cui lavoro con un gruppo di attori straordinari. Gli dissi che ero rimasto colpito dal pezzo e che se mi avesse autorizzato, l’avrei allestito per la stagione successiva. Il Conte mi concesse di trattare e lo sottoposi a uno dei miei soci principali del teatro Il Globo, il signor Fletcher, che dopo averla letta mi spinse subito a dirigerla.
La commedia fu un gran successo e gli spettatori ridevano a crepapelle. In primavera venne recitata in varie zone di Londra, con un pubblico variegato che includeva anche nobili. Si sparse addirittura la voce che la regina in persona volesse assistervi, ragion per cui gli attori erano assai motivati. Trascorsi giornate intere a chiedermi con ansia chi potesse essere l’autore e non avrei preso pace finché non lo avessi scoperto. Tediai all’inverosimile il mio caro amico Chistopher Marlowe – a mio avviso il miglior drammaturgo inglese – ma non mi diede mai una risposta soddisfacente (mi parve persino che Chris stesse prendendomi un bel po’ in giro, che l’autore fosse lui e volesse divertirsi un po’) finché un giorno, in una taverna, sempre tra birbanti alticci e donnine allegre, mi parlò del poeta Benjamin Jonson, di cui aveva letto le opere, restando impressionato dalla sua vena satirica; riconosco nelle sue commedie una gran forza argomentativa, così come un talento nell’allestire masquerades e nel comporre poesie assai originali, ma questa era un’altra storia. Christopher mi riferì che Ben aveva preso parte alla guerra contro gli spagnoli e mi sembrarono così interessanti la sua vita e il modo d’essere che, nei mesi successivi, lo avvicinai. Tra noi nacque una salda amicizia che ci portò a reciproche confidenze. Un giorno gli chiesi se, per caso, avesse scritto lui un pezzo sul soggetto in questione e gli mostrai il manoscritto al fine di accertare la sua responsabilità; assorto e sconcertato mi rispose di no, dicendomi che in quei giorni era immerso nel comporre poesie e che si trovava nel mezzo di una crisi amorosa con una dama di compagnia che lo aveva lasciato, confessandomi, peraltro, che si era messo nei guai con alcuni creditori.
Non essendo venuto a capo di nulla, allora, me ne andai al colmo dell’agitazione per non aver potuto rendere giustizia all’autore di quell’opera geniale. Un giorno, del tutto inaspettatamente, si presentò a casa mia Ben Jonson, molto alterato, per dirmi che era in rovina, che sapeva chi era l’autore di quell’opera scritta su incarico per il Conte ma che aveva promesso di non rivelare mai quel nome in cambio di una considerevole somma di denaro. Mi parlò arrossendo, e quasi con riluttanza, di un certo Joseph Hall, poeta, che viveva da tempo isolato in un sobborgo di Londra. La mia curiosità divenne emozione una volta fornitomi quel particolare. Quando mi fornì l’indirizzo, gratificai Ben con una cospicua somma di denaro. Di buon mattino, il giorno dopo, mi diressi là.
Si aprì la porta di una misera pensione. Mi stava di fronte un uomo barbuto, magrissimo e mal vestito, ma d’aspetto nobile e dagli occhi vivaci. Mi fissò, chiese il mio nome e, quando lo dissi, mi invitò immediatamente a entrare. In quella stanza cadente c’erano una branda, una stufa, una rustica scrivania di legno piena di libri e manoscritti sparpagliati; alcuni stavano sul pavimento, accanto a bottiglie vuote, pezzi di pane e avanzi di cibo. Accatastati su un palchetto manoscritti nati dalla sua penna da svariati anni, a quanto mi disse da lui continuamente rimaneggiati, alla ricerca della perfezione espressiva e del loro significato più profondo. Quel poeta pallido, mal vestito, consunto suscitò la mia pietà. Mi mostrò alcune sue poesie la cui qualità era sublime; non avevo mai letto nulla di così autentico, nobile e dotato di un’ispirazione così elevata e di una siffatta perfezione formale. Man mano che i miei occhi scorrevano quelle pagine, il mio stupore si trasformò in estasi. Turbato, gli manifestai tutta la mia ammirazione.
Lo invitai a mangiare e bere qualcosa; si lavò il viso con l’acqua di un secchio e mi disse che usciva di rado, che soffriva di uno strano male, una specie di fobia che gli impediva di viaggiare e muoversi in grandi spazi, a stento passeggiava per gli isolati vicino casa o sedeva nelle piazze dei dintorni a leggere o contemplare gli alberi, i fiori , i passeri. Però accettò il mio invito a mangiare in una locanda vicina.
Mentre pranzavamo gli chiesi se fosse stato a teatro ultimamente per vedere le sue opere rappresentate e mi rispose di no, mi ripeté che non andava a teatro da anni a causa della sua infermità. Man mano che proseguivamo la conversazione, cresceva in entrambi una sorta di complicità difficile da spiegare. Trascorro molto tempo, mi disse, scrivendo tragedie, poesie, farse e commedie che conservo in un vecchio scaffale e che vengono lette quasi esclusivamente da Christopher e da una letterata di nome Fanny, che amo, e che fa brillanti osservazioni sulle opere. Poi le consegno quasi tutte a Marlowe in cambio di cibo, buon vino e l’affitto di questa umile pensione; lui, poi, le porta al Conte di Southampton.
Mi blocca, come le ho detto, un tremendo disturbo mentale, una specie di panico che mi impedisce di allontanarmi dallo spazio di questi sordidi quartieri.
Dopo aver mangiato e bevuto, il suo volto si illuminò e mi sentii orgoglioso di avergli fatto compagnia. Mi prese per il braccio e mi condusse fuori, per strada. Aveva un’aria sofferente e la voce tremula. Finalmente mi confessò:
Devo dirti una cosa, caro William. Sono molto contento che alla fine sei venuto da me. Non mi chiamo Joseph Hall, quello è il falso nome che ho dato agli altri per proteggerti, bensì Edward Shakespeare, tuo fratello maggiore, quello che la famiglia credeva morto. Da oggi puoi disporre di tutte le opere che ho scritto per rappresentarle al teatro Il Globo. Sono felice, William. Alla fine si è compiuto il mio destino.
Traduzione di Giuliana Manfredi.
In Margutte: La mano di Cervantes