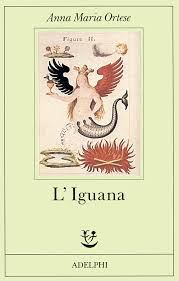GABRIELLA VERGARI.
Mai letto un libro così, a parte forse La nube purpurea (The Purple Cloud) di M. Ph. Shiel (1901).
Non mi è perciò venuto difficile credere alla stessa Anna Maria Ortese, una delle voci più complesse e interessanti della letteratura novecentesca – non solo femminile –, che all’epoca (1965) ebbe a definire questa sua prova una sfida. Altro che!
C’è molto dolore nel mondo, sostiene la scrittrice in Corpo Celeste (Adelphi, 1997), perché l’irreale – il non conosciuto – è assai più profondo. Mille ragioni, di Stato o pratiche, vi si oppongono. Non per malvagità, ma perché a quelle condizioni che mantengono il disordine su cui cresce il dolore, sono legati innumerevoli interessi, anche di cultura o vecchia cultura; quindi di autorità…
Affermazioni che, certo, supportano, e tanto, nella comprensione del romanzo ma che pure la appianano solo in parte, dato che, a lettura completata, si intuisce che ne L’Iguana c’è molto altro e di più.
La solitudine, ad esempio, che in un’intervista all’autrice – inserita a mo’ di postfazione nell’edizione Adelphi del 1986 – Pietro Citati definisce “profonda e disperata: la solitudine senza gesto e senza parola dell’animale condannato, che si chiude nella sua tana e non vorrebbe più uscirne; la solitudine di Kafka”.
Estrellita, ovvero appunto l’iguana che dà il titolo al testo, ne è la perfetta incarnazione.
Appare, poco dopo lo sbarco di Daddo – al secolo Don Carlo Ludovico Aleardo di Grees, dei Duchi di Estremadura-Aleardi, conte di Milano – sulla minuscola Ocaña e il successivo suo incontro con don Ilario Jimenez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, unico abitante dell’isola, insieme ai due fratelli.
Grande, a questo punto, fu la sorpresa del Daddo, nell’accorgersi che quella che egli aveva preso per una vecchia, altri non era che una bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall’apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori, giacché era la somma evidente di tutti i cenci della famiglia. In testa, a nascondere l’ingenuo muso verdebianco, quella servente portava una pezzuola anche scura. Era scalza. E sembrava, benché quelle vesti, dovute a uno spirito puritano dei padroni, la impacciassero non poco, adatta a svolgere tutti i mestieri con una certa sveltezza.
In quel momento, però, sembrava proprio non farcela. Una delle sue verdi zampette era fasciata, e con l’altra, sospirando intensamente, essa si sforzava invano di tirare su dal pozzo un grosso secchio.
Sono proprio queste notazioni, la fatica e la zampetta fasciata, a lasciar a parer mio scoccare, nel lettore, la freccia della compassione. Di sicuro essa centra appieno il Conte, il quale subito si precipita in aiuto della bestiola che, in contraccambio, gli rivolge due occhietti supplichevoli e fantasticanti, destinati a segnare, da qui in avanti, il destino del giovane.
Sintetizza infatti l’autrice (vd. ancora Corpo Celeste, passim): “…Un brav’uomo va in un’isola – è molto ricco e può andare dovunque – e conosce un mostro. Lo prende come cosa possibile, e vorrebbe reintegrarlo – suppone ci sia stata una caduta – nella società umana, anzi borghese, che ritiene il colmo della virtù. Ma si è sbagliato: perché il mostro è un vero mostro anzi esprime l’animo puro e profondo dell’Universo di cui il signore non sa più nulla, tranne che è merce.”
Ecco, è in questo errore di valutazione che può verosimilmente riassumersi tutto il travaglio e l’angoscia del personaggio, al punto da condurlo in breve tempo alla morte. A nulla varranno perciò i moniti che gli verranno rivolti – fino all’ultimo quello, ad esempio, di Cole che, meravigliato e con una sorta di premura premonitrice, lo esorterà a scostarsi dal pozzo dentro il quale potrebbe cadere: la sua sorte resta segnata. Nei momenti che precedono la sua fine, lo troviamo non a caso quasi colto dal delirio, mentre aggrottando la fronte per il lieve sforzo che, ogni tanto, gli veniva dal ricordare, come dal prendere atto di questi mutamenti, e distinguere fra queste continue sovrapposizioni di reale e irreale, invita Ilario a temere del suo stesso animo, come io del mio. Vi è qualcosa che ignoriamo, che non vogliamo sapere, vi è qualcuno, nascosto, che c’impedisce di guardare… Vi è un inganno a danno di persone deboli… Vi è, nella nostra educazione, qualche errore di base, che costa strazio a molti […] La sua sarà perciò una specie di katabasis, che coerentemente si compirà all’interno di un pozzo, dentro al quale egli non sarà in grado né di lucidamente guardare, né di distinguere tra realtà e apparenza. Ma pure da tutto ciò ricaverà una particolare bellezza, non forse catartica né tale da ricomporre del tutto la sofferenza sperimentata, eppure a suo modo chiara e perfino meravigliosa. Mai il conte era stato più calmo e bello […] ma vi era in più, nel suo volto bianco e affinato, un che di cupo, come l’ombra di ciò che il nobile aveva patito negli ultimi due giorni della sua esistenza, quando il presentimento del male e il dubbio sui veri colpevoli lo attanagliavano, quell’ombra ancora lo perseguisse. Ora, tutto era chiarito, ma dal suo ricordo, forse, quel velo che, più leggero di un fiato, andava e veniva sulla sensibile fronte […]; mentre del chiaro sorriso che rialzava appena le sue labbra, il meraviglioso sorriso di coloro che hanno da poco superato la minore delle due prove (l’altra è la vita), non sembrava esservi ragione. Quel sorriso, che turbò tutti, e li rese partecipi di non so che altezza di questo mondo, che pure si crede merce o altro, all’alba finì.
Non così però il romanzo che prosegue, nell’ultimo capitolo, il XXIV, con una serie di lettere da Ocaña, in virtù delle quali qualche critico ha perfino ipotizzato un possibile lieto fine, forse poco convenzionale ma in fondo coerente con l’andamento del reale, che spesso alterna, alla tempesta, il sereno, prospettandosi mutevole come il mare e sostanzialmente impermanente.
Padrona della scena fino all’ultimo, l’iguana, definita in conclusione una certa personcina, nel tentativo di farla emergere nella piena essenza dell’inumana profondità del suo cuore. Compito peraltro quasi impossibile e precluso ai più, soprattutto se accecati, come “l’arcivescovo nero”, dall’intransigenza religiosa (al limite del fanatismo) o, come la famiglia Hopins, dalle solide e prosaiche ragioni di un materialismo yankee della “più bell’acqua”, come si suol dire.
Compito però arduo anche per il più onesto dei lettori, che si trova a fare i conti con un testo assolutamente complesso, pur se indiscutibilmente affascinante, dalla trama imprevedibile, e continuamente aperta alle variazioni di quello che qualcuno ha definito una scatola cinese.
Non manca nemmeno un memorabile processo all’uccisore di Dio.
« Si introduca la Vittima» disse il Giudice.
E si alzò in piedi lui stesso, e tutta la sala si alzò piangendo e tremando.
Entrarono due uomini spingendo un carrello bianco, e sul carrello era deposto l’Altissimo.
Era, Lettore, se mai sei stato desideroso di conoscere le vere sembianze di colui del quale favoleggiamo da secoli, senza mai essere certi di averlo ravvisato, era, arrampicata e addormita su una foglia, una semplice farfalla bianca.
Ḕ indubbio, lo scrive anche P. Citati, che un evento destabilizzante come l’uccisione di Dio getti un inarrestabile fondo di tenebra nel mondo, e di decadenza: “tutte le case e i palazzi che l’Ortese descrive sono pieni di crepe, di stracci e di polvere, e gli alberi sono corrosi e moribondi.[…] Eppure L’Iguana è un libro chiaro e scintillante […] che dissolve il dolore in grazia e leggerezza. Mai l’Ortese dimentica quello che è il dono supremo del romanziere: il piacere di raccontare, di trasformare e sciogliere le vicende”.
Un piacere tutto da cogliere e scoprire per quei lettori che – proprio come il critico ancora proclama dal risvolto di copertina – “desiderino qualcosa che li porti di colpo oltre i confini della realtà”, se da autentici happy few sapranno alzare il velo grigio, scorgendo la bellezza della principessa della fiaba dietro la cenere e i cenci.
Che altro antidoto si può del resto trovare a quella che l’Ortese stessa definisce la moderna virtù del nulla? Nell’intervista rilasciata nel 1977 a Dario Bellezza, la scrittrice descrive, senza mezzi termini, una situazione sventuratamente tuttora attuale: “Più una cosa è nulla, o male addirittura, più è vanificante o vanificata – più viene accettata e celebrata. Sembra uno scherzo, dapprima: poi, a poco a poco, ti convinci che è una realtà (sebbene dell’irreale, cioè del nulla). Ma questo gran giocare e inchinarsi delle società moderne intorno a uomini da nulla, opere da nulla, cose da nulla (che spesso, come il cavallo del mito, trasportano crimine, e là dentro si sente cantare e ridere in vista della città dell’uomo che sta per essere saccheggiata), questa cosa tiene desti: come un incanto, un prodigio.”
Ovvero, detto in altri termini, come non perdere l’uomo?
“Quando per esempio dai il mondo come inspiegabile, cioè innaturale, e lo definisci visione del fuggevole, ci edifichi l’uomo […] Edificare l’uomo è gratuito. Edificare le cose (dell’uomo e sull’uomo) porta compensi molto alti, non solo economici. Ma perde l’uomo” (da Corpo Celeste)
Una grande lezione, oggi più che mai tutta da meditare, pena la perdita della scommessa d’ogni possibile Paradiso.