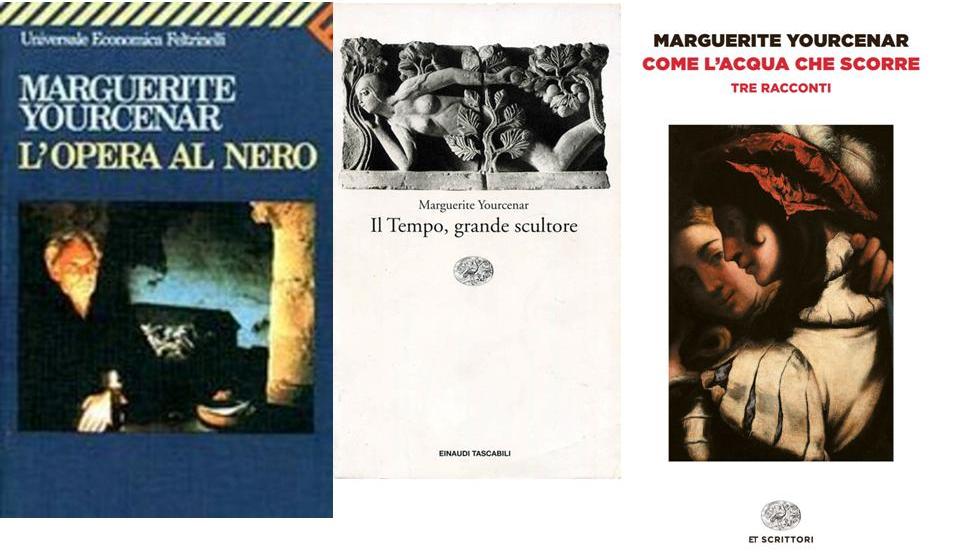
GABRIELLA MONGARDI.
Trent’anni fa, il 17 dicembre 1987 – dopo una vita nomade sia per scelta che per cause di forza maggiore – moriva a Mount Desert, nel Maine, Marguerite Yourcenar, nata a Bruxelles nel 1903. Anche se l’opera più famosa della Yourcenar è indubbiamente il romanzo Memorie di Adriano (1951), preferisco ricordarla qui attraverso l’altro suo grande romanzo, L’opera al nero, la raccolta di saggi Il Tempo, grande scultore e i racconti di Come l’acqua che scorre.
L’Opera al nero (1968) racconta la storia di un uomo del Cinquecento, Zenone, medico, alchimista, filosofo, dalla nascita illegittima a Bruges fino a quando, imprigionato con l’accusa di eresia e pratiche illecite, preferisce darsi da sé la morte anziché aspettare il carnefice. Zenone viaggia per l’Europa e il Levante, esercita la medicina tanto al capezzale degli appestati quanto presso i sovrani, si dedica a ricerche in anticipo sulla scienza ufficiale del tempo: realizza di fatto l’uomo ideale del De dignitate hominis di Pico della Mirandola, considerato la summa dell’antropocentrismo rinascimentale. Il personaggio di Zenone vuole incarnare un tipico esponente di questa civiltà, è costruito con ‘tasselli’ veri, ha qualche tratto di vari filosofi e scienziati cinquecenteschi – Erasmo da Rotterdam, Paracelso, Michele Serveto, Leonardo, Campanella, come ci indica la stessa scrittrice, ma – a differenza di Adriano – non è un personaggio storico, realmente esistito. Abita anche lui – come l’imperatore Adriano – una di quelle età di passaggio che Marguerite Yourcenar predilige, perché sono sede di trasformazioni profonde e violente: «Era una di quelle epoche in cui la ragione umana si trova presa in un cerchio di fuoco». Anche lui – come Adriano – è amato dall’autrice di un amore che rischierebbe di essere troppo forte, se non diventasse un amore “universale” verso la Vita, di cui la creatura che ha di fronte non è che un’emanazione. Questa è, a mio avviso, la chiave di lettura per capire l’Opera al nero: non considerarlo tanto un romanzo storico, bensì “la storia anonima di ognuno”. L’uomo è l’interesse costante di Marguerite Yourcenar: e l’uomo a cui lei offre la propria scrittura come luogo in cui possa consistere si definisce soprattutto in rapporto al pensiero della propria morte, nel prepararsi ad essa. Il motto alchimistico Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius segnala appunto, nel protagonista, questa disponibilità a esplorare qualunque aspetto della vita, inclusa la morte: così la morte stessa, non più via d’uscita dalla vita, ne diventa l’omaggio estremo, l’ultima folle avventura. Così, prigioniero in attesa di condanna, Zenone sceglierà ciò che rimane all’uomo da scegliere, l’ora e il luogo e il modo della sua morte, sperimentando in sé quello che gli alchimisti chiamavano l’opera al nero, o almeno la separazione della materia. Zenone capisce che ciò che lo condanna a morire non è l’eresia, una chiacchiera del secolo intorno ai dogmi religiosi: ciò che lo condanna è la vita stessa. Zenone non crede – e nemmeno l’autrice – che possa esistere un ‘luogo’ che ci attende oltre la morte: ma questo non li porta a rendersi complici di quel nemico; anzi, si assumono la responsabilità della morte, sanno che tutta la vita prende senso come risposta ad essa. La scrittura per Marguerite Yourcenar ha senso per questo: solo se avrà «il coraggio di guardare in faccia la morte», la scrittura sarà un’azione propriamente e degnamente umana. Lo scrittore – come il folle, e il santo – troverà per l’uomo un accesso almeno a una verità: e restituirà in parole all’uomo la sua stessa vita, di cui costantemente il tempo lo deruba.
Ma il tempo per Marguerite Yourcenar non è solo ladro, è anche «grande scultore»: è questo il titolo di una raccolta di diciotto saggi, variamente datati, pubblicata nel 1983. Marguerite Yourcenar saggista – che si occupi di arte o di storia, di India o di Medioevo, di donne o di animali da pelliccia o di suicidio – non esibisce mai un’erudizione fine a se stessa, che rischierebbe di schiacciare il lettore col suo peso, ma la fa lievitare con l’intensità di osservazione e la sensibilità morale che le sono proprie. Ad esempio, il saggio che dà il titolo all’opera e ne indica il più o meno sotterraneo filo conduttore, il quarto, parla di arte, segnatamente degli effetti che lo scorrere del tempo ha prodotto sulla statuaria antica: ma la voce della Yourcenar è quella di chi accetta che anche l’opera d’arte, come tutto ciò che è umano, sia soggetta al tempo, alla metamorfosi, sia esposta alla rovina e alla fine, abbia una durata limitata, per quanto infinitamente più lunga della vita umana: bisogna accettare di essere scolpiti, segnati dal Tempo. È questo l’insegnamento che ci viene dato anche nel secondo saggio, intitolato Sistina, uno dei vertici dell’arte di Marguerite Yourcenar, un testo sublime, che dà i brividi… Nonostante il titolo, non è un’analisi degli affreschi della cappella Sistina, e Michelangelo, tagliapietre, non è che una delle voci che si affacciano alla ribalta di queste pagine, che solo per comodità, per mancanza di un termine più adeguato si possono definire “un saggio”, ma che forse sarebbe più giusto assimilare ad un abbozzo di copione teatrale. Lo scritto infatti è articolato in quattro parti, ciascuna contraddistinta da un nome di persona, come ad indicare colui a cui tocca recitare quel pezzo – sono allievi o modelli di Michelangelo, i cui volti sono stati da lui immortalati appunto nelle figure dipinte nella cappella Sistina. Il primo personaggio, Gherardo Perini, si limita a riferire le parole che il Maestro gli ha detto al momento del congedo, sicché noi attraverso la voce di Gherardo sentiamo in realtà Michelangelo parlare di arte e di vita, di donne di pietra e di carne, di bellezza e di separazioni. Il secondo personaggio, Tommai dei Cavalieri, in un breve intervento commenta il ritratto che di lui ha fatto Michelangelo, per rivendicare la superiorità della vita, dell’uomo vero, sull’immagine disegnata: «Io mi sono scolpito prima che egli mi scolpisse. Che fare? A quale dio, a quale eroe, a quale donna dedicherò questo capolavoro: me stesso?», ma poi conclude: «Gli uomini, di fronte alla mia immagine, non si chiederanno chi fui, che cosa feci: mi loderanno di essere stato», riconoscendo implicitamente la superiorità dell’essere sul fare, dell’arte sulla vita. Nel terzo pezzo è Michelangelo in persona a meditare su una delle figure da lui disegnate sulla volta della Sistina: quella di un giovane, morto, il cui nome, Cecchino dei Bracchi, funge da titolo. La morte è il principale oggetto delle riflessioni di Michelangelo, che delinea una sorta di autobiografia spirituale alla luce dei suoi rapporti con la morte, vissuta attraverso la morte delle persone amate. Anzi Michelangelo stabilisce un nesso strettissimo tra amore e morte: «Amiamo, perché non siamo capaci di sopportare di essere soli. Ed è per la stessa ragione che abbiamo paura della morte», ma poi in lui è lo sguardo dell’artista, dello scultore, a prevalere, e anziché guardare la morte in astratto guarda i morti, come statue finalmente compiute, in cui la bellezza, che la vita aveva sminuzzato in tante espressioni o movimenti, torna intatta, assoluta, eterna. «Era perfetto come quelli che niente può toccare, poiché i morti sono tutti impassibili. I morti riposano, appagati, in una certezza che niente può distruggere, in quanto essa stessa si annulla man mano che si compie». Con un forte effetto di chiaroscuro, la quarta parte, brevissima, affidata ad un personaggio solare fin dal nome, Febo del Poggio, ci fa sentire la voce di una giovinezza che accetta l’esistenza nel suo fluire alterno di aurore e tramonti in modo istintivo, senza pensare a niente.
L’impressionante brevità della vita, sullo sfondo del tempo infinito che si spalanca prima della nostra nascita e dopo la nostra morte, è il tema anche del primo saggio, che ricorda una struggente similitudine – cara anche a Borges – citata dal Venerabile Beda nella sua “Storia d’Inghilterra”. Il trittico delle Elegie sepolcrali (in francese: Tombeau) chiude infine il volume ancora nel segno della morte, la fine del ‘nostro’ tempo: non sono testi in versi (a dispetto del titolo italiano), ma recensioni o ritratti in memoria di scrittori defunti. Inconsueta è la forma del penultimo saggio, Scritto in un giardino: non un discorso sistematico, ma meditazioni sparse, affidate a brevi frasi, aventi come oggetto i quattro elementi – acqua, terra, aria, fuoco – e in particolare l’acqua, «l’acqua che per sua natura cede e discende, e questo spiega perché le si addica l’epiteto francescano di umile», l’acqua che cola – e che dà il titolo, molto suggestivo, all’ultima opera di Marguerite Yourcenar di cui vorrei parlare, Comme l’eau qui coule (1981).
Il titolo italiano Come l’acqua che scorre perde qualcosa del francese coule, che vuol dire insieme “scorre” e “cola”. L’acqua che cola, si versa e fluisce, non ha un percorso, non ‘scorre’ nella forma ben precisa di un fiume o di un ruscello: piuttosto scivola, si infiltra, e alla fine si perde. “Come l’acqua che cola” è per Marguerite Yourcenar la vita stessa, che si disperde in mille rivoli, si perde e poi riaffiora, senza forma data, senza consistenza; “come l’acqua che cola” è la scrittura della Yourcenar, che alla vita si adegua, la assume come tema di fondo, e ne viene modellata. Il volume comprende tre racconti più volte rimaneggiati, secondo la modalità di scrittura tipica di Marguerite Yourcenar, l’eterno suo riandare e tornare alle stesse parole. I tre racconti infatti sono tutti e tre scritture ‘antiche’: il primo (Anna, soror) «riproduce quasi integralmente il testo del 1935»; del secondo (Un uomo oscuro), la scrittrice confessa che rispetto alla prima versione l’attuale rifacimento non conserva «nemmeno una riga»; il terzo (Una bella mattina) ha come punto di partenza semplicemente l’episodio finale del vecchio Nathanaël. È passato del tempo dall’originaria raccolta del 1935 (La morte guida il carro), che raccoglieva D’après Dürer, D’après Greco e D’après Rembrandt: incunaboli da cui nasceranno, nell’ordine, L’opera al nero, Anna, soror e Nathanaël, che nel 1980-81 si scinderà in Un uomo oscuro e Una bella mattina. Ma per la Yourcenar questa non è che una prova ulteriore della «relatività del tempo»: di Anna, soror, cinquantasei anni dopo la prima versione, scrive addirittura: «Mi sento così al passo con questo racconto, come se l’idea di scriverlo mi fosse venuta stamane». Si possono ipotizzare due possibili spiegazioni, per quest’affermazione: una è la legge generale che a Marguerite Yourcenar ha insegnato la donna che ha sostituito per lei la madre morta di parto, Jeanne de Vietinghoff: «Si consuma il mondo, ma la mia anima è sempre giovane»; l’altra è che in questo racconto Marguerite Yourcenar riconosca un tratto essenziale, permanente, della sua scrittura. Il racconto narra – in ellissi – l’amore incestuoso di Anna e Miguel, fratello e sorella, figli del governatore spagnolo di Napoli, don Alvaro della Cerna, e di Valentina di Montefeltro, ultima erede del classicismo rinascimentale: ancora una volta, Marguerite Yourcenar ambienta la sua storia in quell’età di passaggio, tra Rinascimento e Barocco, a lei tanto cara. Anna adora Miguel come se fosse Dio; e Miguel la possiede per sottrarla a quell’unico Signore, invidioso del bacio che ha visto Anna deporre con tanta intensità sul piede di un Cristo crocifisso. Quando Anna accenna alla possibilità di entrare in convento, il fratello vi si oppone urlando: «Vi permetterei un amante, solo perché crocefisso? Credete che io voglia cedervi a Dio?». Al di là dell’incesto, il peccato di Anna e Miguel è semplicemente nel loro amour fou, scandaloso e sacrilego perché totalizzante. L’incesto diventa dunque una metafora di qualunque amore tra creature terrene (appunto sempre fratello e sorella, in quanto creature), in cui l’altro diviene tutto, e la passione diventa idolatria. Anche la scrittrice ha rischiato di cadere in questa idolatria per i suoi personaggi: se si salva, è grazie ad una sorta di amor fati che è nella sua scrittura. Amor fati vuol dire, nella pagina di Marguerite Yourcenar, arrendere la propria volontà e lasciare che sia la necessità ad operare; nascondere la propria voce, e farsi voce dell’altro, in modo che la lingua trami, nell’andare e tornare delle stesse immagini, un testo che ha, al fondo, qualcosa di essenzialmente anonimo, impersonale, universale.
Bibliografia minima:
Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi, Torino 1963
Id., L’opera al nero, Feltrinelli Milano 1969
Id., Il tempo grande scultore, Einaudi, Torino 1983
Id., Come l’acqua che scorre, Einaudi, Torino 1985
Nadia Fusini, VII. Marguerite, o dell’altezza in Nomi, Donzelli editore, Roma 1996, pp.165-192
(foto di Lorenzo Avico)


