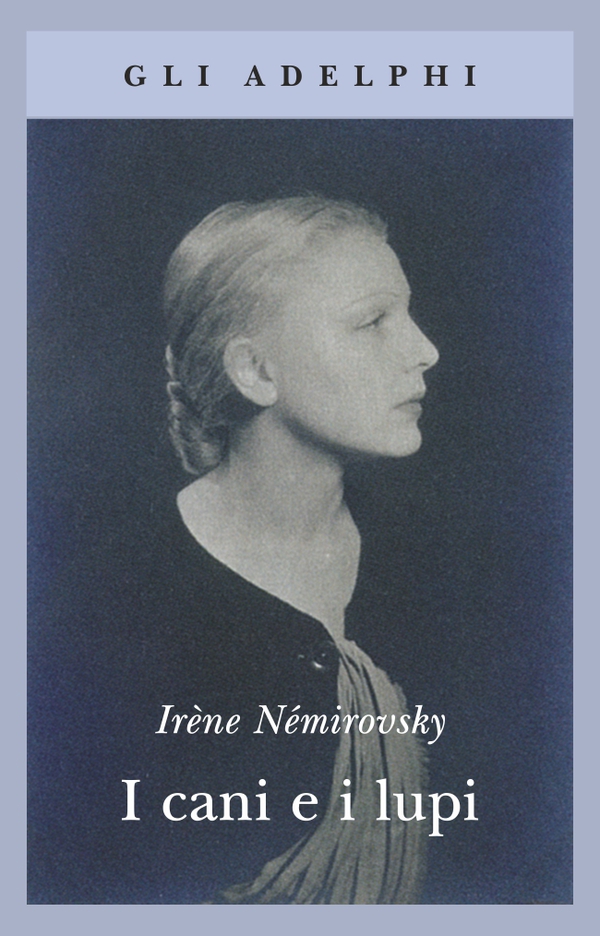GABRIELLA MONGARDI
Quando si parla di “Letteratura e Storia” il pensiero corre subito al romanzo storico e alla fisionomia che assunse nell’Ottocento, in autori come Walter Scott in Gran Bretagna o Alessandro Manzoni in Italia (o dovrei dire “nell’impero austro-ungarico”? Quando I promessi sposi videro la luce, infatti, Milano era ancora austriaca, se vogliamo essere fedeli alla Storia…).
Come tutti i liceali sanno, l’interesse della letteratura per la storia è maturato nel Romanticismo: fondatore del genere è considerato Walter Scott, che nelle sue opere ambientate nel Medioevo, quali Ivanhoe o Waverly, rappresenta le diverse tappe della storia inglese ricostruendone il senso, cioè facendo emergere le leggi fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione: egli vede nell’esito della lotta tra Sassoni e Normanni, conclusasi con la fusione dei due popoli, le origini della nazione inglese.
Il romanzo storico, secondo la celebre definizione manzoniana, è un misto di storia e di invenzione: l’autore colloca una vicenda immaginaria e personaggi fittizi in un momento storico preciso, di cui ricostruisce scrupolosamente la situazione politico-sociale, i costumi, le condizioni di vita. Le vicende private dei protagonisti sono intrecciate con gli avvenimenti collettivi dei popoli e direttamente influenzate da essi, e personaggi realmente esistiti si affiancano a quelli inventati. Il romanzo storico, così, integra la storia sul piano psicologico e/o sociologico. Sul piano psicologico, perché lo scrittore, quando ricorre a personaggi storici come protagonisti del suo romanzo, inventa secondo verosimiglianza ciò che i documenti d’archivio non registrano, ossia i sentimenti, le motivazioni, le reazioni degli uomini alle vicende storiche; sul piano sociologico, perché i personaggi fittizi che agiscono nel romanzo possono appartenere alle classi umili, quelle di cui la storiografia non si occupava, almeno fino all’Ottocento: è questo il caso dei Promessi Sposi.
Il nostro Manzoni si ispirò sì a Scott, ma rinnovò il modello proprio perché per la prima volta pose al centro di un’opera “seria” due personaggi umili, Renzo e Lucia, e perché mise il contesto storico (la Lombardia del Seicento, soggetta alla dominazione spagnola) davvero in primo piano, al punto che un critico, Luigi Russo, arrivò ad affermare che il vero protagonista del romanzo manzoniano è appunto il Seicento. Ma per Manzoni la situazione dell’Italia del Seicento, sottoposta agli Spagnoli, è analoga a quella della Lombardia del suo tempo, in mano all’Austria, e fu questo parallelismo a determinare la fortuna immediata dei Promessi Sposi…
Al genere del romanzo storico appartengono molti altri grandi romanzi ottocenteschi europei, da La certosa di Parma di Stendhal a Les Chouans di Balzac, da La figlia del Capitano di Puskin a Guerra e pace di Tolstoj a I Viceré di De Roberto.
Se la grande fioritura del romanzo storico si può considerare finita intorno alla metà dell’Ottocento, il genere però non tramonta del tutto, anzi viene ripreso nel Novecento da scrittori che scavano nel passato per riflettere sui problemi del presente, come fanno ad esempio Tomasi di Lampedusa con Il gattopardo, la Morante con La storia, la Yourcenar con Le memorie di Adriano… Con una netta differenza, però, rispetto ai modelli ottocenteschi: all’esigenza della documentazione storica si affianca un sempre più vivo interesse per l’analisi psicologica dei personaggi, che diventano il vero centro del racconto, con il conseguente spostamento del punto di vista dall’esterno all’interno e l’introduzione di elementi propri di altre forme narrative, quali il romanzo sperimentale o il romanzo giallo. Soprattutto, nel passaggio dall’Ottocento al Novecento cambia “il senso della storia”, la visione, l’interpretazione che se ne dà. Se in uno scrittore come Scott la storia poteva ancora apparire come sviluppo organico e positivo frutto dell’agire degli uomini per la costruzione di un mondo migliore (ma già in Manzoni prevale il pessimismo storico), per la Morante la storia è “uno scandalo che dura da diecimila anni”, un succedersi di orrori, di avvenimenti che stritolano uomini e cose, lasciandosi dietro una scia di sangue e di violenza…
Lo stesso vale per la Némirovsky, la cui biografia, se anche non fosse scrittrice, sarebbe una conferma della violenza della Storia. Ma lei aveva tutte le doti per essere una grande narratrice: la condizione di straniera, senza patria, senza radici – che le derivava dal suo essere ebrea, ma non solo – le conferiva una straordinaria capacità di guardare le cose e le persone da lontano, e di coglierne l’essenza con immagini e parole nitide e precise.
Nata a Kiev, in Ucraina, nel 1903 da una famiglia dell’alta borghesia ebraica (il padre era banchiere), sin dall’infanzia fu esposta ai più tragici eventi della storia. A tre anni si salvò da un pogrom perché la cuoca le mise al collo la sua croce ortodossa e la nascose dietro un letto. Con la Rivoluzione d’Ottobre i Némirovsky si dovettero rifugiare in Finlandia e infine in Francia, dove la famiglia trascorreva già prima lunghi periodi dell’anno, com’era abitudine tra i ricchi russi, aristocratici o non. A Parigi Irène studia lettere alla Sorbona, scrive romanzi e racconti ispirati al suo mondo e ai difficili rapporti con i genitori, soprattutto con la madre, e sposa l’ingegnere russo Michel Epstein, da cui ha due figlie. Già negli anni Venti Irène Némirovsky è riconosciuta come una delle più grandi scrittrici francesi, ma nonostante la fama e il successo, nel 1935 il governo francese rifiuta la sua richiesta di cittadinanza. Nemmeno la conversione al cattolicesimo di tutta la famiglia, nel febbraio del 1939, basta a garantire loro la salvezza in cui speravano: l’odio antisemita si stringe sempre più intorno a loro come una rete cui è impossibile sfuggire. Quando scoppia la guerra, la famiglia Epstein-Némirovsky si rifugia in un paesino della Borgogna, dove riesce a condurre una vita quasi normale, finché il 16 luglio 1942 Irène viene arrestata e caricata su un treno per Auschwitz, dove morirà un mese dopo.
Come ricordano i suoi biografi, dal 1926 al 1940 la Némirovsky non ha fatto altro che scrivere un unico, immenso, lunghissimo romanzo, a partire da Un bambino prodigio (1927) per arrivare a I cani e i lupi, l’ultimo pubblicato da lei in vita, nel 1940. Oggi esamineremo appunto questo romanzo e l’altro ultimato nello stesso anno, I doni della vita, pubblicato a puntate su “Gringoire” nel 1941 e in volume, postumo, nel 1947: in entrambi la storia inizia sempre prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma si ferma alla seconda metà degli anni Venti in I cani e i lupi; mentre in I doni della vita arriva fino al momento della scrittura, fino al maggio del 1940.
In senso stretto, le opere della Némirovsky non si dovrebbero definire “romanzi storici”, ma semmai “realistici” o addirittura autobiografici, perché l’autrice non tratta se non dei suoi anni e degli eventi tragici che li hanno segnati: i pogrom, la rivoluzione russa, le due guerre mondiali che lei ha vissuto sulla propria pelle fino a esserne schiacciata. Il fatto è che alla Némirovsky «la storia scorreva letteralmente nelle vene», e proprio di qui deriva l’inevitabile carattere storico, la natura intimamente storica dei suoi romanzi: non solo in quanto testimonianza di un’epoca, che è stata anche nostra, ma soprattutto in quanto riflessione sulla Storia e sul senso di essa. Una riflessione che non è riferita e argomentata, ma appunto narrata e messa in scena, incarnata in personaggi vivi e realistici, in ambienti e paesaggi “parlanti”; una riflessione che emerge dalla catena di azioni e reazioni, dai contrasti e dalle analogie tra i vari elementi del racconto: sono in particolare le figure femminili a essere portatrici di una visione del mondo alternativa a quella da cui nasce la “Grande Storia” politico-militare, che è “roba da uomini”…
I cani e i lupi in effetti si direbbe di primo acchito un romanzo d’amore, o addirittura una versione moderna della favola di Cenerentola (con un finale molto diverso, però), ma a guardar bene si rivela un romanzo storico malgré soi, in quanto attraverso le vicende di Ada Sinner, che già da bambina incontra Harry, il suo amore di donna, viene narrata la vita degli ebrei in Europa – all’Est e a Parigi – all’inizio del Novecento, tra pogrom e ambizioni di riscatto, di ascesa sociale da una parte, quella degli ebrei poveri confinati nel ghetto, i lupi, e ricchezza e lusso dall’altra, quella dei cani, ossia gli israeliti che grazie al denaro vivevano come gli altri, i non-ebrei: Ada apparteneva ai “lupi”, Harry ai “cani”.
La scrittrice stessa, in un’avvertenza premessa alla prima edizione, presentava il romanzo come una vicenda che non poteva essere altro che «una storia di ebrei», ribadendo la propria intenzione di descrivere il popolo a cui apparteneva così com’era, «con i suoi pregi e i suoi difetti»: giacché, affermava orgogliosamente, «in letteratura non ci sono argomenti tabù». In effetti, nessuno come la Némirovsky è stato in grado di raccontare il mondo degli «ebrei venuti dall’Est, dall’Ucraina o dalla Polonia» con altrettanta spietata lucidità – e parlare di Ebrei, di vita ebraica nel Novecento significa inevitabilmente scrivere di Storia, dalla parte delle vittime.
È vero che negli anni in cui Irène compone il romanzo non si sapeva ancora dei piani nazisti per lo sterminio sistematico di tutti gli ebrei d’Europa (quella che la conferenza di Wannsee nel 1942 chiamerà con burocratico, criminale eufemismo die Endlösung der Judenfrage) – o si preferiva non sapere, e gli stessi ebrei, non avvertendo la gravità della minaccia che incombeva su di loro, rifiutavano di mettersi in salvo con la fuga: è stato il caso della Némirovsky, o di Primo Levi…
Forse è per questo che la Storia nel romanzo rimane in secondo piano, non è oggetto di riflessione né di discorso da parte dei personaggi o della voce narrante. L’unico evento storico esplicitamente ma obliquamente narrato è un pogrom, visto con gli occhi dei bambini che non capiscono cosa stanno vivendo e fuggono dalla violenza degli altri come si cercherebbe riparo da un violento fenomeno naturale: temporale, esondazione, terremoto… Ma la violenza degli uomini contro altri uomini non è un fenomeno naturale – questa è l’unica, amara considerazione che implicitamente emerge dal testo.
La prima parte del romanzo è ambientata in una città ucraina di cui non viene mai detto il nome, dove la piccola Ada, orfana di madre, cresce affidata a una zia vedova che non la tratta male ma si occupa soprattutto dei suoi due figli, Lilla e Ben. In questa città, in cui è facile riconoscere Kiev, la famiglia di Ada abita nella parte bassa, quella degli ebrei poveri – suo padre di mestiere fa l’intermediario, compra e vende di tutto; ebrei ricchi abitano nella città alta. Fra i due quartieri sembra non esserci altro rapporto se non il disprezzo degli uni e l’invidia degli altri. Ma ad Ada basterà vedere una sola volta Harry, quel bambino ricco, ben vestito, dai riccioli bruni, dai grandi occhi splendenti, che abita nella meravigliosa villa sulla collina e di cui dicono sia un suo lontano cugino, per essere certa che lo amerà per sempre, di un amore assoluto e incancellabile. E allorché il ragazzino Harry si troverà di fronte la bambina Ada, ne sarà al tempo stesso inorridito e attratto: come «un cagnolino, ben nutrito e curato, che sente nella foresta l’ululato famelico dei lupi, i suoi fratelli selvaggi».
La seconda parte è ambientata a Parigi, dove la zia si trasferisce con i figli e la nipote sperando che sua figlia possa diventare un’attrice affermata e Ada, che ha talento per dipingere, una pittrice famosa. A Parigi Ada sposerà il cugino Ben, e molti anni dopo incontrerà di nuovo Harry, sposato a sua volta con una ricca ereditiera francese. I due diventano amanti, Ben diventa l’uomo di fiducia dei banchieri zii di Harry, ma una serie di speculazioni troppo disinvolte portano la banca sull’orlo del fallimento. Ada, che è incinta di Harry, per salvarlo dallo scandalo lo lascia, abbandona Parigi e ottiene un visto per un piccolo paese dell’Europa orientale, dove partorisce in un hotel, assistita da uno studente in medicina e da una levatrice improvvisata. Il romanzo si chiude con una dichiarazione di fiducia nel futuro: «La pittura, il bambino, il coraggio. Con questo si può vivere più che bene».
Dicevo che I cani e i lupi può sembrare un romanzo d’amore ma, come sempre avviene nei grandi scrittori, l’amore in realtà è un codice, un pretesto per parlare d’altro: la storia di un amore è la cellula narrativa elementare che permette di mettere in gioco, sulla pagina, forze contrapposte, tensioni e antagonismi. In questo caso, sul piano storico-sociale, le dinamiche di repulsione e attrazione tra i due gruppi sociali ebraici, che nel profondo restano uguali: «Siamo una razza avida, affamata da così tanto tempo che la realtà non basta a saziarci» I lupi infatti non sono che i fratelli selvaggi dei cani, e questi ultimi, per quando civilizzati e addomesticati, ne avvertono sempre il richiamo.
Ma in verità, per questo romanzo è possibile un’altra chiave di lettura, quella artistica: la protagonista è una pittrice, e sono i suoi quadri a condurre a lei l’uomo di cui è innamorata; è il suo sguardo particolare sulla realtà, il suo distacco dalle cose e dalle persone, a consentirle di salvarsi nelle situazioni pesantissime che affronta – ed è in quanto “romanzo artistico” che il libro della Némirovsky oltrepassa lo status di testimonianza di un’epoca, che pure ha, e attinge il livello del capolavoro. Un capolavoro umile, poco appariscente forse – come la sua protagonista, ma non per questo di minor valore letterario.
Basti pensare all’orchestrazione narrativa, cioè all’ordine del tempo dato dalla concatenazione dei capitoli, per misurarne la grandezza. I trentatré capitoli in cui si articola sono come quadri di una mostra a tema, ciascuno concluso in sé, eppure collegato agli altri non solo dalla presenza in ogni quadro dello stesso sfondo o delle stesse figure, ma ancor più dallo spazio bianco del muro che li separa. In ogni capitolo, e tra un capitolo e l’altro, è più il non detto che il detto; l’allusione, l’ellissi domina sovrana – eppure i personaggi e gli ambienti sono delineati con estrema precisione e acutezza, grazie a rapide e sicure pennellate che suggeriscono più che definire univocamente, e lasciano al lettore la libertà di cooperare alla creazione del quadro, rimanendone però al di fuori. L’autrice non vuole l’identificazione del lettore con i personaggi, che in quanto ebrei sono sempre separati dal resto del mondo da un sottile diaframma, una ineliminabile ‘diversità’ – quella che gli altri chiamano l’insolenza giudea, e che non è se non il portato di una profonda sfiducia in se stessi e nel prossimo, un senso di non-appartenenza, di sradicamento, di precarietà assoluta uniti a un ardore profondo di piegare il mondo alla propria immaginazione, ai propri desideri… In fondo, la stessa condizione degli artisti…
Nello stesso anno in cui pubblicava I cani e i lupi, il 1940, la Némirovsky concludeva anche I doni della vita – in cui invece la tragica “grande storia” europea del Novecento domina la scena, soprattutto nella seconda e nella quarta parte (che comprendono rispettivamente i capitoli dal 6 al 12, dedicati alla Prima Guerra Mondiale, e quelli dal 23 al 30, dedicati alla Seconda). Il romanzo questa volta è interamente ambientato in Francia, e ha i due poli principali in Saint-Elme, una piccola città del Nord dove la famiglia altoborghese degli Hardelot, che ne è la protagonista, ha una cartiera, e in Parigi, dove i giovani Hardelot da generazioni si trasferiscono per studiare e in alcuni casi per vivere, al di fuori dell’atmosfera soffocante della provincia.
I primi cinque capitoli costituiscono il preludio della vicenda: narrano la rottura del fidanzamento “combinato” tra il giovane Pierre Hardelot e la ricca ereditiera Simone Renaudin e il matrimonio d’amore, celebrato quasi di nascosto, tra Pierre e Agnès Florent, concludendosi con la narrazione, tenera e delicatissima, della prima notte di nozze in un albergo parigino.
Dopo un’ellissi narrativa di quattro anni, durante la quale nasce il primo figlio di Pierre e Agnès, Guy, la seconda sezione si apre con lo scoppio della prima guerra mondiale e la chiamata alle armi di Pierre, e si conclude, pochi mesi prima della fine della guerra, con la morte di Charles Hardelot, il padre di Pierre, sotto le macerie di una chiesa parigina colpita da una granata.
Nella terza sezione, che si potrebbe intitolare “Tra le due guerre”, assistiamo alla ripresa della vita “normale”: la parata della vittoria a Parigi, la nascita della sorellina del piccolo Guy, che nel frattempo cresce, va all’università, si innamora della donna sbagliata e tenta il suicidio; la festa per gli 85 anni del nonno Julien Hardelot, che non ha mai perdonato al nipote il matrimonio fatto contro la sua volontà; le difficoltà economiche della ditta, per cui Pierre è costretto a vendere le sue azioni a Simone, che ne diventa così proprietaria, mentre sullo sfondo si sente “l’eco di eserciti in marcia”.
E nell’attesa della guerra, la seconda guerra mondiale, fiorisce l’amore tra Guy e Rose, la figlia di Simone, che dà a malincuore il consenso alle nozze, ma le rifiuta la dote. Perciò, i novelli sposi devono coabitare a Parigi con i genitori di Guy – ma le ristrettezze economiche e i problemi di convivenza durante l’ultima estate di pace vengono spazzati via brutalmente da un male maggiore, la guerra – e la voce narrante commenta: “Un’altra guerra… Due volte in una vita, era troppo!”. E così, la storia letteralmente si ripete: Guy parte soldato, Saint-Elme è di nuovo teatro di guerra, le donne vengono mandate via e da sfollata Rose partorisce un bimbo: la vita continua…
Il romanzo, articolato in 30 capitoli, si apre con un “notturno” sulla spiaggia che ci presenta i personaggi principali (il giovane Pierre, la fidanzata ufficiale Simone e la ragazza di cui è segretamente innamorato, Agnès) e tutta la comunità, accorsa ad assistere allo spettacolo festoso dei fuochi d’artificio – ignara che ben altre esplosioni sconvolgeranno presto il paese. Solo nel “suono debolissimo” delle onde, “come un sospiro umano”, con cui si chiude il capitolo, se ne può cogliere un presentimento – quasi la “sintesi musicale” dell’intero romanzo e delle tre polarità intorno a cui ruota: l’assurda distruttività della storia, la serenità indifferente della natura, il valore salvifico dei “doni della vita”, quelli che Epicuro chiamava “piaceri naturali e necessari”: mangiare, bere, fare l’amore, avere amicizie e affetti solidi… la quotidianità del vivere, insomma, che gli uomini stolidamente distruggono anziché proteggerla e valorizzarla. Tutti i personaggi del romanzo partecipano di questa consapevolezza e traggono da lì la loro forza, in particolare Agnès e Pierre, che si sposano per amore, contro le convenzioni borghesi per cui Pierre avrebbe dovuto sposarsi “per convenienza” con Simone, ricca ereditiera che avrebbe immesso capitali freschi nella ditta – e viene perciò diseredato dal nonno, inflessibile e dispotico custode dell’ordine tradizionale, della proprietà e della fabbrica, ai suoi occhi garanzia di immortalità (p.142). Ma ci penserà la Storia, per ben due volte, a demolire questa sua certezza insieme con gli edifici del paese distrutti dal passaggio dei soldati tedeschi: Pierre combatte nella Prima Guerra Mondiale e viene ferito, il figlio sarà arruolato nella Seconda e la madre deve patire due volte la lacerante sofferenza del distacco, del non ricevere notizie, del sapere l’amato in costante pericolo di vita, ma non si ribella, e la voce narrante commenta: “La guerra aveva già cominciato a creare la sua leggenda. Si dava per scontato che le donne si sarebbero mostrate all’altezza dei soldati con la loro serenità, il loro coraggio, la loro cieca fiducia in un radioso destino”.
Vediamo qui applicata la tecnica straniante del “doppio punto di vista”, con cui la Némirovsky parla della guerra senza mai descriverla direttamente, contrapponendo semplicemente il punto di vista “maschile”, pubblico, ufficiale, a quello “femminile”, privato, ma molto più ragionevole – perché è ragionevole costruire, conservare, proteggere, non distruggere: è ragionevole dare la vita, non la morte, e questo sia a livello individuale che collettivo, nazionale e internazionale… Basta mettere nero su bianco certe parole perché la menzogna ideologica del “radioso destino” sia smascherata e la verità dis-velata, in tutta la sua fulgida nudità: ma bisogna saper scrivere…
Allo stesso modo, quando narra le ripercussioni della guerra sulla vita dei civili, l’autrice non pronuncia giudizi, non dimostra tesi, non emette sentenze, ma si limita ad accostare le descrizioni dei soldati tedeschi per le vie di Saint-Elme, degli abitanti che lasciano le loro case senza sapere dove andare, alle loro considerazioni sull’impossibilità che la loro città fosse teatro di guerra, al loro cieco attaccamento alla casa, alle cose, al decoro formale. Basta questa alternanza a far risaltare tutta l’assurdità delle certezze borghesi e a minarle dall’interno fino a farle esplodere, da un lato; dall’altro, questa contrapposizione vale anche come condanna della guerra e della sua violenza insensata e porta a riconoscere la forza e il valore di quelle certezze, quando si tratta di risorgere dalla devastazione della catastrofe.
Ma la condanna della guerra emerge anche da un’altra contrapposizione, quella tra uomo e natura, che percorre come un fil rouge tutto il romanzo dal primo all’ultimo capitolo, ogni volta che nel testo compare, più o meno fugace, un accenno alla bellezza della natura: che sia l’incanto di un’alba o il concerto degli uccellini, le rose del giardino di casa o l’ombra protettrice del bosco della Coudre. Anche in questo caso, nulla è detto esplicitamente: ma basta che la pagina accolga la natura, che lo sguardo si sposti sull’altro polo, per evidenziare tutta l’infelicità che l’uomo si procura da se stesso. La Némirovsky, a differenza dei romantici, non accusa mai la natura di essere indifferente alla pena dell’uomo: accusa l’uomo, di essere così stolidamente artefice del proprio male – e lo fa attraverso la letteratura.
Finora abbiamo parlato della storia nei romanzi di Irène Némirovsky, del posto che occupa, dell’interpretazione che ne viene data, come se questo fosse il senso del titolo del mio intervento, Letteratura e storia in Irène Némirovsky; ma quel titolo può anche significare: in che rapporto stanno letteratura e storia per Irène? La risposta a questa domanda è indubitabile: la Storia è ancella della letteratura, a cui fornisce contenuti, materiali per la scrittura; ma quello che conta è la Letteratura, ossia il risultato della scrittura, della capacità di trasfigurare quei contenuti, quei dati storici, in forma, ritmo, arte, senza tradirne la Verità. Scrive Michail Bachtin in Estetica e romanzo, trad. it. di Carla Strada Janovič, Einaudi, Torino 19791, 20013, p.28: « La forma esteticamente significante è l’espressione di un rapporto sostanziale col mondo della conoscenza e dell’azione, ma si tratta di un rapporto che non è né conoscitivo né etico; l’artista non interviene nell’evento come suo partecipante diretto, ma occupa una posizione essenziale fuori dell’evento, come contemplatore disinteressato, che però capisce il senso assiologico di ciò che avviene; egli non lo vive immediatamente, ma lo rivive simpateticamente. Questo trovarsi-fuori (che non è indifferenza) permette all’attività artistica di unificare, organizzare e compiere dall’esterno l’evento. La forma estetica, che intuitivamente unifica e compie, si cala dall’esterno sul contenuto e lo trasferisce su un nuovo piano assiologico: quello di un’esistenza distaccata e compiuta, assiologicamente pacificata in sé: la bellezza».
Ed è quanto riesce perfettamente alla nostra autrice, grazie alla sua capacità di scavo psicologico, al suo talento descrittivo, allo stile classico, da cui sgorgano similitudini allo stesso tempo intense e delicate, semplici e illuminanti: ne cito solo due, le ultime, che sebbene compaiano a venti pagine di distanza l’una dall’altra, se accostate formano un testo continuo e sintetizzano bene lo spirito, il messaggio del libro: «E il panico si propagava di paese in paese, dilagava in tutta la Francia, come il mare invade la spiaggia nelle burrasche dell’equinozio. […] Ma Agnès non voleva sapere niente, voleva tener viva nel suo cuore la speranza, così come si protegge con la mano la fiamma tremolante di un cero».
Ma alla base del talento narrativo della Némirovsky c’è soprattutto, a mio avviso, il suo senso del tempo, che oserei definire “quantistico”, cioè granulare, puntiforme, discontinuo. Come in I cani e i lupi, anche in questo romanzo ciascuno dei capitoli costituisce per così dire un “quadro” a sé, e tra i capitoli c’è il vuoto, il buio, o meglio la presenza di un campo di forze che la scrittura non si cura di descrivere e definire, ma che si limita a suggerire tramite allusioni sotterranee. In questo modo la Némirovsky non solo affida alla scrittura il compito di selezionare i momenti salienti di una vita, di una vicenda, ma sembra renderli tali perché li narra, e se il tempo nei suoi romanzi “salta”, come gli elettroni da un orbitale all’altro del nucleo atomico, è per eccesso di energia, per non dissiparla, ma concentrarla tutta in un punto, la “scena” narrata: è per liberarsi dalle catene della successione cronologica e della durata, annullandosi nell’insignificanza del non-narrato, è per dissolversi in quanto tempo – come nelle equazioni fondamentali della meccanica quantistica (si veda il prezioso volumetto del fisico C. ROVELLI, L’ordine del tempo, Adelphi, Milano 2017).
Dopo le rivoluzioni romanzesche di Proust, Joyce, Svevo, romanzi novecenteschi apparentemente lineari, facili, come quelli della Némirovsky, che scardina, sfalda il tempo senza darlo a vedere, senza violentare né la sintassi né la punteggiatura né il lessico, possono sembrare letteratura popolare, di mero intrattenimento, di consumo – ma non è così. Sono romanzi poetici perché “dicono la verità obliquamente”, filtrando esperienze dure attraverso uno sguardo di bambino – cioè di artista – e allontanando il più possibile da sé l’oggetto della narrazione. Sono romanzi allo stesso tempo profondi e leggeri, che si sarebbe tentati di definire agrodolci se non si sapesse quanto poco ‘dolce’, quanto atrocemente ‘agra’ è stata, nella civilissima Europa del Novecento, la sorte degli ebrei – e della scrittrice stessa, passata per il camino… Colpa di un’entità impersonale chiamata “Storia”, magari con la maiuscola, per ipostatizzarla meglio, o degli uomini che la fanno? E quale altra arma – per quanto debole, inadeguata, irrisoria – possiamo avere per difenderci dalla storia, se non la Letteratura? Quale altra alternativa abbiamo? Solo grazie alla Letteratura, la Némirovsky è sopravvissuta alla Storia che l’ha annientata…
(testo dell’intervento tenuto al convegno AICC 2019, Il senso della Storia)