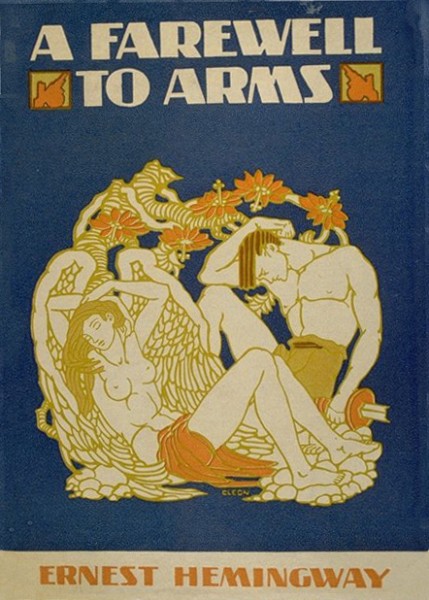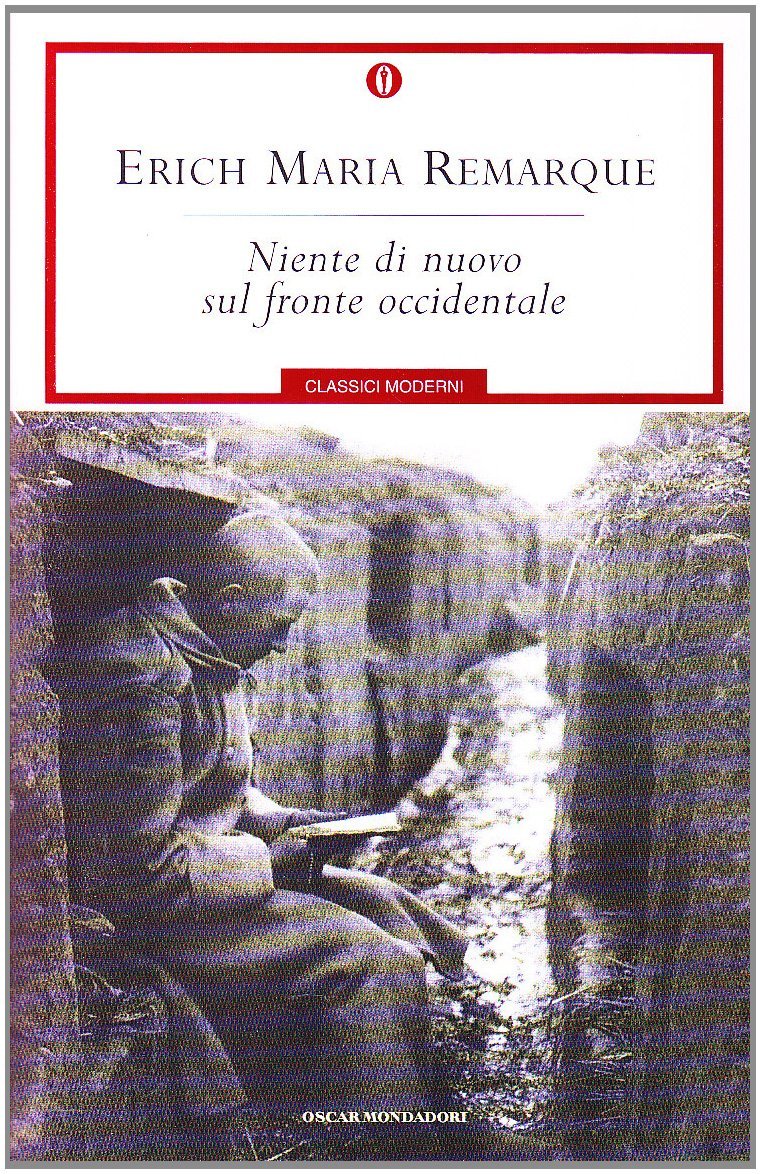STEFANO CASARINO.
1.
“L’inutile strage” di Attilio Ianniello ha il raro pregio di far comprendere come fu vissuta la guerra del ’15-’18 a Mondovì: è una riflessione importante, perché troppo spesso si tende a dimenticare che la Storia non riguarda solo i Grandi, i potenti, ma ci coinvolge tutti, senza scampo.
Oggi, 24 maggio, ricorre il centenario esatto dall’ingresso dell’Italia in quella che è stata unanimemente chiamata “la Grande Guerra” (con la doppia iniziale maiuscola sia in francese – Grande Guerre – che in inglese – Great War – che in tedesco – Grosse Krieg, ma qui compare anche per la prima volta l’espressione Welt Krieg, Guerra Mondiale): mai si era visto niente di simile prima!
Purtroppo, però, dopo vent’anni dalla conclusione di quel conflitto, l’umanità vedrà qualcosa di ben peggiore, al cui confronto la “Grande Guerra” quasi impallidisce. Un solo dato: la stima dei caduti nel primo conflitto mondiale oscilla tra i 10 e i 15 milioni; quella del secondo ammonta a più di 60 milioni, più di quattro volte tanto!
Come ricordare oggi quel conflitto, apparentemente così lontano nel tempo, e quali riflessioni far scaturire dalla memoria di ciò?
Proviamo a farci guidare dalla letteratura, convinti come siamo che essa fornisca sempre un’imprescindibile “lettura”, una conoscenza in profondità del divenire storico.
Va, però, svolta qualche preliminare considerazione: l’Europa affronta quel conflitto nel pieno del suo benessere economico e del suo splendore culturale. Dall’epoca della Belle Epoque e del Liberty finisce dritta nella guerra di trincea; dal massimo della prosperità – agli inizi del Novecento il PIL di Inghilterra, Germania e Francia assieme era il 60% di quello mondiale – passa con incredibile rapidità alla distruzione, alla miseria, all’orrore.
Quella guerra fu affrontata con leggerezza, con incoscienza: avrebbe dovuto essere una “guerra lampo”, durò anni.
Il suo svolgimento e le sue conseguenze contengono, come vedremo, tutte le premesse del conflitto successivo. E’ lì che è iniziata la “finis Europae”, che il Vecchio Continente ha progressivamente perduto la sua identità e la sua importanza: e noi siamo ancora del tutto dentro questa storia!
2.
Nel 1929, undici anni dopo la fine del conflitto, escono due libri importanti, che avranno però entrambi una sorte un po’ complicata.
Il primo è Addio alle armi di E. Hemingway: bisognerà aspettare il 1948 per la prima traduzione italiana. Al regime fascista dette troppo fastidio quella prosa così spietatamente critica contro l’incapacità dei nostri generali, quella testimonianza così lucida della disfatta di Caporetto, quell’esibito antimilitarismo.
Basta leggere la seguente affermazione per rendersene conto:
L’esercito austriaco era fatto apposta per consentire a Napoleone di vincerlo; a qualunque Napoleone. Avrei voluto che l’avessimo anche noi un Napoleone, e invece avevamo il generale Cadorna, grasso e florido, e Vittorio Emanuele, il magrolino col lungo collo sottile e la barbetta da capra.
Si noti l’impiego del “noi”, l’americano Hemingway si sente italiano!
L’opera è certamente un capolavoro, per la mirabile fusione del tema amoroso con quello bellico, entrambi ricavati dalla personale esperienza dell’autore (Hemingway prestò servizio in Italia nella Croce Rossa Americana, fu ferito, ebbe una relazione con un’ infermiera americana): uno splendido esempio di quella prosa “assolutamente onesta nei confronti del genere umano” che era l’obiettivo cui l’autore ha sempre mirato.
Si denuncia in particolare l’ottusa applicazione di un codice militare che induce a fucilare l’ufficiale trovato senza elmetto e distante dai suoi uomini, senza concedergli nemmeno la possibilità di giustificarsi, di spiegare quanto una ritirata sia caotica (L’Italia non dovrebbe mai ritirarsi, è la demenziale risposta che tronca ogni abbozzo di difesa).
E si evidenzia la perdita di qualunque convincimento idealistico, di qualunque entusiasmo: gli ufficiali stessi non ne possono più di combattere, come comprendiamo da questo veloce scambio di battute:
“Non c’è niente di peggio della guerra”. “La sconfitta è peggio”. “Non credo […]Cos’è la sconfitta? Si torna a casa”.
3.
Il secondo libro di quell’anno è Niente di nuovo sul fronte occidentale di E. M. Remarque: lo si può definire il canto della distruzione di un’intera generazione, perché è il racconto di come dei ragazzi tedeschi non ancora ventenni furono catapultati dalle aule scolastiche al fronte dalla criminale retorica dei loro insegnanti.
Un perverso sistema educativo – che è perdurato ben oltre il primo conflitto mondiale ed ha prodotti frutti ancora più avvelenati nel secondo! – ha preparato quegli adolescenti non al lavoro e alla vita, ma alla guerra e alla morte, cancellando la loro personalità, trasformandoli in passivi esecutori di ordini. Le premesse poste nelle aule liceali hanno trovato realizzazione in caserma:
In dieci settimane ci formarono alla vita militare, e in questo periodo ci trasformarono più profondamente che non in dieci anni di scuola. Imparammo che un bottone lucido è più importante che non quattro volumi di Schopenhauer.[…]Avevamo diciott’anni, e cominciavamo ad amare il mondo, l’esistenza: ci hanno costretti a spararle contro.[…] Per anni e anni la nostra occupazione è stata di uccidere, è stata la nostra prima professione nella vita. Il nostro sapere della vita si limita alla morte. Che accadrà dopo? che ne sarà di noi?
Queste alcune delle affermazioni che si possono leggere e che vanno attentamente meditate: contengono già in nuce quella che sarà la successiva metamorfosi della nazione tedesca, che si consacrerà al nazismo dopo Weimar e che sarà responsabile di un altro, più tremendo conflitto.
Niente di nuovo sul fronte occidentale ebbe un enorme successo, raggiunse il milione di copie vendute, ma dette seri problemi al suo autore: come per l’opera precedente, neppure questa poteva ovviamente piacere al regime venuto dopo. Nel 1937 il nazismo priva Remarque della cittadinanza tedesca, lo costringe ad emigrare due anni dopo a New York: nel 1947 prende la cittadinanza americana.
Il suo libro scuote le nostre coscienze ancora oggi, vale più e meglio di una esplicita condanna della guerra e del militarismo, perché come affermato nella premessa, non vuol essere né un atto d’accusa né una confessione. Non è che il tentativo di raffigurare una generazione che – anche se evitò le granate – venne distrutta dalla guerra.
4.
Accanto a queste due opere straniere, l’italiano Un anno sull’altipiano di E. Lussu è un libro che merita attenzione e che fornisce ulteriori importanti elementi per meglio comprendere le peculiarità della Grande Guerra.
Scritto nel 1936 quando l’autore era ricoverato in un sanatorio svizzero e apparso prima in francese nel 1938 e in italiano solo nel 1945 (sorte analoga al romanzo di Hemingway), rappresenta un io narrante che è colto (cita Ariosto e Baudelaire) e, soprattutto, astemio: tutti al fronte bevono, tranne lui! E questo attira su di lui il massimo dello sconcerto: come si può affrontare la guerra, quella guerra, senza essere storditi dall’alcool? Le distribuzioni di cognac alle truppe sono generosissime prima di ordinare l’assalto alle trincee nemiche: chi è un po’ brillo non pensa, il liquore obnubila le menti, rende più docili.
Leggendo Lussu, si comprende bene l’assurdità della guerra di trincea (È da oltre un anno che io faccio la guerra – dice un ufficiale – un po’ su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi! È orribile! È per questo che ci ubriachiamo tutti, da una parte e dall’altra) e l’odio che i soldati, la truppa provano nei confronti degli altezzosi, supponenti generali (emblematica la figura del generale Leone!).
La guerra è un’autentica idiozia, una serie di errori madornali commessi da ambo le parti, che causano un incredibile sperpero di vite umani: altro che raffinate strategie! E della guerra sono causa, in modo perfettamente bilanciato, sia il velleitarismo irresponsabile che la speculazione criminale:
Noi siamo entrati in guerra con i capi politici e militari impreparati.[…] E attorno a loro una banda di speculatori, protetti da Roma, fa i suoi affari sulla nostra vita. Lo avete visto l’altro giorno con le scarpe distribuite al battaglione. Che belle scarpe! Sulle suole, con bei caratteri tricolori, c’era scritto: “Viva l’Italia!”. Dopo un giorno di fango, abbiamo scoperto che le suole erano di cartone verniciato color cuoio.[…]Le scarpe non sono che un’inezia. Ma il terribile è che hanno verniciato la stessa nostra vita, vi hanno stampigliato sopra il nome della patria e ci conducono al massacro come delle pecore.
Quella guerra fu davvero un macello, una mattanza.
La letteratura ce ne descrive tutto l’orrore ma ci permette anche di comprenderne le tante cause: una cattiva retorica e una cattiva educazione che inneggiavano alla guerra; un assoluto disprezzo della vita umana; una gravissima impreparazione, un incredibile velleitarismo, la palese inadeguatezza della classe dirigente e dei ceti militari, che addirittura inizialmente pensavano che la guerra sarebbe durata poco! Tutta questa follia si rivelò potentemente contagiosa, come osserva Remarque: In fondo i soli veramente ragionevoli erano i poveri, i semplici, che stimarono subito la guerra una disgrazia, mentre i benestanti non si tenevano dalla gioia, quantunque proprio essi avrebbero potuto rendersi conto delle conseguenze.
5.
Poco più di vent’anni – giova ripeterlo – intercorrono tra la prima e la seconda guerra mondiale.
Si può ben ritenere che lo svolgimento e la conclusione della prima abbiano determinato lo svolgimento e la conclusione anche della seconda, pur con gli opportuni distinguo. Credo che l’insegnamento che si può trarre dalla riflessione sulla Grande Guerra sia ben condensato in queste parole di Elémire Zolla: La guerra del 1914 segnò uno sperpero osceno di civiltà. Le generazioni che ne emersero si trovarono mutate a fondo, pronte alla tortura comunista o fascista, mai prima sperimentate.
La Prima Guerra Mondiale si concluse con la cancellazione di tre grandi Imperi (austro-ungarico; russo; ottomano) ma non con una ridefinizione intelligente ed equilibrata dei rapporti tra i diversi Stati. Il Trattato di Versailles (1919) fu definito da Winston Churchill “pace anfibia”: né riconciliazione né annientamento. Favorì il mantenimento dei risentimenti, dell’odio tra i popoli e le nazioni, pose le premesse per il sorgere di fascismo e nazismo.
Verrà un’altra guerra. Poi, forse, qualcosa lo si è imparato.
Nel 2012 all’Unione Europea è stato conferito il Premio Nobel per la pace, per aver garantito settant’anni di pace: una mezza verità storica, bisogna dimenticarsi, ad esempio, della guerra civile in Jugoslavia (1991-95).
Ma è comunque vero che perlomeno i Paesi fondatori dell’UE, le Nazioni coinvolte nei due conflitti mondiali non hanno più dichiarato guerra, non si sono più combattuti tra loro. Non è poco.
Per questo, ricordare la Grande Guerra deve servire, a parer mio, a riflettere sull’Europa, su cosa è stata e, soprattutto, su cosa potrebbe ancora essere.