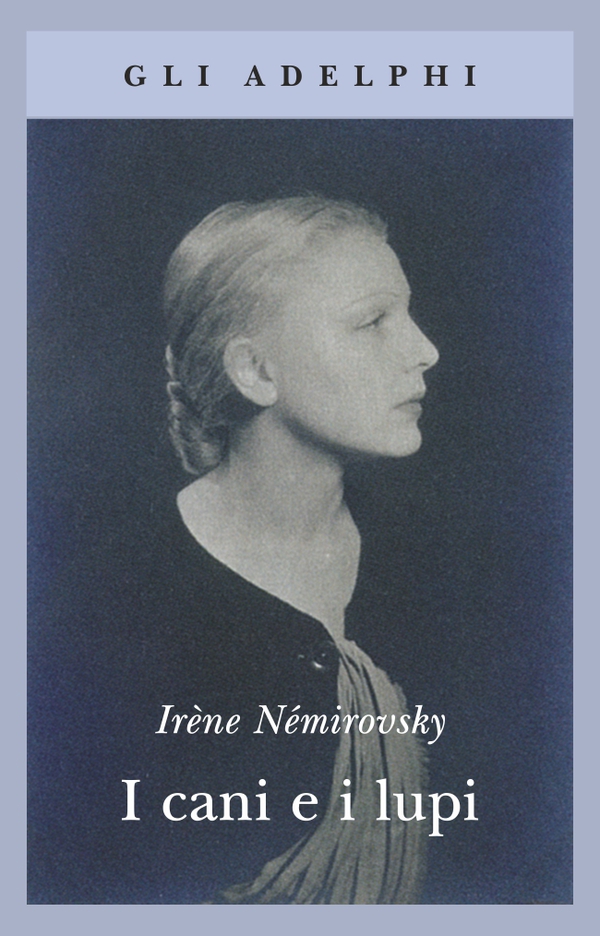 GABRIELLA MONGARDI.
GABRIELLA MONGARDI.
Chissà com’è stato accolto quando è uscito, nel 1940 a Parigi, I cani e i lupi, il libro di un’ebrea che raccontava «una storia di ebrei… venuti dall’Est, dall’Ucraina e dalla Polonia… una storia che, per ogni sorta di ragioni, poteva accadere solo a degli ebrei»… E che miracolo, che abbia trovato un editore disposto a pubblicarlo, in anni in cui l’antisemitismo era un sentimento diffuso, condiviso, addirittura assurto a ideologia di Stato, tradotto in leggi! È vero che la stessa Némirovsky è stata accusata di antisemitismo, da chi non ha capito che “gli ebrei sono come gli altri” e che la denuncia dei loro difetti, oltre che essere espressione di libertà artistica, è un disperato tentativo di assimilazione, di mimesi degli “altri”, indotta dal loro antisemitismo.
Leggere oggi i libri di Irène Némirovsky, ebrea ucraina fuggita a quindici anni a Parigi e morta ad Auschwitz nel 1942, a trentanove anni, è anche una forma di Kippur, di espiazione, ma è soprattutto un toccar con mano l’impoverimento, la regressione subita dalla cultura e dalla civiltà europea per lo sterminio di milioni di ebrei, colpevoli solo di essere di religione diversa dai cristiani, di essere acuti, ironici, intellettuali, artisti …
Il romanzo I cani e i lupi può sembrare un romanzo d’amore, addirittura una versione moderna della favola di Cenerentola (con un finale molto diverso, però), ma è piuttosto un romanzo storico, in quanto attraverso la vicenda di Ada bambina e poi donna, e dell’incontro con Harry, l’amore della sua vita, viene narrata la vita degli ebrei in Europa – all’Est e a Parigi – all’inizio del Novecento, tra pogrom e ambizioni di riscatto, di ascesa sociale da una parte, quella degli ebrei poveri confinati nel ghetto, i lupi, e ricchezza e lusso dall’altra, quella dei cani, ossia gli israeliti che grazie al denaro vivevano come gli altri, i non-ebrei.
Come sempre avviene nei grandi scrittori, l’amore in realtà è un codice, un pretesto per parlare d’altro: la storia di un amore è la cellula narrativa elementare che permette di mettere in gioco, sulla pagina, forze contrapposte, tensioni e antagonismi. In questo caso, sul piano storico, le dinamiche di repulsione e attrazione tra i due gruppi sociali ebraici, che nel profondo restano uguali: «Siamo una razza avida, affamata da così tanto tempo che la realtà non basta a saziarci». I lupi infatti non sono che i fratelli selvaggi dei cani, e questi ultimi, per quando civilizzati e addomesticati, ne avvertono sempre il richiamo.
Ma c’è almeno un altro piano di lettura, quello artistico: la protagonista è una pittrice, e sono i suoi quadri a condurre a lei l’uomo di cui è innamorata; è il suo sguardo particolare sulla realtà, il suo distacco dalle cose e dalle persone, a consentirle di salvarsi nelle situazioni pesantissime che affronta – ed è in quanto “romanzo artistico” che il libro della Némirovsky oltrepassa lo status di testimonianza di un’epoca, che pure ha, e quello di piacevole lettura, che pure è, e attinge il livello del capolavoro. Un capolavoro umile, poco appariscente forse – come la sua protagonista, ma non per questo di minor valore letterario.
Basti pensare all’orchestrazione narrativa, cioè all’ordine del tempo dato dalla concatenazione dei capitoli, per misurarne la grandezza. I trentatré capitoli in cui si articola sono come quadri di una mostra a tema, ciascuno concluso in sé, eppure collegato agli altri non solo dalla presenza in ogni quadro dello stesso sfondo o delle stesse figure, ma ancor più dallo spazio bianco del muro che li separa. In ogni capitolo, e tra un capitolo e l’altro, è più il non detto che il detto; l’allusione, l’ellissi domina sovrana – eppure i personaggi e gli ambienti sono delineati con estrema precisione e acutezza, grazie a rapide e sicure pennellate che suggeriscono più che definire univocamente, e lasciano al lettore la libertà di cooperare alla creazione del quadro, rimanendone però al di fuori. L’autrice non vuole l’identificazione del lettore con i personaggi, che in quanto ebrei sono sempre separati dal resto del mondo da un sottile diaframma, una ineliminabile ‘diversità’ – quella che gli altri chiamano l’insolenza giudea, e che non è se non il portato di una profonda sfiducia in se stessi e nel prossimo, un senso di non-appartenenza, di sradicamento, di precarietà assoluta uniti a un ardore profondo di piegare il mondo alla propria immaginazione, ai propri desideri… In fondo, la stessa condizione degli artisti…
Dopo le rivoluzioni romanzesche di Proust, di Joyce, un romanzo novecentesco apparentemente lineare, facile, come quello della Némirovsky, che non violenta la sintassi né la punteggiatura né il lessico, può sembrare letteratura popolare, di mero intrattenimento, di consumo – ma non è così.
È un romanzo poetico perché “dice la verità obliquamente”, filtrando esperienze dure attraverso uno sguardo di bambino – cioè di artista – e allontanando il più possibile da sé l’oggetto della narrazione. È un romanzo allo stesso tempo profondo e leggero, che si sarebbe tentati di definire agrodolce se non si sapesse quanto poco ‘dolce’, quanto atrocemente ‘agra’ sarebbe stata la sorte degli ebrei – e della scrittrice stessa – di lì a poco…


