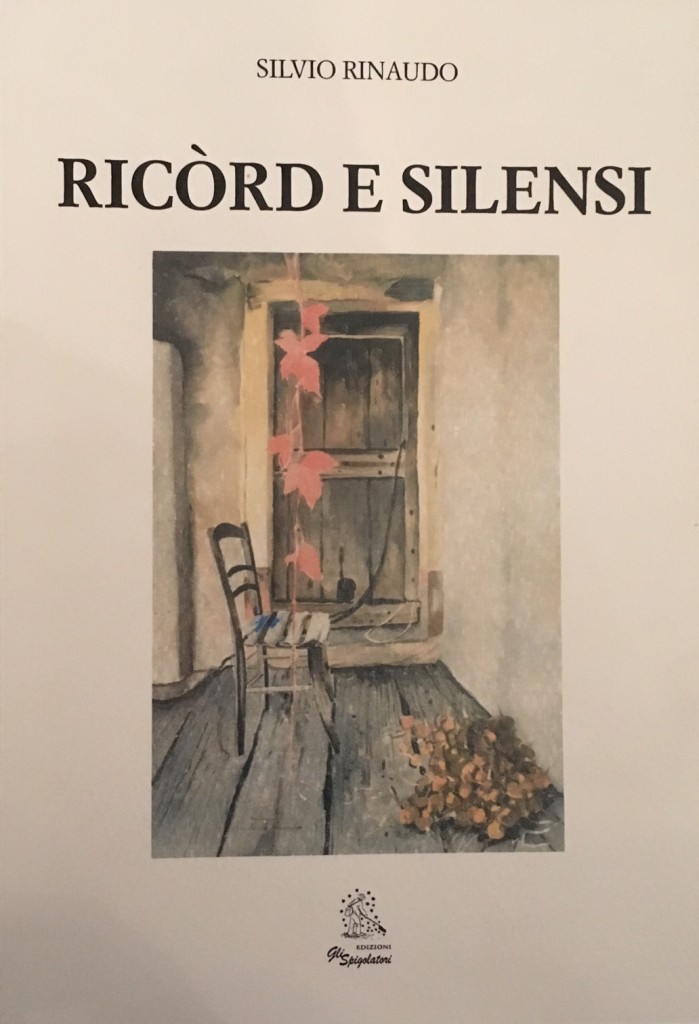NICOLA DUBERTI.
Risale a giugno di quest’anno la morte di Silvio Rinaudo, ma io solo ora – a ottobre – trovo la forza d’animo di scrivere qualcosa su di lui. La sua storia infatti si è intrecciata profondamente con la mia e non è facile per me parlarne. Quando io ero un adolescente, verso la metà degli anni Ottanta, Silvio Rinaudo era il direttore della Biblioteca Civica di Mondovì, la città dove mi ero trasferito per frequentare il ginnasio e poi il liceo. Alto, severo, vestito sempre in modo impeccabile, faceva parte di quelle figure istituzionali con cui un ginnasiale monregalese doveva per forza venire a patti – a meno che la sua famiglia non fosse così ricca da avere tutti i libri possibili in casa. La mia non lo era, anzi: quindi la biblioteca era un punto di riferimento, per me, anche se quella figura elegante ed altera mi incuteva un certo timore.
Passarono pochi anni, io continuavo a sembrare un adolescente ma ormai frequentavo l’università di Torino. Frequentavo solo alcuni corsi, per la verità, perché appena potevo cercavo di guadagnare qualche soldo lavorando qua e là. Durante il secondo anno, terminata l’assidua frequenza di filosofia teoretica con Vattimo, mi trovai ad avere un semestre senza corsi da seguire. Nel frattempo si liberò un posto a tempo determinato presso la biblioteca di Mondovì. Lo ottenni io e mi trovai con grande curiosità dall’altra parte del bancone prestiti. Silvio Rinaudo divenne così il mio capo e scopersi ben presto che dietro la facciata di rigore e professionale distacco (la baveta, ‘la maschera’, delle sue poesie) si nascondeva un uomo onestissimo, profondamente sensibile e straordinariamente buono. Io ero all’epoca un ragazzo timidissimo e pieno di complessi – mi resi conto che lui lo era altrettanto, ma aveva trovato una serie di modi per trasformare la timidezza in signorile riservatezza e per suonare con la musica delle sue dissonanze una vera e propria sinfonia di parole. Era l’anno accademico 1991-1992, io ero iscritto al corso di laurea in Lettere classiche e lui aveva appena pubblicato Fio’ feura stagion ‘Fiori fuori stagione’ per i Babi Cheucc di Meco Boetti. Il piemontese era la mia lingua di prima socializzazione e la sua varietà di Mondovì mi aveva sempre incuriosito, sebbene in casa parlassi solo il violese e sentissi circolare tutt’al più un po’ di kje. Conoscere di persona un poeta in dialetto e cominciare a discutere con lui di scrittura e di lingua orientò in modo definitivo i miei interessi. Fino ad allora mi interessavano le lingue classiche, o almeno credevo che mi interessassero. Cominciai d’improvviso a rimpiangere di non avere scelto un orientamento universitario diverso (magari lingue e letterature straniere) per potermi dedicare alla letteratura medievale e moderna, alla poesia in occitano, alla filologia romanza e alla dialettologia italiana. Cominciai a farlo da dilettante, trascurando sempre più gli studi classici che comunque conclusi per forza d’inerzia. Ormai davvero mi interessava altro. Tramite Rinaudo conobbi gli altri grandi nomi del cenacolo poetico monregalese: Carlo Regis, prima di tutti, poi Remigio Bertolino, Meco Boetti, Carlo Dardanello, Ezio Briatore. Ripresi a scrivere in dialetto violese, attività che avevo già iniziato quasi per gioco a diciassette anni. Nel frattempo il mio periodo di lavoro in biblioteca si era concluso, ma non le conseguenze di quell’esperienza: i miei interessi erano cambiati in modo definitivo. Cercai di inserire nel piano di studi universitario tutti gli esami che mi consentissero di leggere poesia. Tra questi, Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea con Giorgio De Rienzo. Scelsi il programma per non frequentanti, visto che dovevo lavorare – anche se non più in biblioteca, non più con Rinaudo purtroppo. Il programma prevedeva la lettura integrale di tantissime opere di poesia novecentesca in italiano, in edizione integrale. Quell’esame mi cambiò per sempre; e non avrei mai scelto di inserirlo nel piano di studi se prima non avessi conosciuto Rinaudo. E fu sempre a lui che mi rivolsi quando alcuni anni dopo mi resi conto di avere da parte una certa quantità di versi in dialetto, nati anche sulla base delle suggestioni novecentesche assorbite durante gli studi universitari. Glieli lasciai in lettura, un po’ timoroso del suo giudizio. Giudizio che invece fu molto positivo: os no lesa nen tante ’d ròbe parèj, mi disse mentre passeggiavamo sotto i portici di Piazza Maggiore, nel cuore medievale della Mondovì alta. Nacque così la mia prima raccolta di versi, Varsci appunto (in violese), uscita nel 1996 per i tipi de “Il salice dorato” su iniziativa – e a spese – proprio di Silvio Rinaudo. Per questo mi risulta difficile parlare di lui con il distacco di chi ricorda semplicemente la morte di un operatore culturale e di uno scrittore. Per me è un po’ come parlare della morte di un padre – e non è cosa facile. Mio padre del resto era proprio del 1926 come Silvio Rinaudo e come lui nato in un paese di montagna delle Valli Monregalesi: a Viola mio padre, a Montaldo Silvio. Quando conobbi Silvio mio padre Emilio era già morto da molti anni. Per questo – inconsciamente – credo di avere cercato in Silvio un padre che non avevo più, come forse lui cercava in me un figlio che non aveva mai avuto. O forse no, lui era solo incuriosito da quel ragazzotto impacciato, chiuso e strano che ero io all’epoca. Fatto sta, che anche la Ca Rossa presente nelle poesie di Rinaudo, la casa di Mondovì Ferrone dove lui aveva i più bei ricordi della sua infanzia, dove credo sognasse di tornare spesso – anche quella casa, dicevo, era legata a filo doppio con mio padre. Mio padre aveva visto quella casa molte volte, abbandonata com’era nei primi anni Ottanta, e mi aveva confessato più volte di considerarla bellissima e di sentire che lì sarebbe stato benissimo. La casa della felicità che mio padre rimpiangeva di non aver mai avuto era la stessa casa della felicità che Silvio rimpiangeva di non avere più. Non un edificio simile, non l’idea di una casa: no, proprio lo stesso edificio, con lo stesso colore, lo stesso giardino, le stesse crepe e lo stesso imminente destino di distruzione. Io, educato da mia madre fin da piccolo a cercare ovunque la traccia dei segni, lessi in questa identità di desideri abitativi un segno inequivocabile di identificazione delle figure.
«Due figure sono uguali quando sovrapposte coincidono» ha scritto Giovanni Tesio nella presentazione di Memòrie e spin-e, raccolta con cui Rinaudo ha vinto il premio “Salutme ’l Mòro” nel 2002. Tesio usa questa definizione geometrica per sintetizzare quella che secondo lui è la massima aspirazione di Rinaudo e nello stesso tempo il suo azzardo più alto: tentare le perfetta corrispondenza fra parola e cosa. «Tra i confrères monregalesi – scrive sempre Tesio nella sua prefazione – è Rinaudo il meno disposto a trafficare con registri aerei, è lui a spremere il verso con la più spietata nudità di tratto, la più esposta franchezza confessionale. È suo l’io più immediatamente implicato». Ecco, quest’ultima osservazione mi pare particolarmente interessante: Rinaudo era autenticamente se stesso, nei versi che scriveva. Nella misura in cui è possibile esserlo scrivendo poesie, è naturale: cioè molto, anche quando l’io è mediato da ricordi altrui e suggestioni letterarie. In lui quest’esigenza di autenticità è palpabile, anche se la cifra da lui scelta – quella del rimpianto, dello struggimento sommesso e lancinante per lo scorrere inesorabile del tempo – ha finito in qualche caso per incanalare un’ispirazione più ampia che avrebbe potuto dare prove anche diverse. Ne è un bell’esempio la poesia che Rinaudo consegnò a Remigio Bertolino e a me per la raccolta Fërvaje 2013, ossia It é ‘Tu sei’, un testo incredibilmente ricco di immagini, intessuto di una vitalità quasi ottimistica: It é l’eva dël poss / ch’a smòrta la sèj / a bestie e cristian.// It é la pieuva dossa / dl’aprim / ch’a serca la rèis pì profonda.// It é na canson lontan-a / compagna dël vent e dla neut.// It é la lun-a spària / ch’a passa, a fa cèr / e dòp un mèis a j’é torna.// Për tut cos it dè / l’anada dël cheur e dij sògn / as fa bon-a. (‘Sei l’acqua del pozzo / che spegne la sete / ad animali e uomini. // Sei la pioggia dolce / della primavera / che cerca la radice più profonda. // Sei una canzone lontana / compagna del vento e della notte. // Sei la luna pallida / che passa e fa luce / e dopo un mese c’è di nuovo. // Per tutto quel che dai / l’annata del cuore e dei sogni / si fa buona’).
Una poesia stupefacente, per chi conosce la cifra “classica” di Rinaudo, cristallizzata nella disincantata e malinconica contemplazione eroica dei fallimenti esistenziali scanditi dal tempo, come in Agost (‘Agosto’): La vampa dij falò / a brusa tuti ij sògn / prima dla sèira. / La neut e ’l vent / i pòrto sofi ’d dësperassion / e ’l bate lontan ëd n’ora përdùa. / L’istà o meura / sensa le stèile. (‘La fiamma dei falò / brucia tutti i sogni / prima della sera. / La notte e il vento / portano soffi di disperazione / e il battere lontano di un’ora perduta. / L’estate muore / senza le stelle’); oppure nella decrittazione dei segni che una mano misteriosa disegna sui muri, sull’asfalto delle strade, sui volti delle persone incrociate nelle piazze cittadine: j’eva dij sègn / ënt ël primavere dla mia gioventù / quand l’ànima a cantava e a svantava / come la lëssìa al so e al vent ëd mars… (‘c’erano dei presagi / nelle primavere della mia gioventù / quando l’anima cantava e sbatteva / come il bucato al sole e al vento di marzo…’), mace d’ariso pitòco ’l man e la facia, / la pel a l’é ’n linseu trasparent / campà sui grop ëd ven-e nèire / e sui cordin tirà dij nerv ch’i coro sota… (‘macchie di ruggine punteggiano le mani e il viso / la pelle è un lenzuolo trasparente / buttato sui nodi di vene nere / e sulle corde tese dei nervi che corrono sotto…’). Anche i titoli delle raccolte danno il senso di quest’orientamento tematico e attitudinale: Fio’ feura stagion (‘Fiori fuori stagione’, 1991), J’eva dij sègn (‘C’erano segni’, 1994), Memòrie e spin-e (‘Memorie e spine’, 2002), Ricòrd e silensi (‘Ricordi e silenzi’, 2010). Una poesia profondamente piemontese, non solo per la lingua usata: è la visione del mondo che ne emerge ad essere in perfetta sintonia con l’ideale rettitudine esistenziale del galantòm sabaudo di antico stampo, capace di guardare in faccia senza tremare la terrificante maschera tragica del mondo.