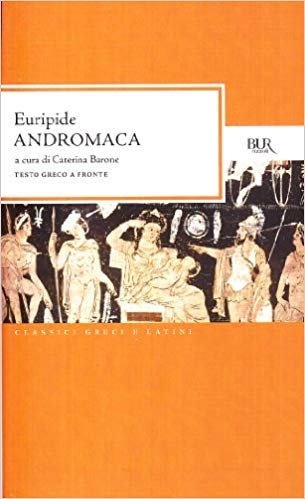GABRIELLA MONGARDI
L’idea per queste considerazioni mi è venuta dalla lettura di un libro, Donne e potere di Mary Beard, edito da Mondadori a febbraio 2018 nella traduzione di Carla Lazzari, o meglio dal suo sottotitolo: «Per troppo tempo le donne sono state messe a tacere». La Beard, professoressa di Antichità Classiche a Cambridge (UK), rielabora per questo libro il testo di due conferenze da lei tenute nel 2014 e nel 2017: La voce pubblica delle donne e Donne e potere. Ne risulta un testo di facile lettura, molto discorsivo e chiaro, data la sua origine “orale”: la tesi è che, da sempre, la voce femminile è stata negata, svilita, derisa, temuta e quindi ridotta al silenzio, o confinata in ambiti ben precisi e ristretti, che è la stessa cosa – come se l’unica voce degna di essere ascoltata su temi di pubblico interesse, l’unica capace di produrre un vero discorso “sensato” fosse “naturalmente” quella maschile…
Nel primo contributo la Beard parte dal primo canto dell’Odissea, dal passo in cui Telemaco ordina alla madre Penelope di tornare nelle sue stanze a badare ai lavori femminili, perché «parlare è cosa da uomini, e spetta soprattutto a me, che ho il comando della casa», e lo accosta alle ingiurie da lei ricevute, via Twitter, per essere diventata una celebrità televisiva, cioè per il fatto di parlare in pubblico. Poi la Beard fa altri esempi di questo disprezzo antico per la parola femminile, e sempre li proietta sul presente.
Cita Aristofane, commediografo greco del V-IV sec. a.C., che nella sua opera Ecclesiazouse considera una cosa comica le donne riunite in assemblea politica; cita «un famoso intellettuale del II sec. d.C.» secondo cui «una donna dovrebbe modestamente guardarsi dall’esporre la propria voce a estranei, così come si guarderebbe dal togliersi i vestiti»; cita i miti di Eco, di Filomela, di Io narrati da Ovidio nelle sue Metamorfosi, e accomunati dal fatto che le tre giovani donne sono private della parola umana durante il processo di trasformazione. A Filomela viene tagliata la lingua dal suo violentatore perché non possa denunciarlo, e poi sarà trasformata in usignolo; Io viene trasformata in mucca ed Eco, trasformata in roccia, è condannata a ripetere solo la parte finale delle parole che sente: così riecheggia quelle di Narciso — di cui è innamorata senza essere ricambiata — diventando, si potrebbe dire, strumento del narcisismo maschile. Tutti e tre i miti riflettono l’assunto che alle donne spetta il silenzio, ma quello di Filomela, che anche senza lingua continua a emettere un mormorio, racchiude un altro stereotipo maschilista antico e moderno: la voce femminile è “naturalmente” portata a produrre solo lamento. E a questo proposito la Beard ricorda che, di fronte all’accusa di avere una voce lamentosa, inadatta alla politica, Margaret Thatcher decise di prendere lezioni di dizione — maschile, s’intende…
«Tanta mutezza – scrive la Beard – non è semplicemente il riflesso della generale espropriazione del potere cui furono sottoposte le donne in tutto il mondo classico: niente diritto di voto, niente indipendenza legale, limitata indipendenza economica e così via. Certo, è anche questo, ma lo è solo in parte. […] Qui siamo di fronte a un’esclusione che è stata molto più attiva e insidiosa […]. Il discorso pubblico e l’oratoria non erano semplicemente attività che le donne del mondo antico non svolgevano, ma erano pratiche e attività esclusive, che definivano la mascolinità in quanto genere.»
Le donne nell’antichità avevano diritto di parlare in pubblico esclusivamente a difesa dei propri interessi settoriali oppure per esporre la propria condizione di vittime (è il caso delle martiri cristiane, ad esempio) – e anche oggi avviene così: il discorso pubblico femminile è perlopiù relegato nella nicchia delle cause delle donne, «esiste ancora, e su larga scala, una terribile resistenza allo sconfinamento femminile nei territori discorsivi tradizionalmente ritenuti maschili».
Un episodio esemplare è quello che è accaduto nel 2008 a Rebecca Solnit, una scrittrice e saggista californiana. A una festa ad Aspen un signore pretende di parlarle di un libro che lei aveva scritto e che gli ha appena citato, non considerando minimamente quello che lei gli stava appunto raccontando, «con quello sguardo compiaciuto che conosco bene in un uomo intento a pontificare, gli occhi fissi sul lontano e indistinto orizzonte della propria autorità». Fino a quando un’amica di Solnit interrompe il siparietto surreale per chiarire, definitivamente: «Lo ha scritto lei». Da questo episodio è stato creato addirittura un neologismo, mansplaining (“la spiegazione maschile”) e una pagina web (Academic Men Explain Things to me), dove tante donne del mondo universitario hanno condiviso le umiliazioni subite da colleghi saccenti e arroganti.
Questo cortocircuito tra passato e presente dimostra come il patrimonio culturale e letterario della Grecia e di Roma antica abbia plasmato convinzioni, pregiudizi e comportamenti che ancora perdurano e sembrano “naturali”, non solo ai maschi… Questo però non significa mettere al bando il mondo classico: basta “storicizzarlo” e “relativizzarlo”.
Nel secondo contributo della Beard il punto di partenza è invece un romanzo uscito nel 1915, Herland (La terra di lei), in cui l’autrice Charlotte Perkins Gilman immagina uno Stato ideale, pulito e ordinato, solidale e pacifico, abitato e retto soltanto da donne, che si riproducono per partenogenesi generando solo femmine, ma quando arrivano tre uomini – a metà fra lo smidollato e la canaglia, non tre eroi – le donne sono prese da una sorta di timore reverenziale per i maschi e si convincono di avere sbagliato tutto, perché non sono consapevoli del loro valore. Di qui la Beard indaga su un nodo fondamentale, la persistente misoginia nella politica e nel lavoro, perché la nostra concezione convenzionale del potere e dei suoi “attributi” è ancora nettamente maschile. Anche in questo caso, il mondo classico ci propone alcune figure femminili “potenti”, quali Clitemnestra, Antigone, Medea – ma la logica inflessibile della storia di ognuna di loro è che devono essere spogliate del potere acquisito e rimesse al loro posto: non sono fruitrici del potere, ma usurpatrici. E questa prospettiva sembra essere in vigore ancora oggi, se si considerano anche solo le espressioni usate per parlare dell’ascesa al potere delle donne («bussare alla porta, espugnare la cittadella, demolire la barriera…»): sottolineano tutte che le donne sono delle outsider, e che le donne “potenti” sono ancora l’eccezione, non la regola – non solo numericamente, statisticamente, ma nella mentalità corrente, perché il potere viene ancora visto come un possesso che soltanto pochi, quasi tutti uomini, possono detenere o esercitare. Il che è strettamente connesso con il silenzio imposto alle donne sulle questioni pubbliche, con il fatto che la voce delle donne non è ascoltata: può esserlo individualmente, non collettivamente. Mentre le donne hanno diritto a essere prese sul serio, e non ridimensionate d’ufficio.
Fin qui la Beard. Adesso proseguirò io sulla strada da lei indicata e partirei, ancora una volta, dall’antica Grecia, per la precisione da due tragedie imperniate intorno a figure femminili: l’Antigone di Sofocle e l’Andromaca di Euripide. Non è il caso di ricordare la fondamentale importanza di questo genere letterario per la cultura e l’immaginario della nostra civiltà, e questo perché – come insegna Nietzsche – nella tragedia greca antica erano compresenti l’elemento apollineo (la razionalità, la compostezza formale, la misura) e l’elemento dionisiaco (che è ebbrezza, estasi, follia) e quindi parlava sia alla mente che al cuore dello spettatore, riproponendo un episodio perlopiù del mito già ben noto a tutti, ma con un’interpretazione, un taglio, un “montaggio” nuovo. Il mito era così agganciato all’attualità, all’epoca in cui l’opera veniva rappresentata, ma le tematiche affrontate – che so, la concordia tra i cittadini, la libertà di parola, il discorso sul potere, la condizione dell’esule e della donna, la supremazia della legge – sono temi di grande, perenne attualità…
Nella prospettiva che qui interessa, l’Antigone dell’omonima tragedia di Sofocle è una figura ambivalente, interpretabile cioè sia come esempio di donna indipendente, capace di giudizio autonomo e tanto forte e sicura di sé da osare opporsi al sovrano, sia come conferma del fatto che l’autorevolezza femminile viene riconosciuta solamente per quanto riguarda le questioni famigliari, e che comunque la voce delle donne va messa a tacere, in un modo o nell’altro. Qui, ovviamente, nel modo più tragico.
Sofocle in questa tragedia, rappresentata per la prima volta ad Atene nel 442 a.C., riprende un episodio del ciclo tebano, quello che ruota intorno al mito di Edipo, di cui Antigone è appunto figlia: figlia-sorella, per la precisione, perché Edipo aveva sposato la propria madre, Giocasta, e da lei aveva avuto quattro figli, due femmine – Antigone e Ismene – e due maschi, Eteocle e Polinice. Dopo che Edipo era andato in esilio, i due fratelli erano venuti alle armi per il trono di Tebe e nel duello si erano dati reciprocamente la morte. Il nuovo re di Tebe, Creonte, fratello di Giocasta e quindi zio di Antigone e dei suoi fratelli, aveva decretato che il cadavere di Polinice non ricevesse sepoltura, ma Antigone si oppone a questo editto in nome di una legge più alta di quella dell’uomo, cercando nottetempo di seppellirlo. Scoperta, viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie dell’indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma troppo tardi, perché Antigone nel frattempo si è suicidata impiccandosi. Questo porta al suicidio il figlio di Creonte, Emone, che era il promesso sposo di Antigone, e poi la moglie di Creonte, Euridice, lasciando Creonte solo a maledire la propria stoltezza.
È doverosa una premessa. Sofocle, da quel grande artista che è, non prende posizione, non si schiera da una parte o dall’altra (a meno che non si voglia prendere il titolo come indizio della sua “simpatia” per Antigone…): la tragedia pone un problema, un problema immenso (lo scontro tra una legge dello Stato e la voce della coscienza) ma non lo risolve, lasciando allo spettatore il compito di trovare lui una soluzione, se ci riesce, o di rimanere profondamente turbato e perplesso nel rendersi conto che ciascuno dei due personaggi ha le sue valide ragioni, inaccettabili dal punto di vista dell’altro. Antigone rivendica orgogliosamente la superiorità delle “regole non scritte, incrollabili, degli dei”, eternamente valide, rispetto alle leggi degli uomini, “convenzionali”, frutto del patto sociale necessario per realizzare una convivenza il più possibile pacifica fra esseri umani.
In una società come quella dell’antica Grecia, dove la politica è appannaggio esclusivo degli uomini, non è poco che sia una giovane donna ad avere il ruolo di dissidente. La ribellione di Antigone non riguarda soltanto la sottomissione al nomos del re, ma anche il rispetto delle convenzioni sociali che vedevano la donna sempre sottomessa e rispettosa della volontà dell’uomo (in tutta la Grecia ma ancor più ad Atene). Creonte trova intollerabile l’opposizione di Antigone non solo perché si contravviene a un suo ordine, ma anche perché a farlo è una donna, anche se la sua azione non è rivolta a scardinare le leggi su cui si fonda la polis, ma solo a tutelare i suoi affetti famigliari. Infatti conclude il suo botta-e-risposta con Antigone (la sticomitia dei vv. 508-525) con un perentorio: «Finché io sarò vivo, non comanderà una donna».
Forse Sofocle ha volutamente contrapposto la (super)potenza maschile alla debolezza, all’impotenza femminile, come indicano i nomi stessi dei personaggi: Creonte significa “il potente”, Antigone “quella che è nata contro”; certamente nella tragedia la voce di Antigone risuona alta e convincente a proclamare la sua tesi: esistono leggi non scritte e indistruttibili, quelle degli dei, che nessun uomo può calpestare con le sue leggi, e nel corso dell’azione scenica, grazie all’intervento dell’indovino Tiresia, Creonte arriverà a modificare il suo decreto e a concedere sepoltura a Polinice: ma Antigone non trionferà, perché nella sua inflessibilità avrà preferito la morte – sarebbe stato troppo “scandaloso” per il maschilismo dei tempi “premiarla” lasciandola in vita.
Ai fini del mio discorso, è molto significativo il fatto che a sostenere questa tesi sia una figura femminile: è il riconoscimento della radicale alterità della sensibilità femminile rispetto a quella maschile, e Creonte stesso ne è sconcertato (v.510): Non ti vergogni, a pensare “fuori dal coro”?
Creonte – come ancora tanti maschi odierni, purtroppo – non concepisce che una donna possa sviluppare un pensiero autonomo, avere idee proprie e per giunta diverse o addirittura opposte a quelle della società cui appartiene e che osi esprimerle, ribellandosi alla sua autorità. Così accusa Antigone di hybris e sbotta: Non sono io il maschio, maschio è lei. Hybris, arroganza, nel mondo greco è la colpa peggiore dell’uomo, che non riconosce i suoi limiti di fronte agli dei: Creonte si assimila addirittura a un dio, rispetto ad Antigone… Ma quella di Antigone non è hybris, è la forza di chi è abituata a non contare niente, a non essere nessuno, e quindi non ha nulla da perdere (vv. 460-462): Il mio futuro è morte, lo sapevo, è naturale […] Se morirò prima del tempo, tanto di guadagnato, mi risparmierò delle sofferenze. È anche la forza, la libertà interiore di chi sa guardare in faccia il proprio destino di morte ed è consapevole che la differenza tra lei e Creonte è irriducibile (vv. 499-501): Tu hai le tue ragioni, che io non condivido. Lo stesso vale per te: le mie ragioni ti sono per natura sgradevoli. Ma può anche darsi che a essere irriducibile sia la differenza tra uomo e donna: in questa chiave, da questo punto di vista, lo scontro tra Antigone e Creonte può essere letto come “messa in scena” dell’opposizione tra mentalità maschile e femminile e rappresentazione emblematica dei tanti “femminicidi” che punteggiano la storia e, purtroppo, le cronache.
Da giovane pensavo che la contrapposizione tra uomo e donna fosse dovuta solo a motivi culturali, di educazione e trasmissione di modelli stereotipati dei diversi ruoli sociali di maschi e femmine, ma c’è indubbiamente anche una base “naturale” dovuta alla diversa anatomia e funzionamento del cervello, agli ormoni, al ruolo biologico; la cultura interviene decretando e perpetuando l’inferiorità delle donne, anziché accettarne la pari dignità nella diversità. Lo psicanalista Massimo Recalcati, nel suo libro I tabù del mondo (Einaudi 2017), mette bene in risalto la difficoltà di accettare l’Altro – e la donna è, per un uomo, l’Altro per eccellenza, «è il nome più radicale del segreto impossibile da decifrare». Alla base c’è l’invidia, che per la psicanalisi scaturisce da un sentimento di impotenza e di dipendenza (quella del bambino nei confronti del seno materno, che lo nutre ma non gli appartiene) e mira a distruggere l’alterità dell’Altro per ribadire un’illusoria indipendenza del soggetto: la prima e più profonda “invidia” – un’invidia “biologica” – è quella dei maschi per le femmine, per la possibilità di generare e allattare che la donna ha e l’uomo no. Non potendo dare la vita, l’uomo dà la morte e inventa la guerra, da un lato – dall’altro, inventa mille modi per tenere sotto il suo controllo la donna: prescrizioni religiose, leggi, tradizioni, convenzioni, abitudini… Ecco, di questa contrapposizione Sofocle, nello scontro tra Creonte e Antigone, ci dà la più nitida rappresentazione, o meglio l’archetipo, il “prototipo”.
Un’altra figura emblematica è Andromaca, quale appare nell’omonima tragedia di Euripide, composta tra il 427 e il 425 a.C.: un personaggio grande per la sua capacità di accettare il destino avverso senza odiare nessuno, saggia, energica, magnanima. Andromaca era una principessa di Tebe andata in sposa all’eroe troiano Ettore, a cui aveva generato un figlio, Astianatte (che il padre chiamava Scamandrio). La sua vita felice termina con la caduta di Troia: Ettore viene ucciso in duello da Achille, Troia messa a ferro e fuoco, il bambino scaraventato giù dalle mura, la madre portata schiava a Ftia, in Tessaglia, da Neottolemo, il figlio di Achille, che la fa sua concubina e genera da lei un figlio, Molosso. Questo lo sfondo mitologico su cui Euripide innesta la sua tragedia, che si apre con Andromaca rifugiatasi nel tempio della dea Tetide per sfuggire alla rabbia di Ermione, la moglie di Neottolemo, che vuole ucciderla per gelosia.
ERMIONE
Sciagurata, sei tanto demente da andare a letto col figlio dell’uomo che ha ucciso tuo marito, da generare figli ad un assassino. Ma già, i barbari sono fatti così . Il padre si accoppia con la figlia, il figlio con la madre, il fratello con la sorella, i parenti più stretti si ammazzano tra di loro, e non c’è legge che lo vieti.
Non pensare di introdurre fra noi usanze del genere. Non è bello che uno stesso uomo metta le redini a due donne: no, da noi chi non vuole vivere nella vergogna, si accontenta e riserva la sua attenzione a un solo amore coniugale.
CORO
L’animo femminile è soggetto alla gelosia, una donna non può che aborrire le rivali.
ANDROMACA
Brutta faccenda, per i mortali, la giovinezza e, ancor più la mancanza di giustizia nella giovinezza. Ho paura che l’essere tua schiava mi impedisca di parlare, anche se ho dalla mia molte buone ragioni. Se poi dovessi avere la meglio, temo di attirarmi dei guai. La gente superbiosa sopporta male di essere vinta dagli inferiori. Ma nessuno mi sorprenderà a tradire me stessa.
(da http://www.miti3000.it/mito/biblio/euripide/andromaca.htm)
Benché straniera e schiava, Andromaca tiene testa alla rivale e a suo padre, il potente re di Sparta Menelao, non teme di esporre le proprie ragioni né esita a rimproverarla, ed è pronta a morire sia per salvare il figlio, sua unica ragione di vita, sia per non tradire se stessa e i suoi valori di fedeltà, coraggio, abnegazione.
Anche se la presenza di Andromaca sulla scena è limitata alla prima metà della tragedia (primi tre episodi), è la sua statura morale e la sua capacità di esprimerla in “discorsi migliori” (v.189) a fare di lei l’indiscussa protagonista del dramma. “Il discorso migliore” è espressione appartenente al linguaggio sofistico, per indicare la potenza della parola sostenuta dalla tecnica retorica in opposizione al “discorso senza forza persuasiva”, e perciò destinato a non imporsi. Ma anche il “discorso migliore” di Andromaca soccombe di fronte alla forza, e lei ne ha lucida consapevolezza.
Si noti il commento “maschilista” del coro, che pure è costituito da donne di Ftia… Altre volte il coro, portavoce del senso comune, zittirà addirittura Andromaca, con il motivo formulare dell’“hai parlato troppo, per essere una donna”.
Ma Euripide no: l’autore lascia spazio alla parola di una donna, per di più schiava, e questo non stupisce in lui, per tanti aspetti scandaloso e “anticonformista”: ad esempio gli dei di Euripide sono crudeli e vendicativi, oppure lontani – come Apollo in questa tragedia – e nella sua produzione teatrale si assiste a un processo di destrutturazione della forma tragica, evidente qui nel finale “aperto” , in cui la dea ex machina, Tetide, annuncia un avvenire prospero per la stirpe di Neottolemo e, attraverso Andromaca, per i Troiani. E tutte queste novità del suo teatro – filosofiche e strutturali – condannarono Euripide a non avere gran successo in vita…
Se tutto il teatro greco è sostanzialmente un “teatro di parola”, il teatro di Euripide lo è in modo particolare: questa tragedia ad esempio si snoda attraverso il confronto scenico di coppie antagonistiche (Andromaca-Ermione, Menelao-Peleo, Oreste-Neottolemo), all’interno delle quali i personaggi assumono un loro profilo, definendosi per contrasto – e sono tutte figure “a tutto tondo”, con una netta caratterizzazione psicologica. La cifra di Andromaca, la sua grandezza, è secondo me nella totale assenza di risentimento, nell’equilibrio profondo della sua personalità. Caterina Barone nell’introduzione alla sua traduzione dell’opera rileva:«Al centro dell’universo euripideo c’è l’individuo capace di trovare in sé la forza per reagire ai colpi della sorte, come Andromaca, affranta ma non domata dai lutti, che ha tenuto testa con coraggio ai suoi persecutori e non ha mai rinunciato alla propria dignità di persona». Appunto perché non si abbandonata alla rabbia, al rancore, al risentimento. E questo grazie alla sua padronanza del discorso, alla parola.
Se confrontiamo la figura di Andromaca con quella di Antigone, notiamo analogie e differenze: come Antigone è sola, regale, magnanima ma, a differenza di lei, è una donna matura, moglie e madre, che rimane sì ancorata al passato felice, per rimanere se stessa, per non rinnegarsi, ma sa accettare realisticamente il doloroso presente, valorizzando ciò che di positivo c’è in esso (ossia il figlio, che Andromaca chiama sempre “mio figlio”), e affidandosi a sé.
Il fatto poi che Andromaca in questa tragedia resti in vita, a differenza di Antigone, secondo me simboleggia appunto un atteggiamento più aperto verso la donna e il suo diritto di prendere la parola e di essere ascoltata; e se è vero che il discorso di Andromaca è di carattere sostanzialmente “privato”, relativo cioè alla sue disgrazie personali, nelle sue argomentazioni lei tocca anche temi “pubblici”, se non politici perlomeno etici, come quando a Ermione che sprezzantemente afferma: «Nella nostra città non si seguono usi barbari» ribatte: «Un’azione, se è vergognosa, lo è sia qui che là» (vv. 243-4)
Se passiamo all’attualità, tra le recenti vicende di cronaca un esempio per me scandaloso di “distorsione” del giudizio e di “silenziamento” della voce delle donne è quello che si potrebbe chiamare “l’affare ME TOO”. Com’è noto, ME TOO è l’hashtag che contraddistingue un movimento di opinione nato con il caso Harvey Weinstein, il famoso produttore cinematografico americano accusato di aggressioni sessuali – dalle molestie alla violenza – in due articoli comparsi ai primi di ottobre del 2017 sul New York Times e sul New Yorker. In seguito a questi articoli, molte altre attrici hollywoodiane hanno accusato Weinstein di fatti simili, che duravano addirittura da trent’anni, ma su cui si era sempre preferito sorvolare: tra queste Asia Argento, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, per citare solo le più famose. Weinstein naturalmente smentisce di avere avuto delle relazioni sessuali con donne non consenzienti, ma lo scandalo scoppia, la casa produttrice cinematografica Weinstein Company entra in crisi e nel marzo 2018 dichiara fallimento, il produttore è indagato dall’autorità giudiziaria.
L’attrice statunitense Alyssa Milano incoraggia allora le donne a raccontare il proprio vissuto lanciando l’hashtag #metoo su Twitter. Riceve più di 65.000 risposte da tutto il mondo, che accusano molte altre personalità del cinema e dello spettacolo, o dello sport, della politica, del mondo universitario.
Tutto bene quindi, dal punto di vista della voce delle donne? Sì e no. Sì, perché le donne hanno finalmente trovato il coraggio di parlare, di denunciare “l’abuso di potere” perpetrato nei loro confronti da Weinstein, che – come tanti suoi “colleghi” – imponeva alla malcapitata di turno rapporti carnali in cambio di una parte in un film, o di un contatto utile per la carriera.
No, per le reazioni che ci sono state, anche da parte di donne. Ne cito solo una, Catherine Deneuve. La bravissima e famosissima attrice ha pensato bene di richiamare le donne alla prudenza (prudenza? e di chi verso chi?) e di invitare a non confondere avances e molestie, quando anche una adolescente sa che le avances sono tali quando lei le gradisce e quando c’è reciprocità nel desiderio e smettono immediatamente di esserlo quando invece sono atti subiti.
Da parte maschile, la “difesa” dei vari Weinstein derubricava ogni molestia ad avance, e soprattutto argomentava che il “no” di una donna significa “forse”, il “forse” significa “sì”: perché una signora “sì” non lo dice mai… La parola della donna viene così manipolata e distorta dall’interpretazione del maschio, che “violenta” innanzitutto la sua lingua, negandole il diritto di esprimere limpidamente e “naturalmente” il proprio desiderio erotico…
Ha scritto sul domenicale del Sole24Ore (19-11-17, p.29) la giornalista, scrittrice e saggista Elisabetta Rasy: «La parola femminile sconta un ritardo infinito per essere stata tacitata da un inviolabile obbligo di silenzio lungo tutto il corso della storia. È davvero da molto poco che ha conquistato uno spazio pubblico, e solo qua e là nel mondo uno spazio di ascolto. Ed è un ritardo certamente colpevole, essendo la colpa però non di chi non può parlare ma di chi impedisce all’altro di farlo: non è un silenzio qualsiasi, è l’impossibilità di parola che sempre si verifica quando c’è uno sbilanciamento dei poteri, uno squilibrio dei diritti. In materia di donne è proprio ritardo la parola chiave. Lo incontriamo in ogni campo della vita femminile e non è difficile scorgere il nesso tra questo ritardo e la violenza. Dai ritardi del passato (siamo sicuri di ricordare che solo nel 1981 vengono abrogate le norme del codice penale relative al delitto d’onore?) a quelli di oggi la situazione non è meno grave. Di violenza parlano chiaramente le cifre. Per esempio quelle di una recente ricerca del World Economic Forum sul divario di genere nel mondo, i cui parametri non sono la ridda delle opinioni contrapposte ma elementi precisi, cioè economia, politica, salute, formazione. Ci vorranno, secondo le previsioni, cento anni per colmarlo, questo divario. L’Italia, rispetto ai quattro parametri, è all’ottantaduesimo posto (dopo Burundi, Bolivia, Mozambico…), ma se si considerano invece solo i parametri della situazione economica e della salute scende al 118° posto. Salute e denaro, cioè utensili della sopravvivenza. Come è possibile che chi sia in una posizione così precaria possa difendersi dagli agguati della violenza? La precarietà crea dipendenza, fragilità, sottomissione, cioè potenziale esposizione alla violenza. E non riguarda soltanto le più sfortunate e le più derelitte: è vero, c’è anche chi guadagna bene e chi può curarsi, ma se non c’è parità diffusa che possa penetrare nelle menti e nei cuori e nel corpo collettivo della società, non c’è sicura difesa dalla violenza. E non c’è sicurezza senza giustizia, se non sono tutelate tutte le donne non lo è nessuna». Ma finché questa convinzione non diventa sentire comune, la voce delle donne non avrà potere.