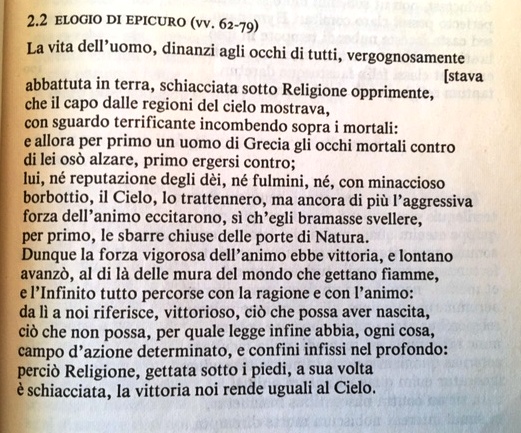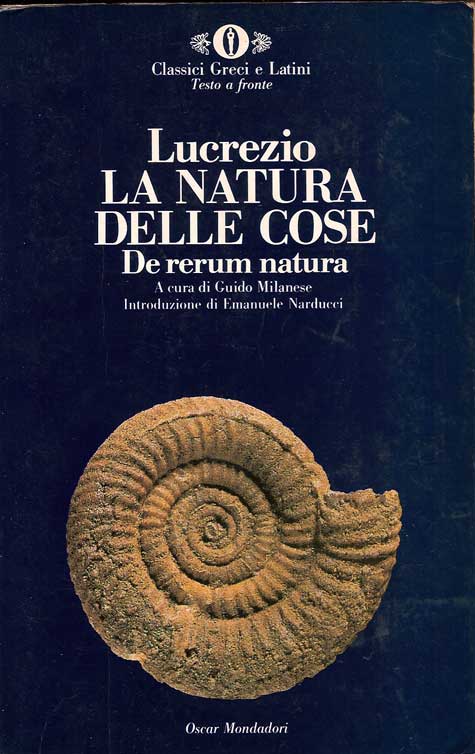GABRIELLA MONGARDI
Riprendo volutamente il titolo di un mio precedente lavoro su Ariosto, non solo perché nel De rerum natura di Lucrezio il lettore è chiamato continuamente in causa, ma anche perché, da quando all’università ho frequentato il corso di estetica del prof. Pareyson, ritengo che il ruolo del lettore sia fondamentale, sia assimilabile a quello del musicista che interpreta un brano musicale: una pagina scritta rimarrebbe muta, inutile, senza un lettore, come uno spartito senza un suonatore…
E se oggi i lettori determinano il successo commerciale di un autore, nel caso degli autori antichi, latini e greci, i lettori ne hanno determinato la sopravvivenza tout court. Prima dell’invenzione della stampa, infatti, i manoscritti venivano ricopiati a mano da chi voleva leggerli ed è stata la catena secolare delle trascrizioni a permettere che arrivassero fino a noi – cioè fino alle prime edizioni a stampa, nel XV sec., che garantendo la riproducibilità meccanica dei libri hanno segnato una svolta radicale nella loro storia, sottraendola alla precarietà materiale e alla limitatezza della diffusione.
Ma di tutto questo Lucrezio, nel I sec. a. C., ovviamente non si preoccupava: a lui interessava soltanto che il suo poema filosofico sulla natura, il De rerum natura appunto, raggiungesse i lettori a cui si rivolgeva, ossia la classe dirigente della Roma del suo tempo, rappresentata nell’opera dal destinatario Gaio Memmio, un aristocratico attivamente impegnato nella politica, perché si “convertissero” all’epicureismo, o almeno abbandonassero il loro antiepicureismo. L’epicureismo, la visione del mondo elaborata da Epicuro ad Atene tre secoli prima, era per Lucrezio, come per tutti gli altri seguaci di quel maestro, una vera e propria religione, una religione dell’uomo, razionale, immanente, materialistica, che affida all’uomo stesso la responsabilità della propria felicità, facendola consistere in un atteggiamento pratico, di controllo dei bisogni e delle ansie, che è alla portata di tutti. A tale finalità etica sono subordinate sia la teoria della conoscenza sia la fisica che sono alla base del sistema epicureo: infatti, secondo Epicuro, ciò che impedisce all’uomo di essere felice sono paure irrazionali, in primis quella della morte, o desideri altrettanto assurdi, come l’ambizione politica, dai quali l’uomo si può liberare grazie appunto alla conoscenza vera della Natura e di se stesso. La fisica di Epicuro – che riprende Democrito – è rigorosamente materialistica: ogni cosa è formata dall’aggregazione di “atomi” in movimento nel vuoto, e anche l’anima non è altro che un aggregato di atomi, perciò non è eterna, ma si dissolve insieme col corpo. Ne consegue che la morte non ci riguarda, perché quando esiste l’uomo non c’è la morte, e quando c’è la morte non esiste più l’uomo, sicché è assurdo averne paura. Infondato è pure il timore degli dei: Epicuro non ne nega l’esistenza, ma sostiene che gli dei vivono un’esistenza serena e imperturbata, e sono del tutto indifferenti alle vicende del cosmo e in particolare a quelle degli uomini. Partendo da queste premesse, Epicuro afferma che principio e fine dell’agire umano, autentico bene e unica fonte di felicità è il piacere (edoné), inteso come assenza di dolore fisico (aponìa) e di turbamenti dell’animo (ataraxìa): è una definizione puramente negativa, minimale; per Epicuro “essere felice” significa semplicemente “non soffrire”. Virtù suprema è la saggezza (frònesis), che aiuta l’uomo a selezionare i suoi bisogni, distinguendo tra quelli naturali e necessari, il cui soddisfacimento è sempre possibile e appagante, in quanto finalizzato alla conservazione della vita, e gli altri bisogni, non naturali e non necessari (quali il desiderio di ricchezza e di potere), fonte di dolore e di turbamenti. Anche il partecipare alla vita pubblica, il far politica è causa di agitazione per l’animo: per questo Epicuro consiglia al saggio la vita appartata, il “vivi nascosto”; questo invito peraltro non va inteso tanto come un’esortazione all’individualismo assoluto, alla chiusura egoistica in se stessi, quanto nel senso di un richiamo all’interiorità e all’unicità dell’esperienza personale – e del resto il motivo individualistico risulta temperato sia dal legame dell’amicizia, che Epicuro vivamente raccomanda come sicura fonte di piacere, sia dall’appello ad una filantropia estesa a tutta l’umanità: “Fare il bene è più dolce che riceverlo”. L’insegnamento etico di Epicuro era condensato in quattro comandamenti, costituenti il cosiddetto tetrafàrmakos, la quadruplice medicina: non temere gli dei, non temere la morte, comprendere che il giusto piacere è facile a procurarsi e che il dolore si sopporta altrettanto facilmente con il coraggio. Tale insegnamento – cosa del tutto inconsueta nell’antichità – era messo a disposizione di tutti, tant’è che nella scuola di Epicuro, detta “Il Giardino” perché le riunioni si tenevano appunto in un giardino, erano ammessi anche gli schiavi e le donne, con grande scandalo degli antichi; tipico dell’epicureismo è infatti un atteggiamento missionario, una vera e propria volontà redentiva, legata alla certezza di avere in mano la risposta definitiva al problema della vita.
A questo afflato missionario, a questo pathos salvifico non sfugge Lucrezio che, sulle orme dei filosofi presocratici, mette in versi la dottrina di Epicuro, componendo un poema didascalico in esametri dattilici. L’opera si articola in sei libri raggruppati in tre coppie o diadi: nella prima diade viene esposta la fisica epicurea, nella seconda l’antropologia, nella terza la cosmologia epicurea. Nei primi due libri la materia e il vuoto costituiscono lo scenario cosmico che fa da sfondo ai movimenti e alle combinazioni degli atomi, gli “elementi primi” che compongono tutte le cose. Nei libri III e IV tale dottrina fisica è posta a fondamento dei fenomeni del mondo umano: vengono illustrate la mortalità dell’anima e le basi materiali di quello che noi oggi chiameremmo la psicologia e la fisiologia. La terza coppia di libri ha per oggetto la cosmologia, la spiegazione dell’universo: il libro V dimostra la mortalità del mondo, in evidente simmetria con l’analoga dimostrazione svolta per l’anima nel libro III, e ne narra la storia, con particolare attenzione all’evoluzione del genere umano dalla primitiva condizione animalesca fino alla civiltà. Il VI cerca di fornire spiegazioni di vari fenomeni fisici, come i fulmini, i terremoti o le eclissi, estromettendone la potenza e la volontà degli dei e sottolineandone la “necessità” naturale, date certe leggi fisiche.
Convinto com’era che Epicuro avesse scoperto la Verità ultima delle cose e consapevole dell’importanza vitale degli argomenti affrontati, Lucrezio sfida il suo lettore, chiamandolo ad aprire la sua mente e ad abbandonare vecchie convinzioni fallaci, chiamandolo a diventare un “illuminato”, “sublime” tanto sul piano intellettuale che su quello morale, così da essere capace di comprendere e accogliere un insegnamento tanto alto. In questa sfida Lucrezio mette in gioco tutto se stesso: se Memmio nel corso della lettura non giungesse a condividere le idee epicuree, l’autore avrebbe fallito, il suo poema sarebbe da buttare.
Ma, secondo la retorica antica, di fronte a una scrittura alta, a una poesia forte è il lettore stesso a produrre sublimità, in quanto il testo lo chiama a lasciar affiorare il suo pathos. Non per niente Lucrezio spesso previene le possibili reazioni del lettore, dalle obiezioni razionali alle risposte emotive, istintive – e questo è forse un modo per sollecitarle, per invitare il lettore sublime a riconoscersi nel testo… come se dalla lettura emergesse un’esperienza latente, che è il destinatario stesso a produrre. Autore e lettore si trovano sullo stesso piano: entrambi sono reverenti spettatori spinti a commuoversi di fronte alla Natura; in entrambi (prima nel poeta, poi per suo tramite nel lettore) il sublime trova il suo campo d’azione.
L’atteggiamento che Lucrezio richiede al suo lettore di fronte alle leggi della Natura che lui gli svela è l’impassibilità, cioè l’assenza sia di stupore che di paura: nil admirari, non stupirsi di nulla, è l’invito più volte ripetuto; le cose stanno così, dobbiamo prenderne atto, e basta: alla retorica del mirabile si sostituisce la retorica del necessario; e questa non può che produrre l’esaltazione dell’individuo, consapevole ora della propria grandezza intellettuale (cfr. G.B. CONTE, Insegnamenti per un lettore sublime, in ID., Generi e lettori, Mondadori, Milano 1991).
Alle esortazioni al lettore, alla tensione verso il destinatario, che si esprime in innumerevoli apostrofi e appelli pieni di sollecitudine, fanno da pendant gli elogi di Epicuro, con cui si aprono quattro dei sei libri del poema (I-III-V-VI). Si crea così una catena per la trasmissione del sapere salvifico: Epicuro è la fonte, “colui che per primo scoprì la scienza della vita”; è il maestro, è un dio; Memmio, il lettore del De rerum natura, è il destinatario, il punto d’arrivo del messaggio che la conoscenza scaccia la paura e che la felicità è a portata di mano; Lucrezio è l’intermediario, l’anello di congiunzione, e la parola poetica è lo strumento – altissimo – di questo passaggio, di questo processo di liberazione dalle angosce irrazionali.
Fin dal proemio del primo libro Lucrezio si rivela consapevole di quanto sia arduo il suo compito:
Né sfugge al mio animo ch’è difficile dar luce,
in versi latini, alle oscure scoperte dei Greci,
soprattutto poiché molte cose occorre trattarle con nuove parole,
per povertà della lingua e novità dell’oggetto,
ma il tuo valore, tuttavia, e il piacere sperato
d’amicizia soave, qualunque fatica m’induce
a sopportarla, a vegliare le notti serene,
ricercando con quali parole, con quale poesia, appunto,
possa io diffonderti innanzi alla mente luci splendenti,
e per esse tu possa vedere a fondo le cose nascoste.
(LIBRO I,vv.136-145)
Questi versi contengono dichiarazioni di fondamentale importanza:
1) Lucrezio sa benissimo che alla lingua latina manca il vocabolario filosofico necessario per trattare in modo adeguato la filosofia epicurea, ed è dunque indispensabile per lui coniare parole nuove, ricorrere a perifrasi o ricalcare direttamente parole greche;
2) Lucrezio vede nell’amicizia per Memmio una delle ragioni della propria attività di scrittore filosofico, e in questo non solo dimostra di accettare il ruolo tutto speciale che l’epicureismo riconosceva all’amicizia, ma siccome in Memmio va intraveduto il destinatario generico dell’operazione di conversione filosofica, di fatto Lucrezio chiama “amici” tutti i suoi lettori, esprimendo fin da subito il suo pathos, il suo coinvolgimento emotivo nello scrivere quest’opera;
3) Lucrezio ribadisce la fatica anche fisica, l’impegno richiestogli dalla composizione dell’opera (come farà Dante, all’inizio del canto XXV Paradiso), ma ciò non lo spaventa, di fronte alla prospettiva che la sua poesia diffonda “luci splendenti” e che la conoscenza della natura dissolva le tenebre dell’errore e l’angoscia che ne deriva.
Lo strumento espressivo a cui Lucrezio fa costantemente ricorso per illustrare le teorie della fisica epicurea, che poneva alla base dei fenomeni naturali l’attività di enti invisibili (gli atomi), è l’analogia, secondo un procedimento raccomandato da Epicuro stesso, per cui l’esempio degli eventi dell’esperienza quotidiana diventava la chiave di accesso alla comprensione dei fenomeni invisibili. Nel poema l’analogia costituisce a un tempo uno dei pilastri portanti dell’argomentare persuasivo e una delle fondamentali sorgenti dell’immaginazione poetica; a essa è affidato il compito di saldare gli insegnamenti della dottrina con le esigenze di espressione artistica del genere didascalico. L’uso metaforico di immagini facilmente memorizzabili, tratte dall’esperienza familiare al lettore, gli rende più facile la comprensione e riduce non solo il divario tra il visibile e l’invisibile, ma anche quello, nel quale facilmente prospera la superstizione, tra il noto e l’ignoto, tra la quotidianità rassicurante e il fenomeno sconvolgente e orroroso; mentre l’esposizione è resa più attraente dai colori poetici che Lucrezio diffonde sulle sue argomentazioni. Un esempio celeberrimo di questo procedimento è fornito dai vv.112 sgg. del libro II, dove l’incessante movimento degli atomi nel vuoto infinito è illustrato tramite l’analogia col pulviscolo che danza in un raggio di sole, e questa immagine è sviluppata in modo da rendere il lettore quasi partecipe della sorte di questi atomi sperduti. Si può definire Lucrezio un poeta essenzialmente “visivo”, tanta è la varietà e la potenza delle immagini che affollano le pagine del suo poema: non solo gli spettacoli maestosi e terribili dei terremoti o delle eruzioni vulcaniche, o le macabre, agghiaccianti immagini di morte (celeberrima la descrizione della peste di Atene che chiude l’opera), ma anche lo scintillio di eserciti in manovra osservati dall’alto di un colle, lo splendore del cielo riflesso in una pozzanghera, le pietre che selciano le strade, i panni stesi ad asciugare, i panorami marini, le conchiglie sulla spiaggia, i colori cangianti della coda del pavone, la giovenca desolata per la sorte del vitello destinato al sacrificio da una religione crudele, l’accalcarsi della folla, gli spettacoli del circo e del teatro, scene della città affaccendata, momenti della vita domestica e di lavoro… Si direbbe che Lucrezio sia lui stesso incantato, quasi soggiogato dalle immagini che di continuo gli si affacciano alla mente; in realtà anche il proliferare delle immagini obbedisce a necessità pedagogiche: Lucrezio ha di mira non solo la ragione, ma anche l’emotività del suo lettore…
All’altro capo della catena di salvezza, invece, Lucrezio non si stanca di celebrare i meriti del maestro, del fondatore della dottrina, trovando immagini particolarmente grandiose e sublimi nel libro I.
Epicuro è rappresentato con i tratti di un guerriero omerico che sfida vittoriosamente il mostro gigantesco della religio – segno evidente dell’intonazione epico-eroica che il poeta intendeva conferire al suo ardore didascalico, e viene dipinto come il gigante del pensiero che ha infranto le mura fiammeggianti dell’universo. Questa concezione di Epicuro combattente per il bene di tutta l’umanità è simmetrica rispetto alla concezione agonistica del rapporto autore-lettore, possiamo dire anzi che la seconda sia una conseguenza della prima, e proprio questo agonismo quasi titanico di Lucrezio, questa sua indomita energia costituisce una delle ragioni del fascino perenne della sua opera.
(la foto di copertina è di Bruna Bonino; la traduzione dei versi lucreziani è di Guido Milanese)
pubblicato originariamente il 15-9-2019