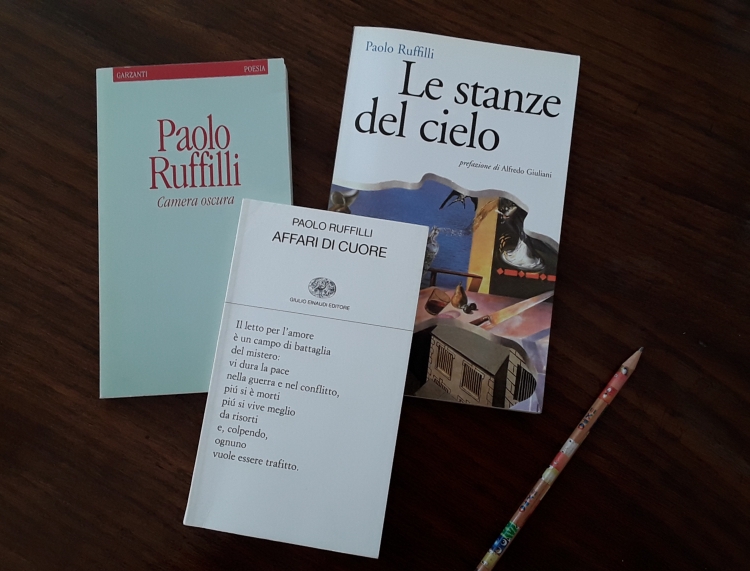ALFREDO GIULIANI
Se c’è una cosa che dobbiamo pretendere da un poeta è che ci si riveli diverso da come ce lo aspettiamo. Proprio perché così ci porta su un terreno che neppure sospettiamo e ci parla di qualcosa che ancora non sappiamo, costringendoci alla sorpresa e alla scoperta. è il tipo di esperienza che ho fatto a ogni nuovo libro di Paolo Ruffilli, nel segno della continuità eppure della continua variazione.
Ruffilli, che è del 1949, ha cominciato a pubblicare piuttosto presto, nei primi anni Settanta. Subito apprezzato dalla critica, ha preso spicco con Piccola colazione (Garzanti, 1987), singolare operetta tramata di ironia, asciutta inquietudine e piacere di muoversi in una cantabilità abilmente sommessa, antilirica. Giuseppe Pontiggia, nella prefazione, la definiva con esattezza “romanzo di formazione autoironico”. I brevi movimenti che compongono il testo raccontano una storia di minime scosse e fuggevoli lampi di memoria; ma quel che conta è il tono del racconto, insieme partecipe e gentilmente distaccato. Una situazione che già prima appariva in formazione, con le sue battute rapide e fulminanti consegnate alle parentesi, in una sorprendente e accattivante cronaca in versi scritta negli anni 1975-79 ma pubblicata nel 1990: Diario di Normandia (Amadeus); cronaca, si intende, reimmaginata e sceneggiata in una nuova forma lirica asciutta e coinvolgente nella presa di distanze.
L’inclinazione a oggettivare i dati, i segni della soggettività, si accentua nella successiva operetta Camera oscura (Garzanti, 1992), dove l’autoironia lascia il posto a una drammaticità senza enfasi né lamenti. E anche qui non può sfuggire ai lettori la percezione del tocco narrativo leggero e contratto che contraddistingue la poesia di Ruffilli. Stavolta i dati iniziali emergono da un pacco di vecchie fotografie. Segni muti. Parvenze dell’accaduto come poste “sotto vetro”. Però, attenzione, avverte l’esordio: “I vivi sono morti: / colti in assenze / di statuto, nell’atto / di discesa senza porti / ma con le sue partenze / e i suoi arrivi. / Morti vivi”.
Le vecchie fotografie sono povere tracce, eppure a pensarle parlano. Un po’ “romanzo famigliare”, come lo chiama Giovanni Raboni in una nota che chiude il libro, un po’ autobiografia del sé bambinesco incantato dal senso del proibito, e un po’ accertamento lancinante di quanto inevitabilmente va perduto e chiede di alleggerirsi, riconoscersi nel presente intemporale della poesia… Camera oscura risponde a un intrico di sollecitazioni che non possono mai finire. Altra sorprendente caratteristica del libro (di ogni libro di Ruffilli), quanto più piccolo e frammentario tanto più capace di rivelarsi compatto e inesauribile per il lettore.
La gioia e il lutto (Marsilio, 2001) ha un sottotitolo che lo colloca a prima vista in una dimensione assai diversa da quella “romanzesca” delle opere precedenti: Passione e morte per Aids. Difatti il tono non è più sommesso, ma offeso e spaventato; ora predicatorio oppure orante, o rivoltoso, ora accanitamente riflessivo, o teso con furente illusione “verso l’impensato”. Una bella gamma di variazioni dentro un tema che sembra bloccato. E, intanto, raccontando comunque una storia.
La gioia e il lutto è un recitativo di singole voci anonime. Chiusa ognuna nel proprio pensiero, si alternano e non dialogano tra loro. Tutte partecipano alla severa rappresentazione farneticando con lucidità. Così Ruffilli ottiene un effetto corale di alta e astratta consonanza, mentre il lettore non dubita che la tragedia è angosciosamente reale. Il poeta l’ha vista in faccia e l’ha ascoltata e riascoltata nella mente. Come dice Pier Vincenzo Mengaldo nella prefazione, “La realtà, per Ruffilli, è in fondo tale solo se pensata dal soggetto”. Pensata, sì, e immaginata (pensare e immaginare sono, appunto, le costanti della poesia di Ruffilli secondo un passo che è ormai fuori dall’elegia).
C’è la voce del giovane morente, che si fa sentire (dalla sua abissale distanza) finché la devastazione della malattia non gli toglie la capacità di pensare. E riconosciamo la madre, il padre, gli amici, l’amante. E c’è una voce che le pensa tutte sulla morte e il dopo, alla fine con forte accento religioso, cosa che non bisogna attribuire semplicemente a una presunta fede dell’autore. Ecco la capacità di astrazione di Ruffilli, il quale – ammettiamo che sia lui – scrive serenamente: “è il pungolo / che incalza e spinge / senza lasciare tregua, / lo stimolo del lutto”. Il pungolo gli fa squadernare “oggettivamente” tutte le ipotesi. E lo stesso pungolo gli fa ricordare il leopardiano Coro di morti.
Quella stessa inclinazione a oggettivare i dati soggettivi di cui si è detto rende capace Ruffilli di calarsi nella soggettività degli altri, da poeta che è anche narratore (allo stesso modo in cui, sia pure in forme differenti, da narratore riesce a rimanere poeta – grande rarità – nei racconti del suo Preparativi per la partenza, Marsilio 2003). Quello che accade con le molteplici voci di La gioia e il lutto, accade anche con la mutevole voce recitante di Le stanze del cielo e con quella esaltata e sconfitta di La sete, il desiderio, l’altra sezione del nuovo libro che conduce il lettore in due territori a dir poco inconsueti per la poesia: lo spazio concentrazionario “esterno” della prigione e quello “interno” della tossicodipendenza, in entrambi i casi dietro all’ossessione della perdita della libertà.
A Ruffilli poeta interessano tutti gli aspetti della vita e in particolare quelli segnati dalla sofferenza e dal male (il male fisico e il male di vivere), come appare evidente nella citazione da Mori i Po posta ad esergo del libro: “I poeti, al contrario di tutti gli altri, sono fedeli agli uomini nella disgrazia e non si occupano più di loro quando tutto gli va bene.” E, per misurarsi con il Male, usa i suoi mezzi di sempre: il passo felpato e breve, un partecipe distacco, la cantabilità sommessa e antilirica dal ritmo sincopato. Soprattutto non si lascia condizionare dall’apparenza dei fatti, perché la realtà è sempre diversa da quello che appare, anche dentro le celle di un carcere (“…crescono qui piante / che voi di fuori / non conoscete ancora, / accadono cose / che occorre collocare / in un mondo intermedio / distante chilometri / dal vostro”) e nella tirannica schiavitù della droga (“fu anzi la coscienza / minuziosa / di me e del mondo / a muovere e guidare / i passi ignoti / del mio precipitare”). Meno che mai si arrende di fronte all’ipocrisia, alle paure e all’ “odio infinito” che la società riversa sui suoi reprobi.
Come nei suoi racconti di Preparativi per la partenza, Ruffilli ci suggerisce che esistono molte realtà, insieme incidenti e parallele, per la cui lettura occorre esercitarsi con cautela e con modestia (con umanità se non con amore) oltre ogni abbaglio dell’immediatezza. Lo fa attraverso il monologare di un carcerato (del “carcerato”) e di un drogato (del “drogato”), insieme nel concreto e nell’astratto, nella storia personale e in quella generale, dal punto di vista di chi ha perduto “per colpa propria o altrui la luce” della libertà. E, se la voce del tossico è ora lucidamente invasata e ora altrettanto lucidamente disperata (“so nel vivo / per ogni grammo di piacere / i quintali di dolore / di vomito e di noia / che è costato, / per tanto paradiso / quanto inferno di più / ho attraversato”), la voce del detenuto cambia continuamente tono: offeso, riflessivo, nostalgico, deluso, rivoltoso. Proprio come per La gioia e il lutto, di nuovo una bella gamma di variazioni dentro un tema che sembra bloccato.
Il procurare il male degli altri e il proprio, dentro l’enigma della vita, va considerato con più dubbi e meno certezze, al di là o dentro la necessità di amministrare la giustizia e di far rispettare la legge. Come il detenuto tenta di opporsi alla totale cancellazione della sua personalità nella reclusione (“Ma che significa punire? / è un patto: si arriva / a giudicare il fatto, / non la persona”), così il drogato rifiuta di farsi omologare dentro le categorie scontate (“Ma non perché / incompreso / e non amato, / debole forse / non vittima però, / estraneo a tutto / e di sicuro fuggitivo, / uno che sente / l’ebbrezza di scappare / verso il vuoto, / tra le braccia / del suo niente”) e, intanto, ecco delinearsi un’ulteriore tangenza tra le due parti del libro: il dilagare della droga dentro il carcere, in cerca di “una via / più rapida / per non vedere, / per non pensare / al tuo dolore / e conquistare il mondo / che intanto / ti scappa dalle mani”. Paradosso ulteriore della permeabilità di “grate e cancelli”, di tribunali e di codici, a quell’entità inarrestabile che intacca e corrompe tutto.
Si staglia sempre più inquietante la solitudine che incatena “l’io delinquente”, mentre emerge lo squallore di un regime carcerario che al di là dell’impegno e degli sforzi di civiltà è il segno tangibile del fatto che “le grandi conquiste / dello spirito / quaggiù sono solo / lettera morta. / In basso regna / l’abiezione: / il male non si vuole, / semplicemente è”. Ma, di fronte a quest’uomo dallo sguardo spento che non è più vivo eppure ancora non è morto, sordo e muto ormai a tutto il resto, consapevole del suo “inferno” (“Non c’è ragione / per tanto orrore. / Qualunque spiegazione… / Neppure Dio lo sa / perché l’ho fatto”), ecco nascere e consolidarsi un rispetto nei confronti dei comportamenti anche più efferati, delle scelte distruttive e suicide. Un rispetto non da “buon cristiano”, ma di una intelligenza sensibile che sospende il giudizio e si sforza di conoscere fino in fondo per capire.
Viene in mente quello che dichiara il capo della polizia in uno dei racconti di Somerset Maugham: “Io ho il compito di impedire i delitti e di cercare i colpevoli quando i delitti avvengono, ma ho conosciuto troppi criminali per pensare che nell’insieme formino una categoria peggiore delle altre. Può capitare che una brava persona sia costretta dalle circostanze a commettere un delitto e, se si fa prendere, viene punita, ma non per questo smette di essere una brava persona. Naturalmente la società punisce chi infrange le sue leggi, e fa benissimo, ma non sempre le azioni sono il metro giusto per giudicare un uomo. Avendo la mia esperienza di poliziotto, si sa che quello che davvero conta non è ciò che la gente fa ma ciò che la gente è. Per fortuna i poliziotti non devono occuparsi dei pensieri della gente ma solo delle loro azioni, altrimenti la questione sarebbe molto diversa e molto più difficile”. E, non essendo appunto un poliziotto, Ruffilli si occupa soprattutto dei pensieri della gente e di quello che le persone sono, non di quello che fanno.
Nella poesia di Ruffilli accade qualcosa che molto raramente si ritrova nell’esperienza egocentrica dei poeti che pure riescono spesso a trasformare in valenza universale la loro dimensione più individuale. Ruffilli, istintivamente, mette sempre in rapporto ciò a cui dà voce con il contesto sociale in cui si muove e parla. E può darsi che sia l’effetto dell’inclinazione narrativa sulla sua vocazione di poeta. Ma è un fatto che, fuori da qualsiasi volontarismo, la sua poesia è sempre anche “civile”, di qualsiasi tema tratti (e non c’è tema, per lui, che non sia adatto a far poesia). E il riscontro civile, o se si vuole collettivo, è la conseguenza indotta e il valore aggiunto della già di per sé validissima ricerca di una poesia che ha insieme i sapori forti della vita e il ritmo implacabile del pensiero in una musica inconfondibile e direi irriducibile, unica nel suo genere da noi; una musica elegante e rarefatta che mi ha sempre colpito e coinvolto, tra Béla Bartók e il cool jazz.
 Prefazione a Le stanze del cielo, Marsilio, 2008, e in “La Repubblica”, 14 febbraio 2008
Prefazione a Le stanze del cielo, Marsilio, 2008, e in “La Repubblica”, 14 febbraio 2008
Un profilo di Ruffilli si trova qui:
http://www.italian-poetry.org/paolo-ruffilli/