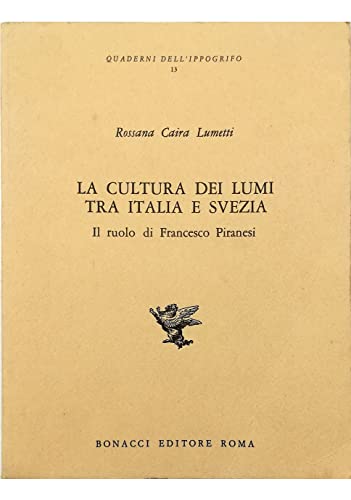DINA TORTOROLI
L’intellettuale che accetta di comporre “a nome di Piranesi” la macchinosa Lettera ad Acton, per impedire che le sue nobili intenzioni vengano fraintese, fornisce una chiave di lettura che ci obbliga a sgomberare il campo da equivoci.
Egli rivela, infatti, una personalità ben diversa da quella di Vincenzo Monti.
Lo ammette anche Rossana Caira Lumetti, nelle pagine con cui introduce il pamphlet:
«Nella Lettera sono interessanti gli spunti sui temi della giustizia, della verità e dell’opinione pubblica. Vi si avverte un fervore, una passionalità che non siamo abituati a riconoscere nella penna montiana: risultato senz’altro dei suggerimenti [corsivo mio] di Francesco Piranesi che hanno fatto della Lettera un monumento di autentica [corsivo mio] passione politica. In sostanza, scrive Monti, se l’ingiustizia provoca sofferenze laceranti, esiste anche la volontà di una giusta rivalsa attraverso la legge e il diritto».
La studiosa fornisce quindi informazioni, attestate da documenti:
«Quando Ugo Foscolo, nell’Esame su le accuse contro Vincenzo Monti (1798) indicò nel poeta l’autore del pamphlet, segnalandolo come testimonianza di coraggio e attribuendo all’autore benemerenze politiche che sicuramente non aveva, non tenne conto delle reali intenzioni del poeta che di fatto si prestò ad aiutare l’amico per avere degli appoggi politici in un momento così critico e incerto.
In realtà Monti s’impegnò nella stesura dell’operetta più per motivi personali e familiari che per una profonda convinzione ideologica. […] Si trattava, e le testimonianze epistolari sono molto chiare, di opportunismo connesso ad una certa intolleranza alle costrizioni intellettuali, e di una reazione all’ambiente romano che lo aveva sollecitato a scrivere la Bassvilliana. […] L’epistolario montiano ci fornisce altri lumi che ci permettono di capire l’interesse del Monti per Piranesi. L’incisore era anche, dal 1793, ministro di Svezia a Roma. Di questa carica non gli vennero mai accettate le credenziali (poiché connesse a un regno protestante). Pur tuttavia il pontefice gli permetteva di esercitare ugualmente le funzioni ad essa connesse. Piranesi aveva così la possibilità di nominare dei consoli. […]. Monti pensò dunque di approfittare della necessità di Francesco [Piranesi], per chiedergli di nominare console suo fratello Francesco Antonio. In tal modo avrebbe potuto beneficiare dei vantaggi dello status diplomatico: Le lettere di Monti al fratello Francesco Antonio (del 30 aprile, del 14 e 21 maggio e del 20 agosto 1796, e inoltre del 20 novembre 1797) mostrano chiaramente le sue aspettative»*.
Lumetti cura la pubblicazione della Lettera nel 1991, ma già l’anno precedente si era occupata di quel testo nel corposo Saggio La cultura dei Lumi tra Italia e Svezia / Il ruolo di Francesco Piranesi, in cui tredici pagine del quarto capitolo – La vicenda Armfelt-Acton-Piranesi – sono riservate alle Caratteristiche compositive della Lettera all’Acton (pp. 156-169)**, e io potrei avvalermi di tutti gli esempi presi in considerazione dalla studiosa, per dimostrare l’affidabilità delle mie impressioni di lettura, che mi inducono a credere autore “verace” (vale a dire credibile prima ancora che probabile) della Lettera in questione non Vincenzo Monti, bensì “il primo Manzoni”, “il Manzoni del Fermo e Lucia” (puntata n. 33), vale a dire Carlo Imbonati.
Mi limiterò a trascrivere (e utilizzerò il corsivo, per dar loro la massima evidenza) frasi o brani del romanzo, che la mia mente associa di colpo alle citazioni dello pseudo-Monti, per il loro rapporto di conformità.
Caira Lumetti fa notare che Monti ha notevole «capacità di rappresentazione dei personaggi»: «Rappresentatevi un paladino del Callotta [Jacques Callot, incisore e pittore di miniature comiche e grottesche] o del Ghezzi [Pier Leone Ghezzi, pittore che eccelse anche nel genere della caricatura], sul taglio poco più, poco meno dello scudiero di Don Chisciotte, con un naso d’antico imperatore, con una testa sempre immersa nelle superstizioni del lotto a segno di tenere il libro dell’arte sotto il capezzale, come dìcesi che d’Omero facesse il grande Alessandro; con due gambe a ciambella, ed egli mal sicuro sulle medesime, che ad ogni passo minaccia di buttarsi in ginocchio per intonare le litanie» (p. 162).
A me viene subito in mente un ritratto contraddistinto dalla medesima efficacia caricaturale:
«la governatrice favorita di Donna Prassede era nominata molto variamente. Il suo nome era Margherita, ma dalla padrona era chiamata Ghita, dalle donne inferiori a lei, e dai paggi di Donna Prassede Signora Ghitina; e dai servitori di Don Ferrante quando parlavano fra di loro non era mai menzionata altrimenti che la Signora Chitarra. Pretendevano costoro che il suo collo lungo, la sua testa in fuori, le sue spalle schiacciate, la vita serrata dal busto, e le anche allargate la facessero somigliare alla forma di quello strumento: e che la sua voce acuta, scordata, e saltellante imitasse appunto il suono, che esso dà quando è strimpellato da una mano inesperta» (Fermo e Lucia – d’ora in poi F. L –, edizione mondadoriana, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, p. 501).
Lumetti osserva che «a modi espressivi popolari o proverbiali si contrappongono riferimenti dotti a scrittori, ad opere famose, all’astronomia, alla mitologia: “quando s’inventano le parole con la furberia de’ fanciulli, e colla coscienza del Segretario Fiorentino”; “perché insomma mettere in campo l’Achille delle vostre ragioni due mesi dopo il bisogno…”. Ci sono riferimenti omerici: “lo lascia in compagnia della sua casta Penelope”; “dove il Mori è stato cercato più che non fu cercata Creusa nell’incendio di Troja”; “e non vi fu tanta esultanza nella reggia d’Itaca al ritorno d’Ulisse dopo vent’anni di pellegrinaggio, quanta ven’ebbe nella vostra Corte al ritorno del Barone dopo dieci giorni di villeggiatura”; […]. I riferimenti ironici continuano a mescolarsi con le citazioni colte» (pp. 163-165).
Nel Fermo troviamo :
– «io posso far testimonio che la mia Lucia aveva in orrore colui, come il diavolo l’acqua santa» (F.L., p. 157);
– «questa povera ragazza aveva un giovane che le parlava [fidanzato], un nostro pari» (F.L., p. 157);
– «Ma, un po’ colle buone, un po’ colle cattive… m’intendete eh? olio ed aceto; e si fa l’insalata» (F.L., p. 487);
– «Dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei» (F.L., p. 503);
–«si parla tuttavia delle magre cene di quel Curio mal pettinato, come lo chiamò Orazio; è viva e comune la memoria del salino di Fabricio e del suo piattello sostenuto da un picciuoletto di corno. E perché dunque il tozzo di pane di Federigo e il suo bicchier d’acqua non potranno ottenere una simile immortalità di gloria? […] Eppure la ragione dice che […] quel tozzo di pane mangiato [da Federigo Borromeo] tra le fatiche d’un ministero di misericordia, di pace, e di pietà, dovrebb’essere una rimembranza più cara agli uomini che non quel salino e quel piattello che copriva la mensa d’un uomo che era sobrio per poter essere forte contra gli uomini; che godeva di essere un povero Fabricio per essere un potente Romano» (F.L., p. 410);
– «si vedeva un pezzo di catenaccio torto e quasi divelto con gli anelli, che teneva ancora insieme quelle imposte, a un di presso come già Romolo Augustolo teneva insieme l’impero romano d’occidente» (F.L., p. 451);
– «Se quel brav’uomo avesse letto Virgilio non avrebbe mancato di dire in questa occasione: «Non ignara mali miseris succurrere disco» (F.L., p. 494);
– «persuaso che tutte le precauzioni immaginabili non avrebbero potuto fare che la congiunzione di Saturno con Giove non fosse avvenuta» (F.L., p. 644);
– «Antonio Ferrer stava immoto a tutti i richiami, come Enea agli scongiuri di Didone» (F.L., p. 433);
– «perché i nostri eroi, simili in ciò a quelli d’Omero, non conoscevano l’uso dell’abbicì» (F.L., p. 509);
– «erano come i cavalieri dell’undecimo secolo coperti d’elmo, di visiera, di corazza, di cosciali, di gambiere, con una buona lancia nella destra, un buon brocchiere alla sinistra, una buona spada al fianco, una buona provvigione di giavellotti, sur un buon palafreno agile all’inseguimento ed alla ritratta*** , in mezzo ad una marmaglia di villani a piede, ignudi d’armatura, e poco coperti di
vestimenti, che per offesa e per difesa non avevano che due braccia e due gambe, e il resto delle membra non atto ad altro che a toccar percosse» (F.L., p. 595);
– «e fra tutti i signori medici non vi sarà quell’ Argo, che possa dire d’aver veduto, non vi sarà quel Briareo che possa dire di aver toccato questo contagio» (F.L., p. 557);
– «due parole che cozzano, che ripugnano, che stanno insieme come Aristotele e scimunito» (F.L., p. 557);
– «iscrivendo nell’aria certi saluti, a guisa d’un nodo di Salomone (F.L., p. 468).
– «l’oste […] ripresa la lucerna con la sinistra gliela sollevò sul capo […] nell’atto che vediamo dipinta Psiche quando sorge a spiare furtivamente le forme del consorte sconosciuto: e disse: “Matto minchione!”» (F.L., p. 471).
Lumetti fa notare una «caratteristica compositiva», che probabilmente colpisce persino i lettori frettolosi: «Monti adopera con sapienza la tecnica dell’oratoria; la scansione ritmica offerta da due o tre sostantivi o aggettivi identici o sinonimi presenti nel discorso contribuisce a creare un climax particolarmente incisivo: “un paragrafo, un periodetto, una sillaba”; “favoleggiate, mentite, calunniate quanto volete”; “buon volto, ma buona cena e buon letto, dico buon letto per il solo Barone”» (p. 165).
Nel Fermo ritroviamo il “buon letto” nelle frasi «un buon letto da darmi» (F.L., p. 465); «preparare un buon letto a Lucia» (F.L. p. 510), e tra lo sterminato numero di incisivi esempi di climax scelgo quelli inerenti il potente Romano Fabricio, nominato sopra, cui viene contrapposto il benevolo cardinale Federigo Borromeo: «Le idee di cui si componeva il sentimento temperante di questo [Fabricio] erano superbe, ostili, sprezzanti, superficiali: quelle di Federigo umane, gentili, benevole, profonde»; « Egli [Federigo] desiderava la giustizia, la fortezza, la sobrietà a tutti, la desiderava per loro, per sè, per la gloria del Dio di tutti, la desiderava e tutta la sua vita fu spesa a promuoverla. […] A dispetto di tutta la storia, di tutta la morale, di tutta la rettorica, Federigo Borromeo era più grand’uomo di Fabricio…» (F.L., p. 410 e 411).
Inoltre, Caira Lumetti aggiunge che «il ritmo non è soltanto binario o ternario».
E noi possiamo constatare che queste cadenze variabili si avvertono nell’intera composizione del Fermo:
– «Sì; pel denaro, per la vendetta, pel diletto di far male l’uomo disprezza il pericolo; sì allora egli sente qualche cosa che lo porta con gioja ad affrontare il suo simile: ma perché uno non sia oppresso, ma perché non s’impedisca una cosa giusta, ma perché le cose vadano come dovrebbero andare, tranquillamente, ordinatamente, tu credevi che troveresti chi si armerebbe con te contra un potente?» (F. L., pp. 78-79);
– «e Fermo allora lo malediceva con tutti i tiranni, con tutti i dottori, con tutti quelli che avrebbero dovuto proteggere il povero, e lo lasciavano opprimere» (F.L., p. 412);
– «Tutti ragionano delle cause del male, tutti propongono i veri rimedj, tutti dissertano di principi generali, di commercio, di monopolio, di importazione, di esportazione, di circolazione» (F.L., p. 423);
– «si afferma senza conoscere, senza poter conoscere, senza cercar di conoscere» (F.L., p. 425);
– «queste false idee… erano ben più universali, più pertinacemente tenute, più furibondamente applicate nei tempi della nostra storia» (F.L., p. 427).
Lumetti evidenzia il fatto che «non viene dimenticato neanche il lettore […]: “Considera dunque mio caro lettore […]. Perdonami adunque la soverchia diligenza delle mie narrazioni…”»; e inaspettatamente commenta: «tono confidenziale che ritroveremo in Manzoni» (p. 166).
E’ un’attestazione preziosa, perché dimostra che anche la studiosa ha avvertito nella Lettera l’eco dell’altra voce narrante.
Proseguire nella rassegna dei suoi esempi mi pare ora superfluo; non voglio, invece, rinunciare a proporre almeno la “corrispondenza” di due episodi allucinanti, indimenticabili.
Al ministro Acton, che afferma di aver catturato a Roma Benedetto Mori, l’autore della Lettera dice:
«Manco male che quest’infame è stato finalmente ghermito dalla giustizia. Presto dunque, che il boia pianti le forche e tenga pronto il capestro. Ma di grazia, prima di consegnarlo al carnefice, degnatevi di vederlo. Spogliatevi per un momento della vostra grandezza, e scendete con meco nell’orrore della prigione, ove quest’uomo languisce da molti mesi. Guardatelo. Egli rassomiglia piuttosto a un cadavere che a un corpo vivo. Egli ha perduto affatto le sembianze di Benedetto Mori. Che dico? Qual metamorfosi? Egli non è più Mori. Egli è un povero camerinese carcerato nel seno della sua patria fra le braccia della sua famiglia, un miserabile che non ha visto mai Napoli, che ai nomi d’Armfelt, di Mori, di Piranesi rimane attonito e senza segni di conoscenza, e che non ha mai offeso né mai sentito nominare quell’Acton che lo conduce a morire. A questo spettacolo mi si riempiono gli occhi di lacrime, mi bolle il cuore di sdegno, mi fugge dalle mani la penna, e mi mancano le parole per proseguire» (Lettera, pp. 100-101).
Nel Fermo, invece, il discorso “prosegue”, con l’orripilante narrazione dei tormenti inflitti all’uomo sbagliato, dopo la ricostruzione del modo spaventevole in cui il Senato era riuscito a «tenerlo».
Molti, ma inutili erano stati i tentativi di trovare «quello spagnuolo grande, quel Don Pietro di Saragozza, che era stato l’intermediario tra il Mora, e il Padilla****. Il caso pareva disperato; ma che non può la perseveranza unita ad un po’ di finezza d’ingegno? Si trovò Don Pietro di Saragozza. Ed ecco in qual modo. V’era nelle carceri del Pretorio di Milano un cattivello soldato spagnuolo, reo costituito di furto attentato. […] molti anni prima venuto al mondo nella città di Saragozza. Suo padre, non credendo mai mai di commettere un’imprudenza, gli aveva messo nome Pedro. Eccoti Pietro di Saragozza. Veramente, a tutto rigore, gli sarebbe mancato il Don. Ma nei titoli s’abbonda per cortesia, e non istando a cavillar sur un monosillabo, procedendo alla buona, s’ebbe un Don Pietro di Saragozza. Costui si può mettere alla corda per l’accusa di furto tentato: quando vi sarà “sia interrogato ed escusso” intorno agli unti pestiferi. Tale è la mente del Senato. Alla fine delle fini questo non gli darà altro incomodo che di stare un po’ più su la corda, tanto che parli come il povero Mora […]. Ma voi Signori, tanto privilegiati, ai quali fu dato di porre gli occhj in faccia a quel Don Pietro di Saragozza che nessuno aveva mai veduto, e di aver dinanzi a voi quella persona che nessuno aveva inteso nominare, diteci, di grazia, come è fatto quest’uomo.
Eccolo, rispondono: un uomo, “di statura comune, di grossezza proporzionata, testa grossa… grosso d’ossi… barba castana tirante al nero, con barbisi tirati in su…”
Così fatto è Don Pietro di Saragozza? Fermatevi per amor del cielo. L’uomo che voi volete alzar colla corda, è il Don Pietro di Saragozza del Mora: certamente; poiché a che vi gioverebbe tormentarne un altro? Non potrebbe esser nemmeno un divertimento per voi, che avete sott’occhi così sovente un tale spettacolo. Ora, Signori, il Mora non potete più averlo per riconoscere quest’uomo, il Mora voi sapete che ne avete fatto. Non ne avete lasciato insieme pur le ceneri; e ciò che era il suo corpo non si riunirà più che in un giorno, nel quale non farete voi la legge; e allora Dio sa se voi farete più paura a lui, o egli a voi. Ma il Mora quando era tuttavia in carne ed ossa, in quella carne che voi avete fatta strappare colle tenaglie, in quelle ossa che voi avete fatto schiacciare con la ruota, il Mora, ve ne ricordi, vi descrisse quel suo Don Pietro di Saragozza, vi dettò i contrassegni, e voi gli avete notati. Scorriamo dunque indietro per questo scartafaccio, e rivediamo quei contrassegni. Ecco: “un grande, magro, di barba nera et poca…” Vedete ora quanto importi guardarsi indietro: per questa poca di diligenza che abbiam fatto, sono messe in salvo, spero, le ossa d’un uomo, giacché voi non potete più fare slogare quelle dell’uomo che tenete: per quanto egli sia Don Pietro di Saragozza, non è però quegli che portò le ambasciate di Don Giovanni De Padilla al barbiere che stava sull’angolo della vetra de’ Cittadini…» (F.L., pp. 718-721).
Speranza vana, ma io non riferirò altri orrori.
Ritorno quindi momentaneamente a mettere a confronto la Lettera e il Fermo, per mostrare quanto sia significativa anche la conformità di locuzioni frequenti nel linguaggio parlato, o anche soltanto di un aggettivo, un verbo, un sostantivo, un avverbio:
– «Ora sapete mo voi chi fu l’uomo d’onore che lo distolse?». (Lettera, p. 84)
«ora mò sentite la penale» (F.L., p. 49); «lo accusavano, indovinate mò (F.L., p. 551).
– «Qual distanza, qual differenza fra questi due punti di prospettiva!» (Lettera, p. 42).
«Qual gloria, signor Don Rodrigo! Qual gloria dinanzi agli uomini» (F.L., p. 96).
– «Avvezzato da molto tempo al linguaggio dei vili e tremanti adulatori che vi circondano». (Lettera, p. 47).
«le ricchezze avevano attirati adulatori che lo avevano avvezzo ad esigere molti riguardi (F.L., p. 61).
– «come mai, signor Generale, voi gran ministro, voi gran politico… come mai è possibile…?» (Lettera, p. 50).
«ebbene? Signor bravo, signor capitano, signor spaccone» (F. L., p. 232).
– «Chi sono questi tre sognati assassini?». (Lettera, p. 61).
«negò costantemente e tranquillamente il sognato delitto» (F.L., p. 705).
– «le risposte, voi lo sapete, tutte coraggiose e piene d’onore, non meno che di evidenza, avrebbero rovesciata la macchina infernale che si era costruita per rovinali». (Lettera, p.75).
«leggendo le risposte loro le quali tutte, al pari delle citate, danno un sentimento immediato ed invincibile di verità, non si sa intendere come elle non portassero questo sentimento nell’animo dei giudici (F.L., p. 705).
– «con un cavillo impudentissimo, ed inaudito»; «ricorrere alle miserabili cavillazioni grammaticali». (Lettera, p. 45 e p. 55).
«non istando tanto a cavillar sur un monosillabo»; «Ma queste, dirà forse taluno, sono cavillazioni» (F.L., p. 718 e p. 873).
L’accenno al cavillo impudentissimo [il SE SAISIR (requisire) cui Acton aveva fatto ricorso per giustificare l’affronto alla Svezia] mi permette di dire che intenzionalmente ho evitato di affrontare il tema che, come sappiamo, assillava l’Imbonati: la manipolazione insidiosa delle parole.
Gli si dovrà quindi dedicare “molto tempo”, “molta pazienza” nonché “soverchia diligenza”.
—————
* Vincenzo Monti, Lettera di Francesco Piranesi al Signor Generale D. Giovanni Acton, a cura di Rossana Caira Lumetti, Sellerio editore, Palermo, 1991, pp. 23-26 e p. 33, nota 16.
**La carrellata di caratteristiche stilistiche della Lettera sono precedute (pagine 158-160) da citazioni dell’epistolario del Monti; ed è utile riflettere almeno su quanto il poeta dichiara, al fratello Francesco Antonio, nella lettera del 30 aprile 1796: «Per venirvi dicendo una alla volta le ragioni che m’hanno indotto a procurarvi l’onorifico distintivo di console svedese, se non è la prima non è neppure l’ultima quella di assicurare la vostra persona e la nostra casa da qualunque insulto ed offesa nel caso (che pur troppo non pàrmi molto lontano) che i Francesi facessero una visita anche allo Stato Pontificio… Voi vedete che la spada repubblicana porta dappertutto la ruina e il terrore… Sotto la protezione di una Potenza neutrale voi dunque potete rimanervi meno degli altri esposto ai pericoli di una qualche soverchieria».
*** Il ricorso al “linguaggio tecnico” dell’“arte di cavalcare” riporta alla mente la cronaca, pubblicata sul Diario di Roma, del “saggio finale” dell’anno 1773, in cui, nel cortile del Collegio Clementino, l’allievo Carlo Imbonati si esibì con successo nelle andature ed evoluzioni di “cavallerizza”.
****«Si vede, e si vedrà ancor più chiaro in seguito che questo personaggio era tutto d’invenzione; e giova credere che il Mora abbia preferito il ripiego di foggiarlo a quello d’apporre un delitto ad un personaggio reale, non solo per impaccio, ma ancora per non accrescere il numero delle vittime» (F. L., p. 697).