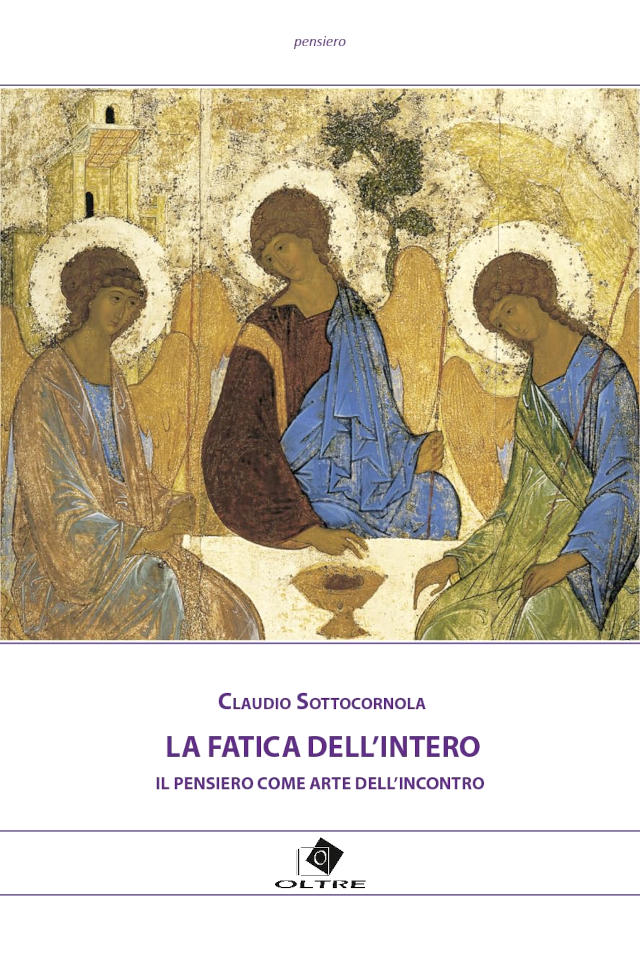È esperienza comune, quando assistiamo a un dibattito televisivo, che gli interlocutori di diverso orientamento politico si fronteggino ribadendo le rispettive contrapposizioni, senza mai addivenire a una qualche condivisione o convergenza. In tale ottica sembra praticamente impossibile riconoscere alle posizioni dell’altro una qualche bontà o attendibilità intrinseca. Anzi, il consentire anche solo in parte alle ragioni dell’avversario sarebbe considerato un cedimento, una sconfitta, una perdita di credibilità. In questo modo si rischia di delegittimare non questa o quella idea, ma l’intera posizione dell’altro, la sua storia e identità profonda, generando ferite difficilmente risanabili.
D’altra parte, gran parte delle motivazioni, dei convincimenti, delle valutazioni che noi effettuiamo sono prodotte entro una cornice di appartenenza che, spesso a livello non pienamente consapevole, struttura in noi una mappa cognitiva che ci guida o almeno orienta nelle nostre scelte e nei nostri giudizi quotidiani. Così, nel giudicare un evento, è facile che assumiamo il punto di vista della testata di nostra fiducia, magari della parte politica per cui simpatizziamo, oppure di un preciso orientamento culturale, di cui potrebbero far parte posizioni di tipo laico o religioso, ma anche valutazioni estetiche ed etiche specifiche.
Si è sottolineato il carattere condizionante, ma anche avvolgente, pervasivo, ineliminabile di tale orizzonte, per mostrare che è in certo modo impossibile prescindere da una qualche appartenenza, variamente declinata, nel fare esperienza della realtà, tanto che Hans-Georg Gadamer definì positivamente il pre-giudizio, inteso come insieme di aspettative che, guidandoci a una prima conoscenza, possono poi essere oggetto di revisione o conferma. Ad esempio, scelgo di andare al cinema per vedere un film perché me ne sono fatto un’idea (pre-giudiziale, prima della visione effettiva) positiva, che andrà poi vagliata alla prova dei fatti.
Ecco il punto fondamentale. Prescindere dall’appartenenza impoverirebbe il mio giudizio, che si sostanzia e irrobustisce proprio grazie a quell’insieme di conoscenze e convinzioni che vanno a costituire un patrimonio acquisito di sapienza e saggezza pratica che è il mio orizzonte cognitivo. D’altro canto, appiattirsi rispetto a tale appartenenza ed assumere, a partire dai suoi canoni e schemi, un discorso o giudizio precostituito da applicare meccanicamente alla mia esperienza della realtà diventa un modo comodo e conformista di vivere, che mi esonera dalla ricerca interiore e rischia di avallare pregiudizi questa volta sì lesivi della dignità e integrità dell’altro.
La maggior parte delle persone però – occorre dirlo – non sembra in grado di trascendere un discorso di parte, anche quando esprime posizioni di potere o di leadership, forse perché tale unilateralità e semplificazione è congeniale al mantenimento del potere stesso e alla inibizione di qualsiasi opinione contraria, che potrebbe metterlo in discussione, e risulta inoltre rassicurante per il singolo che ritiene di possedere la verità e di essere investito del ruolo di suo portavoce. Inoltre, nella contemporanea società tardo-capitalistica, il potere economico-finanziario, quello politico e quello mediatico, tendono a generare un discorso mainstream, come insieme di valori, modelli e operazioni convenienti a tale sistema, che si impone nella vita pubblica, soprattutto attraverso una videocrazia che ha nei mass e social media gli strumenti più intrusivi e subliminali a disposizione nel generare consenso passivo, inconscio e meccanico, ma soprattutto dipendenza antropologica (per esempio da smartphone e Rete). Tantopiù che la gente, impegnata nel lavoro quotidiano, è costretta a fare riferimento proprio a quei mass e social media dominanti per informarsi e formarsi, col risultato di uscire da tale esposizione ancor più condizionata e interiormente impoverita. Capiamo che il dilagare di modelli consumistici, edonistici e materialisti genera coscienze crasse e intorpidite, appoggiate al cliché del così si fa e si dice, come paventava Heidegger.
Ma la capacità di formulare un discorso autonomo esige sempre una fatica, una disciplina, una ricerca che, stimolante e appassionante per gli spazi di libertà che apre, comporta una impegnativa disposizione della coscienza a lasciarsi interrogare e attraversare, per esempio, dal dubbio della propria imperfezione, e dunque dal desiderio di oltrepassare il limite delle proprie conoscenze, delle proprie appartenenze, persino dei propri gusti, per convenire in un paradigma aperto e inclusivo.
Il postmoderno, con cui si designa il nostro tempo, sarebbe caratterizzato proprio dal superamento di una modernità che, dal ’500 in poi, enunciava dei grandi racconti di comprensione della realtà, che pretendevano di essere universalmente validi e pertanto salvifici, in grado di additare un senso al vivere. Ma, a partire dal ’900, l’epoca del pensiero debole o postmoderno ha profondamente messo in dubbio la possibilità e credibilità dei grandi racconti – filosofici, metafisici, scientifici –, orientando il pensiero in una direzione ermeneutica, dove allo scetticismo si può sfuggire solo accettando il carattere situato, in certo qual modo relativo, ma non inutile o inattendibile, della propria conoscenza, intesa come prospettica.
Questa sfida è intellettuale e morale, perché richiede umiltà e disponibilità al dialogo, in una prospettiva che Papa Francesco chiamerebbe di conversazione con l’altro, su una base di sostanziale parità ontologica e gnoseologica, ove ogni coscienza è un po’ come un punto della circonferenza, da cui può guardare al centro, col quale tuttavia non coincide. Ecco allora che, in quest’ottica, diviene essenziale l’apporto dell’altro, della sua esperienza, della sua sensibilità, della sua cultura, della sua intelligenza, per integrare e arricchire la mia prospettiva in modo inclusivo. Ed ecco che un atteggiamento di charitas, cioè di accoglienza e valorizzazione dell’altro, diviene un modo di pensare dinamico ed empatico, che si contrappone al vecchio schema che, presupponendo il pieno possesso della verità da parte di qualcuno, intendeva solo trasmetterla o travasarla in chi ne fosse stato privo. Ancor oggi, del resto, l’integralismo religioso, nelle diverse confessioni, è in grande aumento in tutto il pianeta. Ciò è psicologicamente comprensibile, come via di fuga e ricerca di sicurezza interiore, ma tende a produrre l’illusoria convinzione di avere i copyright della verità, pensando ad essa come a qualcosa di proprietario, e perdendo così quella esperienza fondamentale che Gesù di Nazareth esprimeva nella nozione della universale paternità di Dio.
Raimon Panikkar, grande teologo aperto al dialogo interreligioso, ha elaborato la categoria di mythos fondativo, per designare quell’insieme di esperienze originarie che contrassegnano la vita di popoli, gruppi e individui, per cui nei primi anni di vita ciascuno assimila idee, suggestioni, suoni, profumi, immagini archetipiche che sono solo sue e di nessun altro, e che costituiranno un patrimonio primigenio di esperienza e di apertura all’essere che lo accompagneranno per tutta la vita. Per chi è educato in un contesto religioso, o civile, o politico, o estetico, è dunque inevitabile avere un retroterra mitico-culturale suo proprio che lo orienterà nella lettura e interpretazione del mondo, e che noi siamo chiamati a rispettare. E questo vale per le più disparate differenze culturali ed esistenziali che siamo di conseguenza invitati non già a tollerare, ma ad amare, proprio come voleva Panikkar, per il quale occorre appunto riconoscere come amabile il mythos fondativo dell’altro, quale premessa di ogni incontro possibile. Scrive il grande poeta spagnolo Antonio Machado in una celebre poesia: “La tua verità! No: la verità/ vieni con me a cercarla./ La tua, tientela”. Ancora una volta, la verità è inseparabile dalla comunione, e la charitas ne è l’universale modalità d’accesso.
(da Claudio Sottocornola, La fatica dell’intero. Il pensiero come arte dell’incontro, Oltre Edizioni, 2024, versione integrale pp. 15-20; già in “Missione Salute”, n.1, 2023)