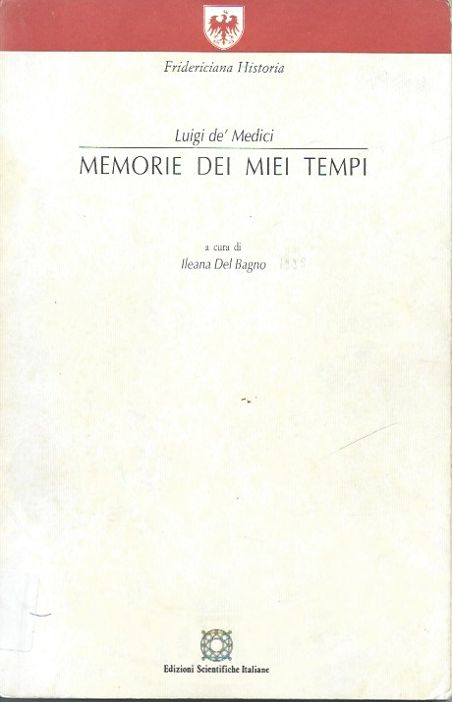DINA TORTOROLI
Don Luigi de’ Medici dei Principi d’Ottajano, alto funzionario del Regno di Napoli, è senza dubbio un personaggio degno di memoria.
Però, egli ebbe una carriera ministeriale talmente tempestosa da provocare un’estrema cautela in biografi e storici.
Il meno titubante è Nicola Nicolini, anche perché supera tutti “quanto a informazione documentaria”.
Nicolini è propenso a evidenziare che si “accumulò contro il Medici ogni sorta d’infamie”, mentre, “a fare vedere l’infondatezza delle accuse” (di giacobinismo) , basterebbe considerare “l’indole, la mentalità, i sentimenti politici e le abitudini di vita del Medici”.
Faccio quindi ricorso alla monografia del Nicolini, Luigi de Medici e il Giacobinismo napoletano (Firenze, Felice Le Monnier, 1935), per dimostrare che “temperamento” e abitudini di vita di Luigi de Medici si attagliano appieno al committente della Lettera ad Acton, come io ho ipotizzato:
– (pp. VIII-IX) «Luigi de Medici rappresenta forse l’eccezione più cospicua a quella che fu quasi generale condotta di vita politica nei napoletani di qualche levatura […] giacchè, originariamente illuminista e riformista dei più avanzati, e pertanto fulgida speranza della parte eletta della nazione, egli restò tale anche dopo che nel 1792 [anno in cui, il 21 settembre, in Francia, i deputati della Convention nationale votarono l’abolizione della Monarchia] la Corte mutò bruscamente cammino, e da quell’anno al 1795, pur senza staccarsi da essa, accarezzò il bel sogno di Gaetano Filangeri d’una rivoluzione pacifica, promossa non dal basso ma dall’alto, non dalla parte eletta della nazione contro la dinastia e la plebaglia, ma dalla dinastia medesima alleata con la parte eletta della nazione, e mirante a far progredire l’ancóra tanto arretrata Italia meridionale al medesimo livello delle più cólte e civili Nazioni dell’Europa».
– (p. 2) «Ambiziosissimo e fortemente attaccato alla sua casta e al suo paese, vedeva malvolentieri crescere di giorno in giorno il potere di uno straniero quale l’Acton, proprio presso quella Regina, della quale, mercè la sorella, marchesa di San Marco, egli era intimissimo».
– (pp. 11-13) «La sua attività di magistrato piaceva tanto alla Corte, che il 3 novembre del 1791 egli veniva nominato reggente della Gran Corte della Vicaria, ch’è quanto dire capo della polizia giudiziaria e politica del Regno di Napoli. [L’aver Luigi accettata la carica] è, a parer nostro, altra prova ch’egli serbasse immutato il concetto che una riforma politico-amministrativa del regno doveva scaturire ab intra e non ab extra: esser compiuta, cioè, dal Re e dai suoi ministri per loro iniziativa, e non sotto la pressione della pubblica opinione, nel valore della quale egli aveva più volte mostrato il più assoluto scetticismo. L’ardore con cui si pose all’opera è generalmente noto. L’apposizione di tabelle viarie alle strade, la numerazione progressiva delle case e delle botteghe, la pubblica illuminazione, i giudizi per direttissima dei colpevoli scoperti in flagranti, l’istituzione di una colonia penale nell’isola di Lampedusa: queste e altre cose, restate fino allora allo stato di meri desideri, divennero rapidamente, mercè sua, palpabile realtà. Senza dubbio, nel compierle, non solo col pieno consenso, anzi col plauso della Corte, egli mostrò una volta ancora la sua grande simpatia per la Francia “illuministica” degli ultimi tempi di Luigi XV e dei primi di Luigi XVI, dal momento che i nuovi regolamenti di polizia da lui introdotti in Napoli non furono se non un adattamento agli usi e costumi napoletani degli analoghi regolamenti introdotti già a Parigi dal luogotenente di polizia Sartines e poi dal suo successore Lenoir. Ma, d’altra parte, nulla prova meglio il nessun pensiero ch’egli avesse di porsi un giorno a capo d’una rivoluzione di tipo democratico e giacobinico quanto il dispregio mostrato da lui fin da allora, verso una facile popolarità. Si pensi, per non dire altro, agl’innumeri nemici che gli procacciarono in basso e in alto, da un lato, la tenacia con cui si diè a rimuovere dall’amministrazione della Vicarìa abusi d’ogni sorta, a cui una vita secolare aveva dato valore di consuetudini intangibili; dall’altro, il suo ritornello favorito che “le reali segreterie erano male organizzate, dacchè s’ingerivano in ciò che apparteneva ai tribunali”, e, pertanto, occorreva riformarle».
- (p. 136-137) Come s’è detto, agli inizi della rivoluzione francese, il Medici, più e meglio di qualsiasi napoletano in vista, rappresentava, nella Corte e nella pubblica opinione, il partito allora in voga, del riformismo, […]: quel partito, che, tra gli uomini della generazione precedente, aveva avuto tre propugnatori di risonanza europea, e che la stessa Corte, che si servì di loro per cariche amministrative, militari e politiche, usava vantare come le più belle glorie di Napoli: l’abate Galiani, morto nel 1787; Gaetano Filangeri, morto nel 1788; il marchese Domenico Caracciolo, morto nel 1789. Compagno già della regina Maria Carolina nella setta massonica, il Medici ne era uscito con lei dopo la famosa inchiesta del Pallante; come lei, pur divenendo poi fiero avversario dei liberi muratori e pur detestando i loro intenti rivoluzionari, ne aveva accolto il programma riformistico […]. E, come il suo riformismo aveva reso caro il Medici alla Regina, così il suo fare bonario e alla mano da gentiluomo napoletano del vecchio stampo, il suo amore per la celia e per il bon ton, finanche l’infiorare il suo linguaggio di realistiche espressioni vernacole, non potevano non renderlo assai accetto al Re. S’aggiungano la vivacità dell’ingegno, la rapidità dell’intuito, la grande capacità tecnica di magistrato e di funzionario e si spiega perfettamente come fin dai suoi primi passi il Medici sapesse rendersi indispensabile. Egli era il funzionario su cui si poteva contare in qualsiasi congiuntura, il cortigiano sempre gradito e benvoluto, l’uomo di fiducia assoluta, il factotum politico, per dir così, della Corte: onde non è da far le meraviglie, se, dopo essergli state affidate le prime inquisizioni politiche e la delicata missione calabrese, gli venisse conferita in età così giovanile [32 anni] la carica, spiccatamente politica, di reggente della Gran Corte della Vicarìa, e la pubblica opinione lo considerasse, accanto all’Acton e al principe di Caramanico , uno dei tre uomini più potenti del Regno. […] Sfortunatamente per il Medici, la sua assunzione alla carica coincise press’a poco con quel brusco mutamento d’indirizzo della Corte, già chiarito di sopra. Dal che, tra lui e gli altri uomini politici, che di quel mutamento erano stati i principali artefici e furono poi i principali sostenitori, un dissenso iniziale, destinato fatalmente a inasprirsi, fino a diventare guerra ad armi corte»
- (p. 139) «Egli procurò sempre di separare in se medesimo il funzionario dall’uomo politico. Il funzionario s’atteneva con la maggiore scrupolosità alle direttive del governo, ch’è quanto dire dell’Acton, e non soltanto negli affari amministrativi, […] ma anche in quelli politici, in cui il dissenso si venne facendo sempre più insanabile. L’uomo politico, invece, prese a fare all’Acton un’opposizione sempre più serrata, condotta nella sola guisa in cui potesse essere efficace in una città quale la Napoli della fine del Settecento e in un regime quale quello borbonico, vale a dire ponendo in rilievo, nei salotti e nella stessa Corte, ora con un’allusione velata, ora con uno di quei bon mots più micidiali talora d’un colpo di coltello, quanto c’era di ridicolo (ed era parecchio) nell’opera e nella persona medesima dell’avversario. In codesto lungo e lento lavorìo di demolizione che, se coronato dal successo, lo avrebbe condotto infallibilmente al ministero in luogo dell’Acton, non mancarono al Nostro alleati più o meno validi».
- (p. 141) Tanto impopolare, invece, quanto il Medici era popolare, l’Acton non aveva dalla sua né l’opinione pubblica, né le belle dame, né i salotti, né i circoli degli intellettuali, né, salvo taluni nemici personali del reggente (il generale Pignatelli, il marchese del Vasto e qualche altro), l’aristocrazia; ma aveva pure, in misura maggiore dell’avversario, la protezione personale della Regina, che, dopo d’aver gettato giù, da un piedestallo che sembrava infrangibile, il vecchio Tanucci, era saputa divenire ogni giorno più l’arbitra assoluta della cosa pubblica».
Coup de théâtre: mi sono imbattuta – con increscioso ritardo – in Memorie* autografe di Luigi de Medici, quindi ora è bene che prenda la parola lui, che alla Regina dedica un intero capitolo.
Lo intitola «Maria Carolina e il suo “impero”, e preavvisa:
- (p. 111) Or di questa donna […] quasi ad ogni pagina di questi commentarj dovrò far parola, non essendovi stato affare di pubblica o di privata ragione cui essa non abbia avuto parte. Ond’è che la sola e nuda narrazione sarà bastevole a formare giudizio de’ pregi e de’ difetti del suo animo e se bene o male della società, cui per volontà del Re suo marito ha preseduto, si abbia meritato. […] E il primo tratto di questo nascente femminile impero fu il tor di mezzo il marchese Tanucci [Primo Ministro], né altrimenti tale impero potea stabilirsi, né raffermarsi».
- (p. 119) «Or passando a ragionare del suo successore, dico che tosto che i congiurati contro Tanucci si credettero in porto per lo consentimento prestato dal Re di Spagna per la sua rimozione, fu tra loro la scelta del successore oggetto di contesa. I più eran per Caracciolo ambasciatore in Francia, uomo di squisito ingegno e di lettere più che bastevolmente fornito, ma coloro che usavano familiarmente colla Regina volevan che cadesse sul marchese della Sambuca nostro ministro a Vienna, e fu fama che ne fosse consultata Sua Maestà Cattolica, la quale tenendo Caracciolo per libero pensatore e poco religioso, diè preferenza all’altro».
(pp.120-121) «Era il marchese della Sambuca un gentiluomo siciliano della illustre famiglia de’ Bologna, quanto ricco di natali, altrettanto e d’ingegno e di beni di fortuna poverissimo; […] la povertà del suo ingegno ad ogni suo detto o fatto si vedeva ad occhio nudo e senza che fosse mestieri di diligente indagatore, onde ebbe per necessità a porsi in braccio de’ suoi uffiziali, che il guidavano come cieco per mano. Era allora tra noi una donna assai scaltra e degli affari di corte peritissima per esperienza acquistatane in Ispagna, intendo dire la principessa d’Aci [che] colse questo uomo nella sua rete e il prese a governare in tutti gli affari del suo ministero, e dessa fu che in su le prime gli facesse intendere che per reggersi nell’uffizio gli convenisse tenersi con la Regina collegato, né dipartirsi da’ suoi voleri e soprattutto di curare attentamente di non far cosa che seco lei non fosse stata avvisata. Così la somma delle cose nelle mani della Regina passò e per opera di Sambuca il Re permise ch’ella ai consigli pubblicamente intervenisse, né grazia da lì in poi fu fatta, né impiego alcuno fu dato, che per sua volontà».
- (pp. 122,125) «Siccome a coloro che fanno pubblici mali piace aver nome di promotori di grandi cose e nuove, Sambuca rivolse l’animo a tor riformagioni di governo, le quali avessero apparenza di comune utilità. […] Or… gli prese pensiero di riformar la real Marina, rendendola adatta a corseggiare contro de’ barbareschi, nel che se fosse egli ben riuscito gran nome si avrebbe acquistato».
- (p. 126) «Sambuca adunque rivolse l’animo a riordinar questo ramo e veduto che fra i nostri uffiziali alcun non vi fosse che per ingegno o per esperienza avesse onori per tanto peso, si appigliò al consiglio di far venir di fuori uno uffizial generale che adatto vi fosse, non presago dei mali che questo uomo far gli dovesse».
- (p. 127) «Or io vo ad entrare nel racconto di un’epoca della nostra istoria che dai nipoti non sarà certamente giammai dimenticata, conciosiache questo uffizial di marina fatto venir di fuori per far guerra ai barbareschi, quantunque affatto sfornito fosse e di lettere e di ingegno ebbe non però l’arte di porsi in mano la somma delle cose, e non fece col fatto che guerra alle nostre leggi e financo ai nostri usi e costumi, e tutto pose sossopra e l’ordin pubblico per modo sconvolse che se la rivoluzion di Francia non gli fosse servita di scusa presso de’ sciocchi de’ sommi mali, de’ quali ci ricoprì, la sua memoria non avrebbe per avventura alcun partegiano: dico alcuno conciosiache assai pochi sónovi che di questa scusa persuasi si siano, essendo opinione di tutti gli uomini saggi che anco senza questo estraordinario avvenimento la condizione nostra non sarebbe stata migliore; e qui non mi basta l’animo di pronunciare il nome di Giovanni Acton, che così chiamàvasi questo uffizial generale [di Toscana], qui da noi condotto [nel settembre del 1778] siccome quello di un uomo esoso ai buoni per gli cattivi ordini di governo che da noi introdusse. Siccome per lo corso di 26 anni ress’egli con assoluto volere la somma delle cose, non posso fare ammeno per lo istituto di queste memorie innanzi di far parola de’ sommi mali che ne ha fatti, di brevemente narrare chi si fosse e come fosse ritenuto meritevole degno di tanta dignità, nel che fare né seguirò l’opinion comune, che per odio di sua persona lungamente tra noi prevalse, ch’ei fosse uomo da nulla, e avventuriero di professione; né l’altra de’ suoi adulatori che da nobilissimi avi il diceva disceso, ma sì bene l’autorità del chiarissimo Ghibbon che di alcune memorie della sua vita, date alla luce dopo la sua morte, della famiglia Acton per occasione fa parola».
Il Medici riferisce quindi i dati fondamentali della vita di “Giovanni Acton”, da lui denominato “il distruttore delle nostre leggi”: brevi informazioni, ma non prive di giudizi sarcastici su quel “giovane povero e scaltro”, dal padre** inviato in Toscana “presso di un suo parente”, sul suo “lungo penare” per innalzarsi da guardia marina al grado di “comandante a capo delle potentissime squadre toscane, o sia di due meschine e povere fregatine”, e sulla sua “mal meritata fama” di “uomo di mare valentissimo”.
Infine, introduce pochissime righe, intitolandole «Cenni su ciò che sarebbe dovuto seguire».
Luigi de Medici evita, insomma, di riferire i “pericoli”*** da lui corsi a causa della “malignità” dei suoi avversari, perciò mi pare importante ritornare indietro e dare il giusto rilievo a quanto egli dichiara nella Prefazione:
- (pp. 31-32) «Essendo io stato testimonio di molti avvenimenti, i quali o per la loro grandezza o per l’eminente condizione delle persone che ne sono state a parte possono dar lume alla storia de’ nostri tempi, ho voluto conservarne la memoria in questi miei privati commentarj per servire di materiali a’ quei felici ingegni cui sarà dato di scriverla. Non è dunque per amor proprio, quasi io mi riputassi uomo di così alto affare d’aver fatto o detto cose degne d’essere a’ posteri tramandate, che abbia io posto mano a quest’opera, ma per solo studio, come io dissi, di dare alla istoria maggior lume di verità. […] Comunque però la cosa si sia, la storia sommo aiuto potrà averne e sommo giovamento: onde io non dubito che mi abbia ben meritato della mia patria con questo lavoro.
Due grandi difficoltà mi si sono fatte davanti tostoche ne concepj l’idea, dandomi scoragimento per distòrmene. Potrò dir tutto senza pericolo? Potrò ben anco nulla tacere? E in vero i tempi ne’ quali viviamo non sono adatti a questa specie di libertà per gli gravi pericoli ai quali si andrebbe incontro, ma dopo quell’ondeggiamento che suol essere in noi nelle risoluzioni di sommo momento, mi sono al più rischioso, ma più virtuoso partito appigliato di adempire ciecamente i doveri d’istorico, ond’è che dirò tutto e nulla tacerò e dividerò le pruove dalle cose che son per dire con quei gradi di verità che loro assegna la critica. […] Il mio lettore vedrà nei miei scritti, e sarà per avventura il solo pregio dell’opera, quel tenero amore per lo benessere de’ miei concittadini e per l’universale degli uomini, che ho sempre nudrito nel mio cuore acosto di non lievipericoli, che i pregiudizj comuni e talvolta l’altrui malignità mi ha fatto correre; e si vedrà un altro titolo di cui io mi pregio e vanto, e di cui assai pochi al par di me posson farselo, che se talora nelle luminose cariche da me esercitate non mi sia riuscito di fare il bene, siccome io mi era proposto, mi sia sempre con sommo studio adoperato a diminuire i pubblici mali».
———
*Luigi de Medici, Alcune cose degne di memoria avvenute a’ tempi miei e messe da me per iscritto l’anno 1810 (manoscritto, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, fondo Archivio Borbone; in: Luigi de Medici, Memorie dei miei tempi, a cura di Ileana del Bagno, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998).
**Il padre di John Acton – “inglese di nascita e medico di professione” – “circa l’anno 1734” fu “fatto venire a Besançon” dallo storico inglese Gibbon, che durante un viaggio in Francia si era gravemente ammalato. A Besançon, il medico si era “invaghito” di una fanciulla che aveva poi sposato. Quindi, a Besançon “aveva fissato la sua dimora e di sua arte vi era vissuto”.
***Le angosciose disavventure del Medici ebbero inizio alla fine del marzo 1794, durante l’inchiesta sulla “maledetta setta giacobinica”, terrore della regina Maria Carolina, (sorella – ricordiamolo – della regina Maria Antonietta, ghigliottinata a Parigi il 16 ottobre 1793!). A Corte si vociferava di un’imminente denuncia di Annibale Giordano (il giovane e brillante matematico, dal Medici ospitato per più di dieci anni nel proprio palazzo di Napoli, per favorirne gli studi), inerente il coinvolgimento – niente meno – del Reggente della Vicarìa nella congiura giacobinica contro lo Stato. Luigi de Medici – “dignitosamente ricorrendo alla via gerarchica” – chiese al Sovrano di poter dimostrare la propria innocenza, a costo di essere “sospeso” dalla propria carica e di essere “chiuso in un Castello”, e durante il Gran Consiglio del 28 febbraio 1795, il Re mostrò apprezzamento per il gesto del Reggente e sembrò assecondarne le richieste, decretandone l’arreso.
Però, immediatamente dopo, si venne a creare una situazione inimmaginabile e scandalosa: la sera stessa del 28 febbraio, don Luigi de Medici si vide trasformato in “preso di Stato”, e, come tale, “imprigionato” nel Castello di Gaeta, dove fu lasciato in attesa del suo Costituto per quasi trentadue mesi, in una clausura totale.