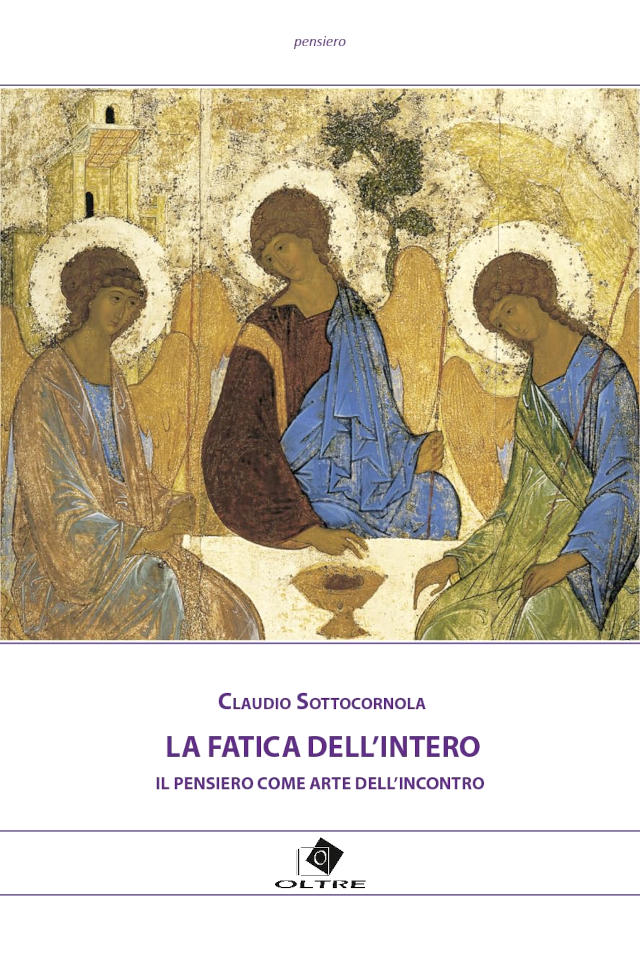CLAUDIO SOTTOCORNOLA
“Ho trascorso la mia vita ad Istanbul, sulla riva europea, nelle case che si affacciavano sull’altra riva, l’Asia. Stare vicino all’acqua, guardando la riva di fronte, l’altro continente, mi ricordava sempre il mio posto nel mondo, ed era un bene. E poi, un giorno, è stato costruito un ponte che collegava le due rive del Bosforo. Quando sono salito sul ponte e ho guardato il panorama, ho capito che era ancora meglio, ancora più bello vedere le due rive assieme. Ho capito che il meglio era essere un ponte fra le due rive. Rivolgersi alle due rive senza appartenere”. Questa affermazione del grande scrittore e saggista turco Orhan Pamuk, nel saggio “Istanbul” del 2003, appare felicemente propedeutica ad avvicinare il tema del difficile e complesso rapporto fra relazione e identità, simbolicamente rappresentate dalle due immagini del ponte, che unisce, e delle case sulla riva che, con i loro muri, custodiscono e proteggono.
È tuttavia innegabile che proprio la nostra epoca, così ricca di possibilità di comunicazione e di movimento, sia anche attraversata da dolorosissime contraddizioni e tragedie collettive, da un lato connesse ai drammatici fenomeni migratori in atto, con naufragi e morti in mare, segregazioni e torture in Paesi di passaggio, sviluppo di una criminalità organizzata nella gestione del fenomeno, difficoltà nella ricezione e integrazione dei profughi, ma anche al progressivo venir meno, per l’opulenta gioventù occidentale, di ogni riferimento strutturante dell’identità e dell’orientamento al valore, con i conseguenti fenomeni di sballo, uso di droghe, dipendenze digitali, stragi del sabato sera, pestaggi fra gang nelle grandi periferie urbane, disadattamento e disturbi psichiatrici, alimentari e autolesionistici in testa.
Perché dunque questo mondo attraversato da innumerevoli ponti ci fa tuttavia soffrire e ci intristisce? Bauman ha coniato la celebre formula, ormai abusata, di rapporti liquidi, per definire la condizione di incertezza e transitorietà che caratterizza le relazioni umane entro l’attuale civiltà tardo-capitalistica, ove diventano insussistenti i rapporti di vicinato, di amicizia e parentela, persino familiari. L’antropologo francese Marc Augé ha invece introdotto nel 1992 il termine non-luogo nel titolo di un suo libro, a segnalare la presenza di spazi non identitari, come autostrade, tangenziali, aeroporti, centri commerciali, mezzi di trasporto, sale d’aspetto, in cui gli individui si sfiorano senza entrare in relazione, mossi dal desiderio di consumo, di efficienza o di evasione.
L’uomo è però un animale simbolico, ed ha bisogno, per vivere, di giocare all’altezza di tale status, costituendosi in società i cui vincoli di appartenenza vengono cementati da valori condivisi, espressi in forme culturali, linguistiche, relazionali dotate di una certa stabilità e riconoscibilità e, quando ciò viene meno, se ne ha una condizione di banale promiscuità dove la vicinanza fisica, divenuta meramente biologica, produce perlopiù disagio, conflitto o indifferenza, mancando quella tessitura invisibile ma efficace che lega gli umani a qualcosa che trascende il loro io empirico e li trasforma in una comunità di persone motivate e attraversate dalla speranza.
Se piante e animali hanno un loro setting per il quale, ad esempio, un determinato insetto o un fiore esprimono modalità percettive delimitate, che permettono loro di non subire interferenze, ad esempio acustiche o visive, d’intralcio alla loro stessa sopravvivenza, anche gli esseri umani sono orientati ad una rigorosa selezione dei molteplici input che ricevono dall’esterno, da cui sarebbero altrimenti sopraffatti. Tutto ciò costituisce una sorta di barriera o muro che li protegge dai pericoli della disgregazione della personalità e dal rischio di vedere minacciata la propria conservazione. Essi dunque possono trascendere sé stessi solo riconoscendo la propria situazionalità, ovvero uno spazio-tempo carico sì di opportunità, ma anche di limiti da accettare in ordine al loro stesso superamento, che sarà sempre prospettico, restituendo una forma del mondo e non un’altra, nell’ambito di quella libertà situata che è dialettica fra universalità e singolarità, categoria tanto amata dal grande filosofo Søren Kierkegaard, che vi coglie lo specifico dell’umano.
Spesso si identifica il Medioevo con l’immagine iconica del castello, caratterizzato da imponenti mura con torrioni merlati, che ne difendevano gli abitanti dai potenziali nemici esterni. Ognuno vede come, in tale scenario, prevaleva l’idea di tutelare e difendere l’identità, la sicurezza, l’appartenenza, rispetto ai rischi della relazione con la dimensione dell’ignoto, potenzialmente pericoloso e letale. Nell’America novecentesca, al contrario, si è invece affermato il mito della trasparenza garantita dal vetro, che ha realizzato perimetri di uffici, case, grattacieli, luoghi pubblici, ristoranti e centri commerciali, all’insegna del non c’è nulla da nascondere, inaugurando una sorta di promiscuità visivo-abitativa che ha abbattuto i confini, la sensazione di pericolo connessa, e lo stesso concetto di privacy sino ai nostri giorni, ove il fenomeno viene non a caso reiterato e moltiplicato nell’invadente trasparenza del web come dei reality televisivi. Insomma, non temiamo più lo sguardo dell’altro, e non avvertiamo più quel senso del pudore rispetto ad esso che – come ha ampiamente illustrato Jean-Paul Sartre – è invece essenziale alla nostra stessa coscienza di esseri non totalmente oggettivabili da un corpo, ma piuttosto attraversati da una dimensione ulteriore ad esso irriducibile. Abbiamo dunque smarrito il senso di una interiorità che vada intimamente protetta, salvaguardata, alimentata nella sua alterità al mondo e alle cose, che pertanto rischiano di inghiottirla, trasformandola in cosa fra le cose, oggettualità inerte pronta allo scambio, forse, con altre merci. L’incontro invece non è mai demagogia dell’indifferenziato, ma epifania dell’altro e del sé, nella irriducibile libertà che ne permette la relazione virtuosa come frutto di una scelta, e dunque di una intenzione creativa, e questa presuppone sempre un’autoralità, che solo l’inabitare nelle profondità della propria coscienza rende pienamente possibile.
Ecco perché talvolta, come evoca il sociologo Vito Teti in “Pietre di pane” (Quodlibet, 2011), a proposito del tema della restanza, ispirandosi alla sua terra di Calabria, oggetto di abbandoni e spopolamento: “Restare… non è stata per tanti, una scorciatoia, un atto di pigrizia, una scelta di comodità; restare è stata un’avventura, un atto di incoscienza e, forse, di prodezza, una fatica e un dolore”. E dunque – in tale ottica – l’avventura del restare esprime una forma più “estrema del viaggiare”, un movimento più radicale ed eroico, totalmente in perdita perché alieno dalle lusinghe del nuovo, e perduto nella escavazione di una trascendenza cercata in profondità, più che nella forma dell’estensione.
Oggi però nessuno sembra più accettare un radicamento che comporti rinunce e sacrifici, ma permetta di salvare la parte profonda della propria anima, il proprio vissuto originario, e, con esso, il proprio mondo. Nella dialettica fra muro e ponte hanno forse perso entrambi, se il ponte è diventato un luogo di fuga piuttosto che di transito e di incontro, e il muro una prigione piuttosto che il perimetro di una casa e di una città accoglienti.
Occorre allora riscoprire la bellezza dell’abitare, come convergenza di un vissuto e di una storia. Come luogo dell’anima. E abitare in sé è il prerequisito essenziale per sognare e cercare l’incontro con l’altro, il diverso, l’ignoto e, qualora se ne presenti l’occasione, anche per attraversare quel ponte che unisce, e diviene il luogo del passaggio e dell’esodo verso l’alterità, piuttosto che l’ennesima occasione di fuga nei territori dell’indistinzione e della promiscuità, di cui si accontentano i più.
(da Claudio Sottocornola, La fatica dell’intero. Il pensiero come arte dell’incontro, Oltre Edizioni, 2024, versione integrale pp. 89-99; già in “Missione Salute”, n.4, 2024)