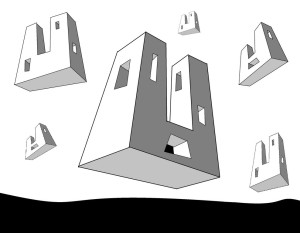ATTILIO IANNIELLO. Nella Stanza della Segnatura all’interno dei Palazzi Vaticani vi è il grande affresco di Raffaello Sanzio pitturato tra il 1509 e il 1510 ed intitolato “La Scuola di Atene”. Al centro del dipinto emergono i due grandi protagonisti della filosofia greca: Platone che tiene sotto il braccio sinistro il suo Timeo ed Aristotele che tiene nella mano sinistra la sua Etica. I due personaggi hanno lo sguardo rivolto l’uno verso l’altro e la posizione delle loro braccia destre sembrano simboli di due piani diversi, verticale e orizzontale, ma tra loro complementari, come se questo particolare dell’affresco fosse una rappresentazione dell’ideale umanistico di Pico della Mirandola: la complementarietà tra fede e spiritualità (rappresentate da Platone, che ha l’indice puntato verso il cielo) e la scienza e l’ordinamento sociale (rappresentati da Aristotele, che protende il braccio in avanti orizzontalmente).
Ma non è questa la sede per perdersi nell’eventuale decifrazione di simboli su cui vi è una vastissima letteratura. La nostra attenzione è piuttosto attratta dal libro che Raffaello Sanzio mette nelle mani di Aristotele: l’Etica.
L’artista urbinate ci suggerisce che questo testo aristotelico era tenuto in gran conto soprattutto in quel periodo culturale rinascimentale definito dagli storici umanesimo civile. Si voleva, semplificando al massimo il discorso, edificare una nuova polis, una nuova civitas ridando linfa alla politica intesa come ricerca del bene comune.
Nell’Etica Nicomachea (IV secolo a. C.) di Aristotele si può leggere, per esempio:
Se vi è un fine delle azioni da noi compiute… è evidente che questo fine deve essere il bene, anzi il bene supremo. E non è forse vero che anche per la vita la conoscenza del bene ha un grande peso, e che noi, se, come arcieri, abbiamo un bersaglio, siamo meglio in grado di raggiungere ciò che dobbiamo? Se è così, bisogna cercar di determinare, almeno in abbozzo, che cosa mai esso sia e di quale delle scienze o delle capacità dia l’oggetto. Si ammetterà che appartiene alla scienza più importante, cioè a quella che è architettonica in massimo grado. Tale è, manifestamente, la politica. Infatti, è questa che stabilisce quali scienze è necessario coltivare nelle città e quali ciascuna classe di cittadini deve apprendere, e fino a che punto; e vediamo che anche le più apprezzate capacità, come, per esempio, strategia, economia, retorica, sono subordinate ad essa. E poiché è essa che si serve di tutte le altre scienze e che stabilisce, inoltre, per legge che cosa si deve fare, e da quali azioni ci si deve astenere, il suo fine abbraccerà i fini delle altre, cosicché sarà questo il bene per l’uomo. Infatti, se anche il bene è il medesimo per il singolo e per la città, è manifestamente qualcosa di più grande e di più perfetto perseguire e salvaguardare quello della città; infatti ci si può, sì, contentare del bene di un solo individuo, ma è più bello e più divino il bene di un popolo, cioè di intere città. La nostra ricerca mira appunto a questo, dal momento che è una ricerca politica. (Et. Nic. I, 2)[1]
E nella rinascimentale Toscana dei Medici la lezione aristotelica veniva attualizzata da intellettuali quali Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti, Matteo Palmieri, mentre nel Napoletano operava Giovanni Pontano.
Ci basti una frase di Leonardo Bruni per entrare nel clima di quel fecondo periodo storico:
se è ottima cosa dare la felicità ad uno solo, quanto sarà più bello conquistarla a tutto uno Stato.[2]
La stagione dell’umanesimo civile, degli intellettuali che riflettevano su quella che potremmo definire “felicità pubblica”, non durò a lungo; già nella seconda metà del XV secolo iniziava ad esaurirsi parallelamente ad un certo affermarsi di signorie, principati e monarchie assolute che davano vita a forme di governo autoritarie. La stagione dell’umanesimo civile, pur conclusa, lasciava sotto traccia nella storia sociale il desiderio di una “città felice”, immagine questa che compare infatti in alcuni titoli di scritti cinquecenteschi (es. la “Città felice” di Francesco Patrizi del 1553), e nella numerosa letteratura utopistica dei secoli seguenti.
In effetti l’immaginare luoghi dove ogni contraddizione del vivere civile cessava e tutto si svolgeva all’insegna dell’armonia tra gli uomini era, e sarà, segno della distanza tra ciò che la realtà sociale è e ciò che dovrebbe essere.
Entra in gioco in questo immaginario utopistico che affascinava, e affascina, molti individui la speranza del possibile cambiamento.
Si attribuisce ad Agostino di Ippona (IV secolo) la seguente frase:
La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per le cose viste che non vanno e il coraggio per cambiarle.
La speranza, sappiamo, è la seconda delle virtù teologali: nasce dalla fede, dalla fiducia nelle promesse di Dio e conduce alla carità, all’amore che include la perfetta giustizia. Questo caposaldo del pensiero cristiano è stato ribadito in anni recenti dal papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe salvi, un interessante documento pontificio sulla speranza, appunto, promulgato il 30 novembre 2007.
In tale enciclica il rapporto speranza-coraggio appare tre volte:
Solo la grande speranza-certezza che, nonostante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore e, grazie ad esso, hanno per esso un senso e un’importanza, solo una tale speranza può in quel caso dare ancora il coraggio di operare e di proseguire. (Spe salvi, 35)
Così, per un verso, dal nostro operare scaturisce speranza per noi e per gli altri; allo stesso tempo, però, è la grande speranza poggiante sulle promesse di Dio che, nei momenti buoni come in quelli cattivi, ci dà coraggio e orienta il nostro agire. (Spe salvi, 35)
Con la fede nell’esistenza di questo potere, è emersa nella storia la speranza della guarigione del mondo. Ma si tratta, appunto, di speranza e non ancora di compimento; speranza che ci dà il coraggio di metterci dalla parte del bene anche là dove la cosa sembra senza speranza (Spe salvi, 36)
Soren Kierkegaard, filosofo danese del XIX secolo, affermava che la speranza «è passione per ciò che è possibile» ed a lui faceva eco Roger Garaudy, filosofo francese del XX secolo, marxista e convertito all’Islam, il quale sottolineava che la speranza «è anticipazione militante dell’avvenire».
Ma il pensatore del XX secolo che ha dedicato più spazio alla speranza nelle sue riflessioni filosofiche e politiche è il marxista Ernst Bloch che pubblica negli anni Cinquanta il suo maggior lavoro teorico “Il principio Speranza”, lavoro che lo farà espellere dall’insegnamento presso l’Università di Lipsia e che lo farà anche fuggire dalla Germania orientale, in quegli anni ancora sotto il dominio dell’ortodossia comunista sovietica, per evitare ulteriori censure al suo pensiero.
Ernst Bloch supera l’interpretazione engheliana e leninista del pensiero di Marx giudicandola troppo “positivista” e soprattutto riduttiva rispetto alla dimensione utopistica del realismo marxiano.
L’uomo pensato da Marx, secondo Bloch, non è solamente un homo oeconomicus, ma è nel mondo per far brillare la “stella utopica” nelle cose e nella storia. Quest’ultima è caratterizzata da una tensione dinamica verso il “non ancora”, verso il completamento del presente. Motore di questa dinamica tensione è la “Speranza” dell’uomo. Nella lunga storia dell’umanità gli individui si sono sempre trovati in uno stato di alienazione, perché, come l’universo di cui fanno parte, sono essenzialmente incompiuti, non realizzati. La Speranza muove gli uomini verso la “patria della identità” dove l’individuo diviene “essenzialmente uno” con se stesso, con gli altri, con la natura. È, per Bloch, la realizzazione del comunismo pensato, sognato, da Marx quando dichiarava che la filosofia non aveva il compito di contemplare il mondo ma di trasformarlo in un futuro pienamente umano.[3]
Il pensiero di Bloch (da alcuni storici definito “marxismo esoterico”) stimolava una rinnovata attenzione verso la Speranza da parte di alcuni teologi, in particolare del teologo protestante Jürgen Moltmann, che pubblicò nel 1964 “La Teologia della Speranza”, opera che aggiungeva una dimensione teista ed ultramondana all’utopia atea ed intramondana dell’autore de “Il principio Speranza.
Anche oggi vale la pena di pensare utopie possibili, di raccontare le piccole utopie quotidiane che crescono e maturano intorno a noi. In “Margutte” vogliamo dare spazio anche a molte delle forme di concretizzazione della speranza e dell’utopia possibile come scenari di poetica incarnata.
Uno slogan iniziale del World Social Forum diceva: «Armati di sogni siamo invincibili». Che i sogni in questo nostro stanco Occidente nascano da cristiani, laici o socialisti poco importa; l’importante che siano per l’uomo, per il bene comune universale.
Attilio Ianniello
(immagine: Lorenzo Barberis, “I Castelli dell’Utopia”, 2013)
[1] Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, Milano, 1979, pp. 84-85.
[2] La frase di L. Bruni è citata in Bruni Luigino, Zamagni Stefano, Economia civile, Bologna, 2012, pag. 54.
[3] Cfr. Bonifazi Duilio, Alici Luigi, Il pensiero del Novecento, Brescia, 1989, pp. 97-103.