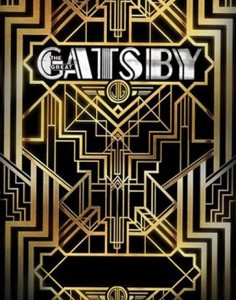LORENZO BARBERIS.
“Doveva continuare l’opera del Padre (Dio), mettendosi al servizio di una bellezza vistosa, volgare, da prostituta.” (Il progetto di vita di Gatsby, p. 122, e il progetto di adattamento di Luhrmann).
(qui la traduzione originale di Margutte dell’incipit dell’opera).
Verificare la fedeltà o meno di un’opera cinematografica rispetto al testo originale di riferimento ha ovviamente il senso di un puro gioco letterario: e tuttavia su un sito di letteratura ed altro, come questo, mi pare un gioco che valga la pena giocare.
Soprattutto perché “Il Grande Gatsby” recentemente trasposto da Baz Luhrmann al cinema viene in qualche modo a chiudere quella che potremmo definire una infedele trilogia della Decadenza.
L’australiano Luhrmann, classe ‘62, aveva esordito a teatro negli anni ‘80 con una Boheme di Puccini traslata negli anni ‘50; il successo viene però col cinema, nel 1996, e il suo “Romeo+Juliet”, già con Di Caprio, dove l’autore elabora una versione pulp del capolavoro shakespeariano.
La scelta di Luhrmann è qui per una curiosa fedeltà infedele, dove il testo shakespeariano è formalmente mantenuto alla lettera, mentre la rilettura radicale avviene per tramite di una radicale modernizzazione che guarda alla Pulp Fiction tarantiniana di moda allora.
Gli anni 2000 di Luhrmann sono invece segnati dal musical “Moulin Rouge!” (2001), altro grande successo che parimenti riscrive l’archetipo della Boheme cara all’autore. Tuttavia il fatto che non vi sia un riferimento preciso a un testo di partenza depotenzia molto, nei fatti, il gioco della dissacrazione che rendeva interessante l’esperimento shakespeariano.
Il recente “Grande Gatsby” si pone su una linea mediana tra il copione teatrale da finger di mettere in scena con fedeltà letterale (1996) e il libero canovaccio di suggestioni da interpretare (2001). Abbiamo infatti un libro, e nuovamente un caposaldo della tradizione culturale anglosassone: come Shakespeare era un intoccabile della letteratura inglese, così Fitzgerald ha analoga funzione per quella americana.
La dissacrazione di Gatsby messa in scena da Luhrmann è quindi particolarmente gustosa.
Di Caprio ritorna e si rivela un Gatsby potenzialmente credibile, ma di cui l’elemento gangsteristico, invece di esser dissimulato, non solo è esaltato (e già questo produce un rovesciamento estetico intenzionale e paradigmatico), ma è attualizzato con una New York proibizionista in mano a gangsta rapper, rave party invece di cene di gala, e adrenaliniche corse in macchina alla Need For Speed, invece delle lamiere accartocciate già al termine della prima festa (p. 71 dell’edizione dei Miti Mondadori del 1996: è Occhi di Gufo l’automobilista incidentato, l’unico altro – altra differenza – che presenzierà ai funerali di Gatsby).
Se in R+J l’attualizzazione era un tradimento palese, pistole per spade e così via, se nel Mulino Rosso si appiattiva in un banale anacronismo medio da cinematografia hollywoodiana, in GG Luhrmann raggiunge il sublime nella sua capacità di irritare il pubblico midcult.
Romeo che svuota un caricatore con la pistola impugnata trasversale era un gioco troppo palese, e troppo vicino all’apogeo tarantiniano, qui invece si ottiene lo stesso effetto fingendo di riprodurre comunque il 1922, facendo scattare una trappola culturale.
Però il gioco più proprio di Luhrmann non può non incontrarsi col gioco di ogni adattamento, quello di una selezione, di una riduzione del testo di partenza che non può in questo caso mancare di appannare la perfezione del gioco del regista.
Se in R+J il gioco era perfetto, il prestigiatore poteva irridere lo spettatore dicendo: “Vedete? Non ho fatto altro che trasporre il testo, parola per parola!”, qui l’autore deve prendersi la responsabilità dei tagli che opera, specie quando non vi sono evidenti ragioni di brevità.
A parte la specifica resa estetica, Gatsby è la figura per paradosso meno tradita tra quelle importanti nel romanzo. Il suo essere di fondo un gangster, cosa che nel romanzo è celata, nell’adattamento è palesata fin da subito. Lo spettatore low brow, che giunge vergine all’incontro, probabilmente ha bisogno che questa sua dimensione gli sia palesata; lo spettatore high brow, si spera, ha già letto il romanzo, conosce già il confronto finale in cui Buchanan rivela come Gatsby non abbia solo speculato coi soldi dei mafiosi, ma ci abbia fatto del contrabbando insieme (differenza cruciale per il puritanesimo calvinista americano); e quindi si può divertire nella variazione sul tema.
Al limite, gli si poteva evitare di far perdere le staffe di fronte alle osservazioni di Buchanan (p. 164), dato che nel libro è proprio la sua studiata freddezza davanti agli attacchi a farlo apparire un gangster, qualcuno che poteva aver già ucciso un uomo; non il contrario.
La figura più edulcorata, e contro motivazione, appare invece quella di Daisy. Già quando il fedifrago marito Buchanan si scaglia contro l’ascesa delle razze di colore (citando il libro di Stoddard, reso Goddard in film e romanzo), mormora “Dobbiamo sterminarle” ammiccando con violenza (p. 21) nel romanzo; appare infastidita nella trasposizione filmica. Il primo di molti tradimenti, che lasceremo al lettore di analizzare, se vorrà, volti a rendere Daisy una figura quasi romantica, rispetto alla nichilistica e distruttiva ereditiera che invece è.
La scena finale della presunta telefonata di lei a Gatsby (è Nick, invece, a chiamare) è spuria, ma di una divertente crudeltà del regista contro il suo personaggio; così come spurio è che Daisy si neghi al telefono a Nick: per quanto ne sappiamo, è davvero partita dalla città in totale indifferenza. E la bambina non appare, come uno spettro etereo, a turbare il sogno di Gatsby, cancellare il passato (p. 144).
Ma l’omissione definitiva è quella di un rigo appena, sul finale: quando il povero Gatsby racconta a Nick lo svolgimento dell’incidente fatale.
“Bè, Daisy ha prima sterzato verso l’altra macchina per scansare la donna, poi ha perso la testa e ha sterzato di nuovo.” (p. 133).
Non è chiaro se quello di Daisy sia un vero omicidio volontario o una vera perdita del controllo. Certo è che, dato che il marito Tom Buchanan, simmetricamente, spingerà il vedovo ad assassinare Gatsby, che si prenderà la colpa al posto di Daisy, viene più di un sospetto al proposito.
Fitzgerald, giustamente perfido, non ci dice nulla. “Poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno.”, come al solito.
Ma Nick, in fondo, ci suggerisce che “erano gente sbadata, Tom e Daisy: sfracellavano cose e persone, e poi si ritiravano nel loro denaro…” (p. 218). Intenzionale lui, intenzionale lei, verrebbe di dire.
Non è, quindi, l’elisione in sé a creare problema: ma l’elisione di qualcosa che avrebbe rafforzato la lettura neo-cinica di Gatsby, invece di lasciare un alone di addolcimento sulla sua relazione con Daisy, fino ad avvicinarla alla Love Story convenzionale.
Ma dalla decadente Trilogia del Tradimento Artistico non ci si poteva forse aspettare niente di diverso.